RENZO FRANCABANDERA | Teatro Grande a Brescia. Stucchi dorati. Scena aperta mentre il pubblico entra in sala. Un gruppo di attori si muove silenzioso intorno ad una grande statua animale. Suono di campanacci. A fare da fondale un sipario slavato, che ha perso la tinta rossa a favore di un pallido color carne: un drappo caravaggesco passato per le mani di Alberto Burri, tali da provocare ampie sdruciture e consunzioni.
Leggermente asimmetrico rispetto al centro della scena, sulla sinistra domina sul palco una possente scultura di carattere iperrealista, raffigurante i corpi moribondi di due o tre cavalli, a gambe aperte e con la pancia rivolta agli spettatori, con il collo reclinato verso terra e a cui verranno bendati gli occhi con uno straccio, quasi a non guardare la loro esecuzione. Attorno a questo possente eyecatcher si muovono i nove danzatori e performer che Alain Platel ha scelto per Nicht schlafen, evocazione tragica di un’imminente fine del consesso umano, piegato e piagato dalle sue stesse miserie, dalle liti per impadronirsi dei suoi propri inutili stracci.

I nove sono figure già incontrate nelle recenti creazioni di Platel, e qui ciascuno porta il suo codice di movimento. Riconosciamo, ad esempio, le due presenze di origine africana del brevilineo e magnetico Russell Tshiebua, e dell’altissimo e più esile Bule Mpanya, già incontrati nel bellissimo Coup fatal, visto in Italia a Bologna nel 2014 a Vie Festival: il Guardian li definì i “dandy di Kinshasa”, ed in quello spettacolo era assistente alla direzione artistica anche Romain Guion, qui in scena, insieme ad altri sei danzatori di origine arabo-europea, uno solo dei quali donna, Bérengère Bodin (anche lei in Italia con Platel per Torinodanza 2014, con Tauberbach. Allora come ora danzando con Elie Tass). Fra i nove anche il siciliano Dario Rigaglia.
Ma per questa nuova creazione, Platel ha selezionato artisti che hanno già lavorato al suo fianco anche fuori dal palcoscenico, come Steven Prengels (direzione musicale), Hildegard De Vuyst (drammaturgia) e Dorine Demuynck (costumi).
Nicht schlafen (non dormire) parte dall’ispirazione non solo musicale dell’opera di Gustav Mahler, ma anche dalla sua biografia, dal tempo e dai luoghi in cui ha vissuto.
Appena iniziato lo spettacolo i nove iniziano una strenua lotta che li riduce alla quasi nudità, con i vestiti fatti a brandelli. Se ne rivestiranno, in modo miserabile, in un mondo che abiteranno da straccioni fino alla fine, delineando u’ antropologia pre o postbellica non importa ma in cui il valore è la sopraffazione, l’incomunicabilità, l’ineluttabilità del confronto violento che non lascia spazio ad altro, e su cui si adagia per contrappunto, è proprio il caso di dirlo l’Adagietto della Sinfonia n 5 per i suoi 10 minuti di durata, con la stessa filosofia estetica con cui Ford Coppola aprì Apocalypse now con i larghi e, tutto sommato calmi, suoni dell’organo Hammond di The End dei Doors. Il riferimento è infatti certamente ai problematici anni del Ventesimo secolo che portarono alle grandi crisi e tragedie delle due guerre mondiali, ma anche al nostro tempo, che pare maturare nell’aria una grande e imminente catastrofe di cui siamo tutti consapevoli ma che attendiamo con ineluttabile fatalità. Il mondo di bestie al macello trova evocazione anche qui nella figura del cavallo, e rimanda all’immaginario della Guernica di Picasso, dove le vittime sono gli uomini (e ancor prima, negli studi, il toro in alto a sinistra), ma a spiccare e a catturare l’occhio è il cavallo, con i suoi occhi sgranati.

Nella creazione di Platel dal forte impatto drammatico, domina un cromatismo omogeneo che grazie ai corpi nudi trasmette un’idea quasi bicromia senza esserlo, intensificata dall’assenza di altri elementi se non i corpi degli esseri umani e il complesso statuario, che riverbera nei visi sfigurati dalla progressiva stanchezza dei danzatori, chiamati ad una prova di energia, di racconto della nobiltà e fierezza dell’uomo piegate alla brutalità della guerra. Seguiranno per tutto lo spettacolo trasfigurazioni di momenti di pietà (altro tema caro a Platel) in un contesto drammaturgico in cui il regresso della società rimane palese e inarrestabile, con un rimando costante fra composizione coreografica e installazione bestiale. Notevoli in questo anche gli altri performer, David Le Borgne, Ido Batash, Samir M’Kirech, con il primo a fare davvero da cavallo e gli altri due a realizzare un complesso sistema di movimenti scenici di cui sono comunque parte sempre tutti, sistema che tesse una trama di inarrestabile caos, che arriva finanche in platea nel finale e che persino quando diventa caos calmo comunica un senso di inquietudine assoluta.

Un complesso di simboli coreografici perfetto quindi, quello di Platel, per esprimere le terribili conseguenze generate dal conflitto ma ancor di più dell’attesa di questo momento, dove rimane potente, per contrasto, l’ancestralità africana dei due performer Mpanya e Tshiebua che ad un certo punto intonano canti tradizionali. Il cavallo agonizzante durante la loro frenetica danza con le cavigliere africane indosso sembra richiamare quasi il destino biologico delle specie viventi, quella luce violenta e inesorabile della savana che travolge la notte fonda dell’uomo, quasi a voler spiegare la brutalità come elemento inscindibile dalla vita, su cui però la ragione dell’essere vivente non riesce ad avere il sopravvento.
La visione dello spettacolo, sconsigliata ai minori di 14 anni, trasmette, con le sue coreografie volutamente imperfette, apparentemente disordinate, una sensazione di fragilità della nostra forza di volontà, ci lascia con il fiato ansimante del cavallo all’ultimo respiro e, come il protagonista di The Revenant, cerchiamo riparo nella carcassa calda della bestia che vediamo morta ma di cui conserviamo nelle orecchie il respiro degli ultimi attimi. Che è forse quello che Platel vuole forse raccontare.
Nicht schlafen
Direzione Alain Platel
Composizione e direzione musicale Steven Prengels
Creazione e performance Bérengere Bodin, Boule Mpanya, Dario Rigaglia, David Le Borgne, Elie Tass, Ido Batash, Romain Guion, Russell Tshiebua, Samir M’Kirech
Drammaturgia Hildegard De Vuyst
Assistenza artistica Quan Bui Ngoc
Assistenza alla Direzione Steve De Schepper
Scene Berlinde De Bruyckere
Luci Carlo Bourguignon
Suoni Bartold Uyttersprot
Costumi Dorine Demuynck
Direttore di palcoscenico Wim Van de Cappelle
Fotografia Chris Van der Burght
Direttore di produzione Valerie Desmet
Tour manager Steve De Schepper
Produzione les ballets C de la B
Coproduzione Ruhrtriennale, La Bâtie-Festival de Genève, TorinoDanza, la Biennale de Lyon, L’Opéra de Lil-le, Kampnagel Hamburg, MC93 Bobigny Paris, Holland Festival, Ludwigsburger Schlossfestspiele, NTGent, Brisbane Festival
Distribuzione Frans Brood Productions
Con la collaborazione di: Città di Ghent, Provincia delle Fiandre Orientali, Autorità Fiamminghe



 ALBERTO CORBA | Black Mirror è la ormai celebre serie antologica inglese, di genere Sci-fi, ideata da Charlie Broocker e prodotta da Endemol e Channel 4.
ALBERTO CORBA | Black Mirror è la ormai celebre serie antologica inglese, di genere Sci-fi, ideata da Charlie Broocker e prodotta da Endemol e Channel 4.


 FABRIZIO PARENTI | Inizio questo secondo pezzo con un piccolo mea culpa: la volta scorsa ho dimenticato di scrivere di quella ch’è stata la madre di tutto ciò che vedremo dopo, la genesi del cambiamento nell’idea stessa di serie, quella che ha cambiato modo di scrivere, filmare e recitare, ovvero Twin Peaks. Ma l’ho dimenticata perché la suntuosa colonna sonora di Angelo Badalamenti non va nella direzione in cui andranno strada facendo le altre serie, ma resta nel campo delle costruzioni sonore di uno sfondo alla vicenda, senza mai entrare nelle dinamiche narrative e senza cercare gli accoppiamenti tra singolo pezzo e situazione. Badalamenti sta a Lynch come Herrmann sta a Hitchcock, le sue musiche sono di straordinaria atmosfera ma restano monolitiche, non vanno in direzione della trasversalità (e questo ragionamento varrà anche per Lost e la colonna sonora di Michael Giacchino).
FABRIZIO PARENTI | Inizio questo secondo pezzo con un piccolo mea culpa: la volta scorsa ho dimenticato di scrivere di quella ch’è stata la madre di tutto ciò che vedremo dopo, la genesi del cambiamento nell’idea stessa di serie, quella che ha cambiato modo di scrivere, filmare e recitare, ovvero Twin Peaks. Ma l’ho dimenticata perché la suntuosa colonna sonora di Angelo Badalamenti non va nella direzione in cui andranno strada facendo le altre serie, ma resta nel campo delle costruzioni sonore di uno sfondo alla vicenda, senza mai entrare nelle dinamiche narrative e senza cercare gli accoppiamenti tra singolo pezzo e situazione. Badalamenti sta a Lynch come Herrmann sta a Hitchcock, le sue musiche sono di straordinaria atmosfera ma restano monolitiche, non vanno in direzione della trasversalità (e questo ragionamento varrà anche per Lost e la colonna sonora di Michael Giacchino).

 lpiti da insolita passione e la splendida 80enne Lucia Zotti si lancerà in uno spogliarello travolgente e gioioso.
lpiti da insolita passione e la splendida 80enne Lucia Zotti si lancerà in uno spogliarello travolgente e gioioso.
 ANDREA CIOMMIENTO | C’è uno spazio pubblico, il Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano, che prende vita grazie a una performance nella quale ogni spettatore ascolta domande in cuffia. Le sue risposte possono manifestarsi solamente con il movimento (spostandosi verso destra e sinistra) e il gesto (espressioni facciali e uso delle mani, braccia e piedi). Qui il dominio del pubblico è sovrano e unicamente condotto da una voce registrata, senza la presenza di attori. L’unico patto è stare lì, cento persone in un unico luogo aperto, e farsi coinvolgere tra la dimensione reale e immaginaria.
ANDREA CIOMMIENTO | C’è uno spazio pubblico, il Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano, che prende vita grazie a una performance nella quale ogni spettatore ascolta domande in cuffia. Le sue risposte possono manifestarsi solamente con il movimento (spostandosi verso destra e sinistra) e il gesto (espressioni facciali e uso delle mani, braccia e piedi). Qui il dominio del pubblico è sovrano e unicamente condotto da una voce registrata, senza la presenza di attori. L’unico patto è stare lì, cento persone in un unico luogo aperto, e farsi coinvolgere tra la dimensione reale e immaginaria. In Domini Públic ci sono regole, come in un gioco, dinamiche di gruppo e di branco, come in un gioco, norme di comportamento indotto, come in un gioco. Ma ciò che il pubblico vive ha il gusto dell’amichevole volto del fascismo (ndr, “The Friendly Face of Fascism” è il nome della compagnia di Bernat) all’interno di una ricerca sull’estetica della percezione.
In Domini Públic ci sono regole, come in un gioco, dinamiche di gruppo e di branco, come in un gioco, norme di comportamento indotto, come in un gioco. Ma ciò che il pubblico vive ha il gusto dell’amichevole volto del fascismo (ndr, “The Friendly Face of Fascism” è il nome della compagnia di Bernat) all’interno di una ricerca sull’estetica della percezione.



 SILVIA FERRARI | Enzo Cosimi ci dice che la bellezza è ovunque, soprattutto dove ci dimentichiamo di cercarla. Dal 2015 sta lavorando su una trilogia intitolata “Ode alla bellezza. Trilogia sulla diversità”, un lavoro intenso e non facile che prova a portare lo sguardo oltre le apparenze. Dopo “La bellezza ti stupirà” (prodotto l’anno scorso in esclusiva per Cagliari Capitale italiana della Cultura 2015 e dedicato ai senzatetto) la seconda parte della trilogia, “Corpus Hominis”, è stata ospite sempre nel capoluogo sardo per Autunno Danza, festival dedicato alla danza e alle arti performative che da più di vent’anni è diretto da Momi Falchi e Tore Muroni: una delle vetrine più importanti per la danza in Sardegna e non solo.
SILVIA FERRARI | Enzo Cosimi ci dice che la bellezza è ovunque, soprattutto dove ci dimentichiamo di cercarla. Dal 2015 sta lavorando su una trilogia intitolata “Ode alla bellezza. Trilogia sulla diversità”, un lavoro intenso e non facile che prova a portare lo sguardo oltre le apparenze. Dopo “La bellezza ti stupirà” (prodotto l’anno scorso in esclusiva per Cagliari Capitale italiana della Cultura 2015 e dedicato ai senzatetto) la seconda parte della trilogia, “Corpus Hominis”, è stata ospite sempre nel capoluogo sardo per Autunno Danza, festival dedicato alla danza e alle arti performative che da più di vent’anni è diretto da Momi Falchi e Tore Muroni: una delle vetrine più importanti per la danza in Sardegna e non solo.



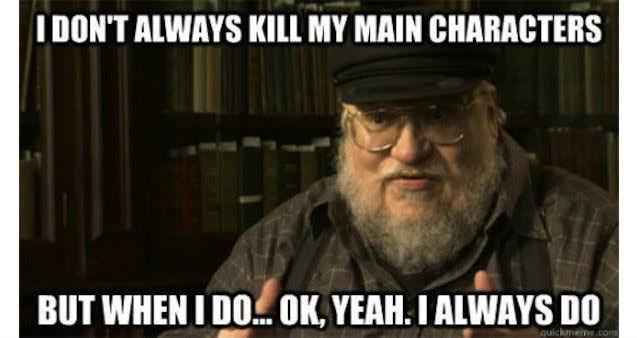



 RENZO FRANCABANDERA | Aggirarsi per Londra all’indomani del referendum sulla Brexit è stata quest’anno un’esperienza educativa. La città era, e probabilmente ancora è, un po’ frastornata. Ma, come per le elezioni USA, è sempre la periferia a decidere i destini, a sentirsi lontana dal centro. Sono le periferie a vivere i disagi, a non sentirsi parte del network che invece le città fra loro naturalmente creano. Basta vedere una mappa delle infrastrutture ferroviarie per comprendere quanto le città, i poli di ricchezza, tendano a creare fra loro legami. Come le città così i poli culturali hanno questa tensione al legame, a creare unione. E se c’è qualcosa che in questi decenni ha creato l’ossatura dell’Europa dal punto di vista culturale, questo è stato senza dubbio il livello più alto dell’istruzione, il network universitario e i progetti transfrontalieri. Uno dei più importanti, utilizzati in modo massiccio e sicuramente anche il più popolare, è il progetto Erasmus.
RENZO FRANCABANDERA | Aggirarsi per Londra all’indomani del referendum sulla Brexit è stata quest’anno un’esperienza educativa. La città era, e probabilmente ancora è, un po’ frastornata. Ma, come per le elezioni USA, è sempre la periferia a decidere i destini, a sentirsi lontana dal centro. Sono le periferie a vivere i disagi, a non sentirsi parte del network che invece le città fra loro naturalmente creano. Basta vedere una mappa delle infrastrutture ferroviarie per comprendere quanto le città, i poli di ricchezza, tendano a creare fra loro legami. Come le città così i poli culturali hanno questa tensione al legame, a creare unione. E se c’è qualcosa che in questi decenni ha creato l’ossatura dell’Europa dal punto di vista culturale, questo è stato senza dubbio il livello più alto dell’istruzione, il network universitario e i progetti transfrontalieri. Uno dei più importanti, utilizzati in modo massiccio e sicuramente anche il più popolare, è il progetto Erasmus.
 Ne è nato un percorso drammaturgico, ma anche didattico e teatrale, di cui saranno interpreti nella serata del 28 gli allievi della Scuola del Piccolo, cui si aggiungerà l’esperienza degli attori Leonardo De Colle e Pia Lanciotti. “Portiamo nel nome e nel nostro lavoro la parola Europa – ci ha dichiarato Sergio Escobar, da anni alla guida del Piccolo Teatro d’Europa – e non può suonare rinunciatario, dunque, chiederci se l’Europa non esista più o se l’Europa esista ancora. Lavoriamo per la seconda. L’identità non è un fotogramma, ma un racconto. Non è assurdo, dunque, pensare che, paradossalmente, il riaffermarsi di nazionalismi e di muri di egoismo nasca non già da prove di forza, ma da somme conflittuali di debolezze di quegli Stati che, nel pensiero dei fondatori dell’Unione Europea, avrebbero dovuto interpretare lo “sguardo largo” dell’Europa ma che ora sembrano aver perso qualsiasi sguardo”.
Ne è nato un percorso drammaturgico, ma anche didattico e teatrale, di cui saranno interpreti nella serata del 28 gli allievi della Scuola del Piccolo, cui si aggiungerà l’esperienza degli attori Leonardo De Colle e Pia Lanciotti. “Portiamo nel nome e nel nostro lavoro la parola Europa – ci ha dichiarato Sergio Escobar, da anni alla guida del Piccolo Teatro d’Europa – e non può suonare rinunciatario, dunque, chiederci se l’Europa non esista più o se l’Europa esista ancora. Lavoriamo per la seconda. L’identità non è un fotogramma, ma un racconto. Non è assurdo, dunque, pensare che, paradossalmente, il riaffermarsi di nazionalismi e di muri di egoismo nasca non già da prove di forza, ma da somme conflittuali di debolezze di quegli Stati che, nel pensiero dei fondatori dell’Unione Europea, avrebbero dovuto interpretare lo “sguardo largo” dell’Europa ma che ora sembrano aver perso qualsiasi sguardo”. I nomi che riecheggiano in questo lavoro così polifonico che risuonerà lunedì 28 sono quelli di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann e Ada Rossi, protagonisti autentici dell’europeismo, che hanno lavorato per il sogno di un’Europa unita durante i giorni più bui della storia del nostro continente. Le parole dei primi tre, in particolare alcuni dei loro testi più icastici, sono stati oggetto della rielaborazione drammaturgica dagli studenti del Corso di Storia del Teatro dell’Università e il loro testimone di parole è passato nelle mani di altri giovani che di quel testo devono fare teatro, portarlo in scena, con la regia di Emiliano Bronzino. Un passaggio forse anche filosofico a ben pensarci, sulla necessità che la parola dei padri sia capace di essere feconda e dare opportunità, lavoro. Una fonte di ispirazione che mai come in questo momento deve continuare a scorrere, ma che modestamente proponiamo sia portata anche in periferia.
I nomi che riecheggiano in questo lavoro così polifonico che risuonerà lunedì 28 sono quelli di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Ursula Hirschmann e Ada Rossi, protagonisti autentici dell’europeismo, che hanno lavorato per il sogno di un’Europa unita durante i giorni più bui della storia del nostro continente. Le parole dei primi tre, in particolare alcuni dei loro testi più icastici, sono stati oggetto della rielaborazione drammaturgica dagli studenti del Corso di Storia del Teatro dell’Università e il loro testimone di parole è passato nelle mani di altri giovani che di quel testo devono fare teatro, portarlo in scena, con la regia di Emiliano Bronzino. Un passaggio forse anche filosofico a ben pensarci, sulla necessità che la parola dei padri sia capace di essere feconda e dare opportunità, lavoro. Una fonte di ispirazione che mai come in questo momento deve continuare a scorrere, ma che modestamente proponiamo sia portata anche in periferia.