
MATTEO BRIGHENTI | Corpi, corpi stesi sulla sabbia, corpi a perdita d’occhio, onde immobili di un mare che non ha più lacrime. Il petto nudo, le gambe aperte in pantaloni corti e stazzonati, tenuti su con lo spago, la faccia coperta come si fa con i morti di morte violenta. Solo un uomo è in piedi, un muezzin che ha fatto dell’oscurità il suo minareto: salmodia “Allāhu Akbar”, “Dio è grande”. In fondo e in alto, sul palcoscenico, due donne ritmano pesantemente su due tamburi un invito al risveglio, alla forza, alla rivolta. Gli Angeli e Demoni del Teatro dei Venti sono uomini che riemergono dalle viscere del tempo, asce di guerra disseppellite da occhi smarriti: ognuno si alza con il suo andamento che diventa suono, gesto, linguaggio comune a tutti. La tragedia non è che esiste il destino, è non trovare il coraggio di resistergli e combattere per un destino migliore.
La scena è una spiaggia di richiedenti asilo emotivo. Sono i detenuti e gli internati della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia e della Casa circondariale di Modena. Il progetto, infatti, è promosso dal Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, con la richiesta di lavorare su La Gerusalemme liberata, a cui partecipano anche gli studenti della V superiore dello Spallanzani di Castelfranco Emilia e la compagnia del Teatro dei Venti. L’opera del Tasso per il regista Stefano Tè è l’occasione di spingersi sul labile confine tra bene e male, e guardare in entrambi gli abissi, essendone ri-guardato a sua volta, come ben spiega Giulio Sonno su Paper street.
La battaglia tra ‘Angeli e Demoni’, i cristiani e musulmani del testo di partenza, è un incontro di suggestioni che procede per fermi immagine, una successione di quadri di perdizione e resurrezione sottolineati e scanditi dall’uscita dal buio alla luce, e viceversa. Gli attori-detenuti, ma bisognerebbe dire semplicemente attori, rispettando quando detto per gli attori ‘sensibili’ di Lenz Fondazione (il teatro è l’eterna sfida del presente per riscattarsi dal passato), sono senza infingimenti, la pelle tatuata, gli occhi fieri e timorosi. Chiedono aiuto, muti, con la sabbia che gli scivola tra le mani. Una volta in carcere, ci ha raccontato Tè, un detenuto per protesta si è cucito la bocca: si capisce allora che Angeli e Demoni è epica della realtà, ci riporta a vite che ci accadono vicino, ma qui non possiamo guardare e passare, dobbiamo guardare e restare.

Un momento dopo si asciugano le labbra riarse con la rena e poi arrivano gli studenti, calmi, lenti, con delle tazze di metallo in mano, e danno a ognuno qualche dito d’acqua. Sono ragazzi e hanno una gentilezza di latte e scarpe da ginnastica. Conducono le sofferenze di questi uomini sperduti in un luogo ‘altro’ dall’odio, dal terrore di questa spiaggia senza mare dove non c’è un attimo di pace, quiete, serenità.
Se dal loro incontro nascono le frasi della partitura scenica, le attrici del Teatro dei Venti ne sono la punteggiatura: non tutte le creazioni hanno uguale potenza visiva, eppure la convinzione non cala mai e il vigore e la tensione nemmeno. Nella messinscena Angeli e Demoni sconta quindi l’articolazione del progetto, con le energie e risorse concentrate e concertate unicamente nei momenti di residenza: nel febbraio 2015 alla Corte ospitale di Rubiera, Reggio Emilia, nel giugno 2015 al Teatro delle Passioni di Modena e l’ultima, di nuovo alla Corte Ospitale, nel gennaio di quest’anno, con l’obiettivo del debutto in prima nazionale al Teatro Herberia di Rubiera.
L’ascolto e lo scambio tra i tre gruppi ci sono stati e si vedono, ma alcuni passaggi di stati d’animo e situazione non sono fluidi e lineari, la costruzione per stare in piedi ha bisogno ancora delle impalcature (ad esempio, un uso didascalico della musica, Marilyn Manson, The Cranberries, Šostakovič, a sottolineare circostanze e coloriture emozionali). Ostacoli, inciampi da cui Stefano Tè e Compagnia si devono rialzare, se è vero che il Teatro dei Venti vuole essere rappresentato da e in questa formula sulle assi del palcoscenico, e un domani anche negli spettacoli in strada, nelle piazze e negli spazi della vita quotidiana.
Il passo è comunque di quelli che, attraverso la formazione artistica, fanno incontrare la volontà e l’opportunità con un futuro di crescita individuale e collettiva: in scena, poco prima della fine, i ragazzi chiudono di sabbia le palpebre degli attori e raccolgono in eredità i loro movimenti, nella sorpresa di scoprirsi adulti tra gli adulti.
E poi gli Angeli e Demoni prendono gli applausi tutti insieme, abbracciati.
Angeli e Demoni
Uno spettacolo su La Gerusalemme liberata
con Maria Albamonte, Luca Arnaldo Alduzzi, Nicola Azzali, Giulia Basile, Morena Borrelli, Elisa Carucci, Saverio Casadonte, Oksana Casolari, Emanuele Cassin, Eleonora Cavilli, Laura Dallari, Daniele De Blasis, Massimo Dessì, Giada Di Lascio, Francesca Figini, Lucia Goldoni, Hanna Grahl, Lucio Improta, Karim Morad, Carlo Alberto Lomartire, Francisco Lopez, Youssef Medi, Roberto Milano, Lucia Moreali, Gionata Muratori, Penelope Muratori, Elisa Lucia Onfiani, Ciro Pecorella, Antonio Piccolo, Beatrice Pizzardo, Andrea Rogolino, Antonio Santangelo, Eleonora Segala, Felice Spavento, Valeria Topala, Mersia Valente
regia Stefano Tè
progetto realizzato con il sostegno del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, Comune di Modena, Comune di Castelfranco Emilia, in collaborazione con la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, la Casa Circondariale di Modena e la Corte Ospitale di Rubiera
Visto sabato 23 gennaio, Teatro Herberia, Rubiera, Reggio Emilia.

 Si tratta di uno studio sul Dottor Faustus di Marlowe, una riscrittura molto libera e coraggiosa del testo originale, “La tragica storia del Dottor Faust” appunto. Luca Scarlini torna all’Ur-Faust e se ne riappropria, condensando la mai-conclusa e la mai-appagata ricerca esistenziale del protagonista (una Sehnsucht ante litteram) in dieci quadri, dieci monologhi interiori che raccontano un Io profondamente diviso e frammentato. Per l’esattezza: Uno studio in rosso; Scrivo, dunque sono? Specchio; Desiderabile; Invocazione; Ritirata strategica; Tentativo di ribellione; Prove di afasia; Canto della resa incondizionata e del silenzio prolungato; Acromo, felice.
Si tratta di uno studio sul Dottor Faustus di Marlowe, una riscrittura molto libera e coraggiosa del testo originale, “La tragica storia del Dottor Faust” appunto. Luca Scarlini torna all’Ur-Faust e se ne riappropria, condensando la mai-conclusa e la mai-appagata ricerca esistenziale del protagonista (una Sehnsucht ante litteram) in dieci quadri, dieci monologhi interiori che raccontano un Io profondamente diviso e frammentato. Per l’esattezza: Uno studio in rosso; Scrivo, dunque sono? Specchio; Desiderabile; Invocazione; Ritirata strategica; Tentativo di ribellione; Prove di afasia; Canto della resa incondizionata e del silenzio prolungato; Acromo, felice.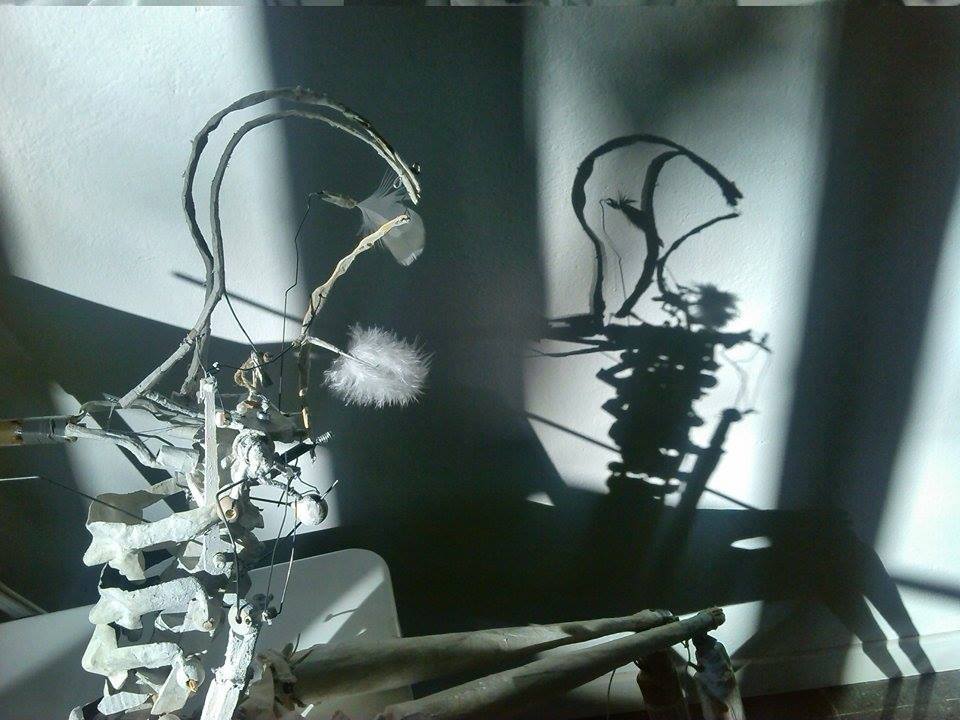
 direttore della compagnia Teatro di Dioniso. La versione scelta da Malosti è quella della prima stesura del testo, in siciliano, che mantiene sfumature di tono più difficili da rendere con l’italiano.
direttore della compagnia Teatro di Dioniso. La versione scelta da Malosti è quella della prima stesura del testo, in siciliano, che mantiene sfumature di tono più difficili da rendere con l’italiano. La prima cartuccia delle tre è La variante E.K., in cui un giovane protagonista viene indottrinato da due maestri becchini su vari tentativi di suicidio con la speranza di trovare quello a lui più congeniale. Gli attori non fanno in tempo ad entrare in scena che subito trascinano con loro un ragazzo del pubblico. Per la serie: stasera vado a teatro e mi rilasso. Sarà proprio lo spettatore scelto dagli attori ad interpretare E.K., variante ogni volta diversa protagonista dello spettacolo.
La prima cartuccia delle tre è La variante E.K., in cui un giovane protagonista viene indottrinato da due maestri becchini su vari tentativi di suicidio con la speranza di trovare quello a lui più congeniale. Gli attori non fanno in tempo ad entrare in scena che subito trascinano con loro un ragazzo del pubblico. Per la serie: stasera vado a teatro e mi rilasso. Sarà proprio lo spettatore scelto dagli attori ad interpretare E.K., variante ogni volta diversa protagonista dello spettacolo. I protagonisti sono gufi ed alieni le cui vicende si alternano con quelle di fantasmi storici quali Marx, Darwin, Hitler, Freud, Netwon e addirittura lo stesso Gesù, che mostrano con freddure da brivido in che modo rapiscono gli alieni. La forza del loro rapimento, però, è fragile quanto il retino per farfalle che gli attori utilizzano in scena a conclusione dei loro siparietti. Anche qui gli sketck comici focalizzati su giochi e assonanze di parole si alternano ora con le vicende di due gufi intrappolati in una vita monotona e claustrofobica (maschere di Tiziana Tassinari) che dialogano tra loro con freddure da brividi, ora con alieni militari che si prendono gioco del pubblico.
I protagonisti sono gufi ed alieni le cui vicende si alternano con quelle di fantasmi storici quali Marx, Darwin, Hitler, Freud, Netwon e addirittura lo stesso Gesù, che mostrano con freddure da brivido in che modo rapiscono gli alieni. La forza del loro rapimento, però, è fragile quanto il retino per farfalle che gli attori utilizzano in scena a conclusione dei loro siparietti. Anche qui gli sketck comici focalizzati su giochi e assonanze di parole si alternano ora con le vicende di due gufi intrappolati in una vita monotona e claustrofobica (maschere di Tiziana Tassinari) che dialogano tra loro con freddure da brividi, ora con alieni militari che si prendono gioco del pubblico. Tra il pubblico che non riesce a smettere di ridere e i passanti increduli, Talarico è l’unico a soffrire per la morte del collega: tutto intorno a lui sghignazzano per la situazione surreale, mostrando quanto un macabro rito funereo possa essere invece motivo di felicità altrui. Lo spettacolo riprende in sala non senza prima aver fatto le dovute condoglianze al distrutto Talarico. Un susseguirsi di continue domande sul come debellare le malattie che portano inevitabilmente alla morte, trovano risposte nei consiglio di santi identificati in accensioni di lampadine o da squilli di un telefono posti in proscenio. Il gioco tra la vita e la morte è composto da pedine di spettatori che trasformano le loro risate in un sorriso stentato quando, abbandonati i giochi e le maschere, il duo svela come alcune vicende da loro realmente vissute abbiano poi portato alla costruzione di quello che fino ad adesso ci ha fatto ridere tanto.
Tra il pubblico che non riesce a smettere di ridere e i passanti increduli, Talarico è l’unico a soffrire per la morte del collega: tutto intorno a lui sghignazzano per la situazione surreale, mostrando quanto un macabro rito funereo possa essere invece motivo di felicità altrui. Lo spettacolo riprende in sala non senza prima aver fatto le dovute condoglianze al distrutto Talarico. Un susseguirsi di continue domande sul come debellare le malattie che portano inevitabilmente alla morte, trovano risposte nei consiglio di santi identificati in accensioni di lampadine o da squilli di un telefono posti in proscenio. Il gioco tra la vita e la morte è composto da pedine di spettatori che trasformano le loro risate in un sorriso stentato quando, abbandonati i giochi e le maschere, il duo svela come alcune vicende da loro realmente vissute abbiano poi portato alla costruzione di quello che fino ad adesso ci ha fatto ridere tanto.



 NICOLA ARRIGONI – Kriminal Tango è un recital, ma è anche tappa di un percorso. Il percorso è quello che porterà all’elaborazione del Discorso Verde di Fanny & Alexander, lavoro sul denaro e l’economia, che arriva dopo quelli legati alla politica (grigio), all’educazione (giallo) e allo sport (azzurro). Dopo il destabilizzante, potente, perfetto Scrooge – visto l’estate scorsa a Drodesera – con Kriminal Tango, Marco Cavalcoli e Chiara Lagani, insieme a Luigi De Angelis si prendono una pausa, si concedono un divertissement. Ed in effetti come tale deve leggersi, anche se non mancano in Kriminal Tango elementi di costruzione drammaturgica che ammiccano a un mondo criminoso, a un passare di mano in mano di denaro e fortune più o meno estorti, flusso di ricchezza e potere che seduce e contamina. In un ambientazione da night con tavolini dove prende posto il pubblico e camerieri che girano per ricevere le ordinazioni Buscaglione/Cavalcoli si diverte, affiancato dall’Orchestrina di Bluemotion. Fred Buscaglione alias Cavalcoli con tanto di paglietta e sigaro non solo sciorina il suo repertorio, ma ne fa – con accenni a volte velati altre volte espliciti – un testo nuovo.
NICOLA ARRIGONI – Kriminal Tango è un recital, ma è anche tappa di un percorso. Il percorso è quello che porterà all’elaborazione del Discorso Verde di Fanny & Alexander, lavoro sul denaro e l’economia, che arriva dopo quelli legati alla politica (grigio), all’educazione (giallo) e allo sport (azzurro). Dopo il destabilizzante, potente, perfetto Scrooge – visto l’estate scorsa a Drodesera – con Kriminal Tango, Marco Cavalcoli e Chiara Lagani, insieme a Luigi De Angelis si prendono una pausa, si concedono un divertissement. Ed in effetti come tale deve leggersi, anche se non mancano in Kriminal Tango elementi di costruzione drammaturgica che ammiccano a un mondo criminoso, a un passare di mano in mano di denaro e fortune più o meno estorti, flusso di ricchezza e potere che seduce e contamina. In un ambientazione da night con tavolini dove prende posto il pubblico e camerieri che girano per ricevere le ordinazioni Buscaglione/Cavalcoli si diverte, affiancato dall’Orchestrina di Bluemotion. Fred Buscaglione alias Cavalcoli con tanto di paglietta e sigaro non solo sciorina il suo repertorio, ma ne fa – con accenni a volte velati altre volte espliciti – un testo nuovo. Fanno allora capolino – fra una canzone e l’altra – anche il sorriso di Berlusconi, l’attualità, il miracolo economico che fu, le seduzioni del denaro che non basta mai, che non serve ad acquistare qualcosa, ma diviene l’unico e vero fine dell’umana esistenza dei giorni nostri. Suggerimenti, citazioni si rincorrono sulla scia di un recital canoro e musicale raffinato, leggero, intelligente. Come sempre Marco Cavalcoli è perfetto, ironico, divertito e divertente, si assiste con piacere a un’ora di buona musica con un pizzico di sapore vintage.Tutto ciò in Kriminal Tango vive con equilibrio e dimostra di essere proiettato verso un altrove che lascia l’amaro in bocca, che ci fa dire di aver assistito a una parte di un tutto che deve ancora venire. Sensazione questa che non si era percepita in Scrooge, allestimento più complesso, linguisticamente più elaborato e con maggiore energia. Con l’amarezza ma anche la speranza di un Discorso verde al di là da venire, Kriminal Tango offre comunque l’occasione di incontrare e apprezzare il lavoro di Fanny & Alexander, l’intelligenza e la voglia di essere presenti e menti pensanti del teatro di Luigi De Angelis, Chiara Lagani e ovviamente Marco Cavalcoli.
Fanno allora capolino – fra una canzone e l’altra – anche il sorriso di Berlusconi, l’attualità, il miracolo economico che fu, le seduzioni del denaro che non basta mai, che non serve ad acquistare qualcosa, ma diviene l’unico e vero fine dell’umana esistenza dei giorni nostri. Suggerimenti, citazioni si rincorrono sulla scia di un recital canoro e musicale raffinato, leggero, intelligente. Come sempre Marco Cavalcoli è perfetto, ironico, divertito e divertente, si assiste con piacere a un’ora di buona musica con un pizzico di sapore vintage.Tutto ciò in Kriminal Tango vive con equilibrio e dimostra di essere proiettato verso un altrove che lascia l’amaro in bocca, che ci fa dire di aver assistito a una parte di un tutto che deve ancora venire. Sensazione questa che non si era percepita in Scrooge, allestimento più complesso, linguisticamente più elaborato e con maggiore energia. Con l’amarezza ma anche la speranza di un Discorso verde al di là da venire, Kriminal Tango offre comunque l’occasione di incontrare e apprezzare il lavoro di Fanny & Alexander, l’intelligenza e la voglia di essere presenti e menti pensanti del teatro di Luigi De Angelis, Chiara Lagani e ovviamente Marco Cavalcoli. Lo spettacolo, in scena dal 19 al 24 gennaio al Teatro Gobetti di Torino, nel cartellone del Teatro Stabile, inizia al buio sulle note del famoso tema di Così parlò Zarathustra di Strauss, su cui si staglia una voce enfatica. Lo spettatore viene a conoscenza della storia di alcuni blocchi di granito che Hitler, certo dell’imminente vittoria, aveva fatto trasportare dalla Svezia alla Polonia in previsione della costruzione di un monumento che celebrasse il trionfo del Terzo Reich. Le pietre, però, avranno tutt’altra destinazione. Nel 1948, lo scultore ebreo polacco Nathan Rapoport le modellerà per dare forma al Monumento agli Eroi del Ghetto di Varsavia, un imponente bassorilievo eretto in mezzo alle rovine della capitale e oggi meta di pellegrinaggio e commemorazioni. Quando due potenti fari illuminano la scena, appare davanti a noi proprio questo gruppo scultoreo, reso con sorprendente verosimiglianza dai sei attori-mimi della compagnia. Ricoperti di pittura color bronzo da capo a piedi, gli attori incarnano i protagonisti del monumento: giovani uomini armati, una donna e un bambino, esseri umani dai vestiti laceri e impressionanti occhi incavati.
Lo spettacolo, in scena dal 19 al 24 gennaio al Teatro Gobetti di Torino, nel cartellone del Teatro Stabile, inizia al buio sulle note del famoso tema di Così parlò Zarathustra di Strauss, su cui si staglia una voce enfatica. Lo spettatore viene a conoscenza della storia di alcuni blocchi di granito che Hitler, certo dell’imminente vittoria, aveva fatto trasportare dalla Svezia alla Polonia in previsione della costruzione di un monumento che celebrasse il trionfo del Terzo Reich. Le pietre, però, avranno tutt’altra destinazione. Nel 1948, lo scultore ebreo polacco Nathan Rapoport le modellerà per dare forma al Monumento agli Eroi del Ghetto di Varsavia, un imponente bassorilievo eretto in mezzo alle rovine della capitale e oggi meta di pellegrinaggio e commemorazioni. Quando due potenti fari illuminano la scena, appare davanti a noi proprio questo gruppo scultoreo, reso con sorprendente verosimiglianza dai sei attori-mimi della compagnia. Ricoperti di pittura color bronzo da capo a piedi, gli attori incarnano i protagonisti del monumento: giovani uomini armati, una donna e un bambino, esseri umani dai vestiti laceri e impressionanti occhi incavati.
 MARTINA VULLO | E se un bel giorno il politico acclamato di turno fosse una trans decisamente in-trans-igente verso ogni tipo di diversità?
MARTINA VULLO | E se un bel giorno il politico acclamato di turno fosse una trans decisamente in-trans-igente verso ogni tipo di diversità?