ELENA SCOLARI | Un taccuino nero legato alla vita, come un breviario ad un saio, un abito nero un po’ monacale, gli occhi limpidi che guardano il pubblico, così Mariangela Gualtieri abita il palco della Serra Lorenzini di Milano per la seconda data della nuova rassegna Gemme e Tempesta, organizzata dalla Cooperativa Sociale I Percorsi Onlus con la direzione artistica di Monica Morini (Teatro dell’Orsa).
 Dietro la pedana una grande vetrata lascia vedere i moderni tram che attraversano il Gratosoglio. La vita e le persone transitano in una domenica pomeriggio di periferia, in uno strano contrasto tra la vegetazione fitta dell’interno e l’autunno dell’esterno.
Dietro la pedana una grande vetrata lascia vedere i moderni tram che attraversano il Gratosoglio. La vita e le persone transitano in una domenica pomeriggio di periferia, in uno strano contrasto tra la vegetazione fitta dell’interno e l’autunno dell’esterno.
Mariangela Gualtieri è poeta, non poetessa, e già questa volontà essenziale ci piace molto, perché è libera dall’inutile esigenza di affermare la femminilità per definizione nominale.
Qui l’amore è per le parole nel loro essere capaci d’incanto, per la bellezza di saper schiaffeggiare e accarezzare. L’autrice ringrazia le parole e lo fa nel miglior modo: usandole con cura, con attenzione, con passione e con sincerità.
Fate piano,
ch’è delicato tutto, nel suo esile
canto d’esserci, fate piano, per carità, fate piano.
C’è uno spintone sgarbato sulle
venature d’ogni colore, c’è un
passo pestatore che fa
lo schianto delle primavere.
Questi versi ci hanno colpito e ci sono sembrati i più giusti per provare a descrivere il carattere di Gualtieri, che con una fermezza dolce, trasparente sa fare della poesia un mezzo diretto, non ellittico, per dire la sua sul mondo, scuote i pensieri con una grazia decisa.
L’abitudine ad ascoltare la prosa e la rara frequentazione della poesia hanno prodotto un pregiudizio sulla fatica di seguire testi in versi, ma Bello Mondo è un itinerario di parole chiare, un sentiero che si segue senza sforzo. La poesia che abbiamo ascoltato è una radura dove trovano spazio situazioni e sentimenti che possono esserci più o meno vicini, ma ognuno dei presenti si sarà sentito toccare dalla voce di Mariangela, il cui timbro è rasserenante anche quando sollecita punti dolorosi: la pena di assistere al decadimento di una madre, l’incapacità di accettare la morte ma al tempo stesso una visione positiva perché …grazie ai nostri morti, che fanno della morte un posto abitato.
Bello Mondo è descritto come un “rito sonoro” (con la guida di Cesare Ronconi), la musica, sempre lieve, è intervallo di respiro tra un componimento e l’altro, a volte accompagna la recitazione, dando una cadenza calma, francescana, e lasciando allo spettatore il tempo di riprendersi. Sì perché se si è entrati in quella radura, per quell’ora si è stati messi di fronte, con sana franchezza, a molto di quello che nella vita attraversiamo e sentiamo forte ma non riusciamo a dire. Però lo riconosciamo, lo riconosciamo nitidamente nelle parole che sanno descriverlo.
Crediamo alle parole di Mariangela Gualtieri perché lei assomiglia a loro.
In questa bellissima poesia d’amore si chiede gentilezza, e guardando la poeta sappiamo che quella gentilezza è la sua.
Sii dolce con me. Sii gentile./ E’ breve il tempo che resta. Poi/ saremo scie luminosissime./ E quanta nostalgia avremo /dell’umano. Come ora ne/ abbiamo dell’infinità./ Ma non avremo le mani. Non potremo/ fare carezze con le mani./ E nemmeno guance da sfiorare /leggere./ Una nostalgia d’imperfetto/ ci gonfierà i fotoni lucenti./ Sii dolce con me./ Maneggiami con cura/… Sia placido questo nostro esserci,/questo essere corpi scelti/ per l’incastro dei compagni/ d’amore.//’
In quel taccuino nero è custodito un sapere altissimo: deve essere sfogliato lentamente per cercare la via e poi lasciato cadere.


 NICOLA ARRIGONI | «Nell’estate del 1956, Hannah Arendt scriveva all’amico e maestro Karl Jaspers di un conflitto millenario tra filosofia e politica emerso alle origini della tradizione occidentale, più precisamente a partire dal processo di Socrate, cioè da quando la polis processò il filosofo», scrive Ilaria Possenti nell’introduzione a Socrate di Hannah Arendt, un testo intenso e che ci interroga sul senso di democrazia, sulla necessità di avere punti di riferimenti fissi e immutabili: le idee platoniche?, sulla liquidità di Socrate. In tempi in cui in nome della sicurezza si vorrebbe sacrificare un po’ di nostra libertà, il testo di Arendt ci aiuta a capire che questo rischio non vale la pena di essere corso, perché poi ripercorrere la strada inversa sarebbe difficile, se non impossibile. Arendt non si limita a raccontare il rapporto di Socrate con la polis che non lo comprese e lo lasciò morire, non si limita a mettere in evidenza come il rapporto con il suo allievo, Platone finì per metterlo in ombra, ma soprattutto racconta di «una visione socratica della condizione umana, in qualche modo intesa come condizione ‘politica’, che dovrebbe aiutarci a ripensare da capo il senso della vita della polis, i suoi rapporti con l’etica e la conoscenza, i tanti dualismi della nostra tradizione (verità e opinione, pensiero e azione, mente e corpo) e l’oggetto stesso della ‘meraviglia’ filosofica – la pluralità – che ci unisce, ci distingue e ci attraversa».
NICOLA ARRIGONI | «Nell’estate del 1956, Hannah Arendt scriveva all’amico e maestro Karl Jaspers di un conflitto millenario tra filosofia e politica emerso alle origini della tradizione occidentale, più precisamente a partire dal processo di Socrate, cioè da quando la polis processò il filosofo», scrive Ilaria Possenti nell’introduzione a Socrate di Hannah Arendt, un testo intenso e che ci interroga sul senso di democrazia, sulla necessità di avere punti di riferimenti fissi e immutabili: le idee platoniche?, sulla liquidità di Socrate. In tempi in cui in nome della sicurezza si vorrebbe sacrificare un po’ di nostra libertà, il testo di Arendt ci aiuta a capire che questo rischio non vale la pena di essere corso, perché poi ripercorrere la strada inversa sarebbe difficile, se non impossibile. Arendt non si limita a raccontare il rapporto di Socrate con la polis che non lo comprese e lo lasciò morire, non si limita a mettere in evidenza come il rapporto con il suo allievo, Platone finì per metterlo in ombra, ma soprattutto racconta di «una visione socratica della condizione umana, in qualche modo intesa come condizione ‘politica’, che dovrebbe aiutarci a ripensare da capo il senso della vita della polis, i suoi rapporti con l’etica e la conoscenza, i tanti dualismi della nostra tradizione (verità e opinione, pensiero e azione, mente e corpo) e l’oggetto stesso della ‘meraviglia’ filosofica – la pluralità – che ci unisce, ci distingue e ci attraversa». E’ in questa prospettiva che il testo di Hannah Arendt ci interroga al di là della figura di Socrate, ma recuperando nel volatile Socrate una capacità di dialogo, un’attività dialogica che porta nel confronto con l’altro alla definizione di una verità possibile, verità comunque non assoluta che trova la sua necessitata possibilità metamorfica nell’azione continua del dialogare. Ecco secondo Arendt Platone tradisce questa fluidità dialogica e dialettica del maestro Socrate per inaugurare un approccio metafisico alla verità, soprattutto con l’elaborazione del mito della caverna.
E’ in questa prospettiva che il testo di Hannah Arendt ci interroga al di là della figura di Socrate, ma recuperando nel volatile Socrate una capacità di dialogo, un’attività dialogica che porta nel confronto con l’altro alla definizione di una verità possibile, verità comunque non assoluta che trova la sua necessitata possibilità metamorfica nell’azione continua del dialogare. Ecco secondo Arendt Platone tradisce questa fluidità dialogica e dialettica del maestro Socrate per inaugurare un approccio metafisico alla verità, soprattutto con l’elaborazione del mito della caverna.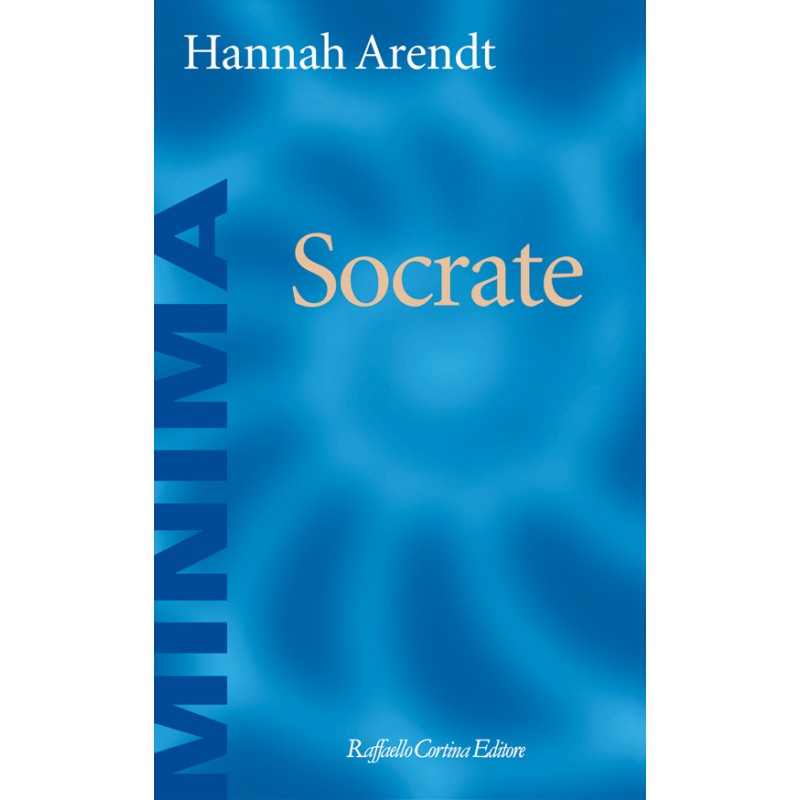 E pare sintomatico in merito quanto scrive Arendt: «Il fatto che Platore raffiguri gli abitanti della caverna come congelati, incantati di fronte a uno schermo, senza alcuna possibilità di fare qualcosa o di comunicare l’uno con l’altro, rientra fra gli aspetti enigmatici dell’allegoria. (…) L’unica occupazione degli abitanti della caverna è fissare lo schermo; è chiaro che amano il vedere fine a se stesso, indipendentemente da ogni bisogno pratico. (…) Platone li rappresenta come potenziali filosofi, impegnati a fare, in condizioni di oscurità e ignoranza, la stessa cosa che il filosofo fa alla luce del sole e con cognizione di causa». La suggestione offerta da questo passaggio è tutta contemporanea, è la condizione dell’homo videns di oggi, ma è anche una sorta di estatica contemplazione e di ricerca di icone che forniscano verità imitabili ma non discutibili con la morte della polis, ovvero di quel confronto fra cittadini che è nucleo fondante della democrazia, dell’utopia della democrazia. L’estatica contemplazione contrapposta al dialogo socratico nella convinzione che «quando pensiamo, ci rapportiamo a noi stessi come se fossimo in due in quell’uno che appare agli occhi degli altri, che grazie a questa esperienza riflessiva possiamo articolare l’esperienza filosofica della meraviglia, e cominciare a dubitare, contraddirci, farci delle domande; che, infine, la solitudine del pensiero, in quanto animata da rappresentazioni, è ancora in contatto con il mondo comune e parte integrante del nostro essere e vivere con gli altri». È questo aspetto che rende interessante e assolutamente utile la lettura di Socrate di Hanna Arendt, una lettura che ci incoraggia ad aprirci al dialogo in tempi che paradossalmente poterebbero nella direzione opposta.
E pare sintomatico in merito quanto scrive Arendt: «Il fatto che Platore raffiguri gli abitanti della caverna come congelati, incantati di fronte a uno schermo, senza alcuna possibilità di fare qualcosa o di comunicare l’uno con l’altro, rientra fra gli aspetti enigmatici dell’allegoria. (…) L’unica occupazione degli abitanti della caverna è fissare lo schermo; è chiaro che amano il vedere fine a se stesso, indipendentemente da ogni bisogno pratico. (…) Platone li rappresenta come potenziali filosofi, impegnati a fare, in condizioni di oscurità e ignoranza, la stessa cosa che il filosofo fa alla luce del sole e con cognizione di causa». La suggestione offerta da questo passaggio è tutta contemporanea, è la condizione dell’homo videns di oggi, ma è anche una sorta di estatica contemplazione e di ricerca di icone che forniscano verità imitabili ma non discutibili con la morte della polis, ovvero di quel confronto fra cittadini che è nucleo fondante della democrazia, dell’utopia della democrazia. L’estatica contemplazione contrapposta al dialogo socratico nella convinzione che «quando pensiamo, ci rapportiamo a noi stessi come se fossimo in due in quell’uno che appare agli occhi degli altri, che grazie a questa esperienza riflessiva possiamo articolare l’esperienza filosofica della meraviglia, e cominciare a dubitare, contraddirci, farci delle domande; che, infine, la solitudine del pensiero, in quanto animata da rappresentazioni, è ancora in contatto con il mondo comune e parte integrante del nostro essere e vivere con gli altri». È questo aspetto che rende interessante e assolutamente utile la lettura di Socrate di Hanna Arendt, una lettura che ci incoraggia ad aprirci al dialogo in tempi che paradossalmente poterebbero nella direzione opposta.
 IRIS BASILICATA | Ai posti 10 e 12 della fila E del teatro Vascello non c’è nessuno. È sabato sera, la città è vuota ed è inutile che ci giriamo intorno: i fatti di questi giorni hanno inevitabilmente condizionato il nostro quotidiano. Si esce di meno e per le strade o sui mezzi pubblici si respira una strana atmosfera. Il palco, invece, non è vuoto: una ballerina è lì per noi, per danzare la sua storia. L’artista in questione è Stéphanie Fuster, ballerina di origini francesi approdata in Andalusia nel 1996 per un corso di flamenco diventando una delle bailaora più ambite dalle compagnie internazionali. Aurélien Bory le dedica la coreografia
IRIS BASILICATA | Ai posti 10 e 12 della fila E del teatro Vascello non c’è nessuno. È sabato sera, la città è vuota ed è inutile che ci giriamo intorno: i fatti di questi giorni hanno inevitabilmente condizionato il nostro quotidiano. Si esce di meno e per le strade o sui mezzi pubblici si respira una strana atmosfera. Il palco, invece, non è vuoto: una ballerina è lì per noi, per danzare la sua storia. L’artista in questione è Stéphanie Fuster, ballerina di origini francesi approdata in Andalusia nel 1996 per un corso di flamenco diventando una delle bailaora più ambite dalle compagnie internazionali. Aurélien Bory le dedica la coreografia 

 Come mai l’idea di accostare il mito ad un tema d’attualità?
Come mai l’idea di accostare il mito ad un tema d’attualità?  RENZO FRANCABANDERA | Lo sciocco è quello che davvero crede che il batter d’ali della farfalla possa provocare un tifone dall’altro lato del pianeta. Il saggio quello che ne nutre un ragionevole dubbio, che non ne esclude aprioristicamente la possibilità; piuttosto la analizza attraverso la Storia, senza rassegnarsi, come essere umano, ad essere di quest’ultima solo un passeggero senza biglietto, ma allevando nel frattempo bachi da seta per prepararsi ad essere protagonista del cambiamento.
RENZO FRANCABANDERA | Lo sciocco è quello che davvero crede che il batter d’ali della farfalla possa provocare un tifone dall’altro lato del pianeta. Il saggio quello che ne nutre un ragionevole dubbio, che non ne esclude aprioristicamente la possibilità; piuttosto la analizza attraverso la Storia, senza rassegnarsi, come essere umano, ad essere di quest’ultima solo un passeggero senza biglietto, ma allevando nel frattempo bachi da seta per prepararsi ad essere protagonista del cambiamento.
 RENZO FRANCABANDERA E VINCENZO SARDELLI | RF: Capita nella vita di non interessarsi mai di una cosa, forse persino di tenerla in qualche modo lontana dai propri interessi e poi di finirci dentro mani e piedi senza volerlo e di rimanerci affascinato. Di solito capita per incontri con quelli che Peter Brook, e prima di lui Gurdjieff, definiva gli uomini straordinari.
RENZO FRANCABANDERA E VINCENZO SARDELLI | RF: Capita nella vita di non interessarsi mai di una cosa, forse persino di tenerla in qualche modo lontana dai propri interessi e poi di finirci dentro mani e piedi senza volerlo e di rimanerci affascinato. Di solito capita per incontri con quelli che Peter Brook, e prima di lui Gurdjieff, definiva gli uomini straordinari.
 LAURA NOVELLI | Un oratorio laico. Una preghiera pietosa a vantaggio degli ultimi della Terra, quelli più vicini a Dio, ammesso che Dio esista. Può essere letto così l’ultimo, intenso, lavoro di Ascanio Celestini, fabulatore instancabile di una sacralità umana che in “Laika” – debuttato al Teatro Vascello di Roma per il RomaEuropa Festival 2015 – costruisce la storia di una galleria di emarginati per riportarci al nocciolo di quella pietas virgiliana di cui abbiamo smarrito la memoria e la forza.
LAURA NOVELLI | Un oratorio laico. Una preghiera pietosa a vantaggio degli ultimi della Terra, quelli più vicini a Dio, ammesso che Dio esista. Può essere letto così l’ultimo, intenso, lavoro di Ascanio Celestini, fabulatore instancabile di una sacralità umana che in “Laika” – debuttato al Teatro Vascello di Roma per il RomaEuropa Festival 2015 – costruisce la storia di una galleria di emarginati per riportarci al nocciolo di quella pietas virgiliana di cui abbiamo smarrito la memoria e la forza.