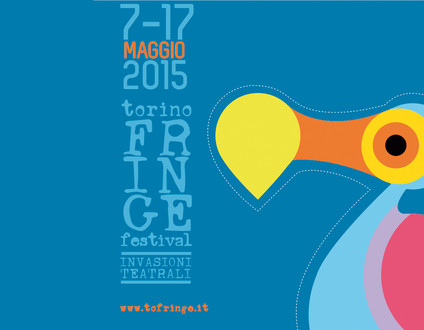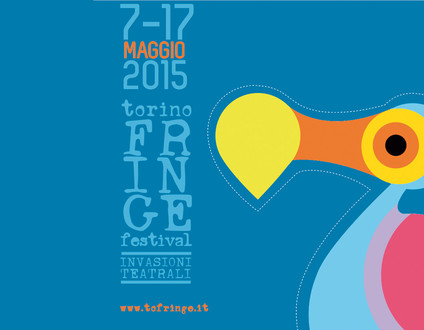GIULIA MURONI | Ha preso il via la quindicesima edizione di Interplay. La kermesse torinese guidata da Natalia Casorati conferma la propria inclinazione bifronte: guardando all’Italia e all’estero, propone artisti esordienti, perlopiù selezionati per talento dalle reti di operatori e realtà consolidate del panorama nostrano e non solo.
Nella seconda serata, al Teatro Astra di Torino, si sono succeduti gli spettacoli “Strascichi” di Irene Russolillo e “Complex des genres” di Virginie Brunelle.
La prima performance, diretta e danzata dalla giovane danzatrice pugliese, intesse un personale collage di azioni e sensazioni attraverso una partitura di movimento, parole e suono. I testi attingono da un ricco repertorio, Beckett, Cohen, Morante, Szymborska, e fanno da contraltare a musiche e arrangiamenti originali. La danza è agile, asciutta nel suo tendersi nervoso, potente in realizzazioni inedite: Russolillo si mostra performer poliedrica e intensa.
“Complex des genres”, ad opera della compagnia canadese guidata da Virginie Brunelle, ha dato vita a uno spettacolo ricco e efficace, che ha suscitato un’ovazione dal pubblico. I sei interpreti, tre uomini e tre donne, sulla scena si annodano, perdono i confini tra sé e l’altro, hanno atteggiamenti ludici, voluttuosi, irosi. Un disegno luci articolato ha pennellato la scena e i corpi dei danzatori in modo sapiente, elegante. La partitura coreografica ha raccolto a piene mani dal codice della danza classica per risignificarlo mediante una cornice di senso totalmente altra. Anche l’elemento acrobatico porge la mano alla costruzione di uno spettacolo che vuole mostrare la natura labile e paradossale dei generi, laddove maschile e femminile sono costruzioni più culturali che biologiche in senso stretto. Spettacolo immediatamente fruibile, è arrivato con forza al pubblico dell’Astra, commosso e partecipe.
Alle Fonderie Limone, Interplay darà il suo contributo al progetto “Torino incontra Berlino” con la proposta di due realtà provenienti dalla Germania: la coreografa israelo-tedesca Zufit Simon e Stephen Herwig. Serata spartita con “Gut Gift” di Francesca Foscarini e Yasmeen Godder. Sarà poi la volta dei Blitz Metropolitani, realizzati in collaborazione con Torino Jazz Festival Fringe 2015 e con Torino Capitale Europea dello Sport, dove si susseguiranno brevi performance Daniele Ninarello, Sara Marasso con Stefano Risso, Lali Ayguadè, Daniele Albanese, Francesco Cordova Azuela e Virginia Garcia insieme a Damiàn Muñoz.
Un’altra serata alle Fonderie Limone il 30 Maggio e infine il 12 Giugno performances site-specific nel Museo Ettore Fico. Questo il pacchetto Interplay, costellato di collaborazioni importanti, varietà di luoghi, performance in contesti urbani, aperitivi con dj-set, workshop e, soprattutto, un ricco cartellone di spettacoli parla di una rassegna che, nonostante i tempi di crisi e anche in virtù di una proficua rete di partner e di collaborazioni, dichiara e dimostra di tenere viva l’attenzione sulla pluralità dei linguaggi del contemporaneo.





 RENZO FRANCABANDERA | Un gruppo di uomini col la testa di papero emerge dal buio.
RENZO FRANCABANDERA | Un gruppo di uomini col la testa di papero emerge dal buio.