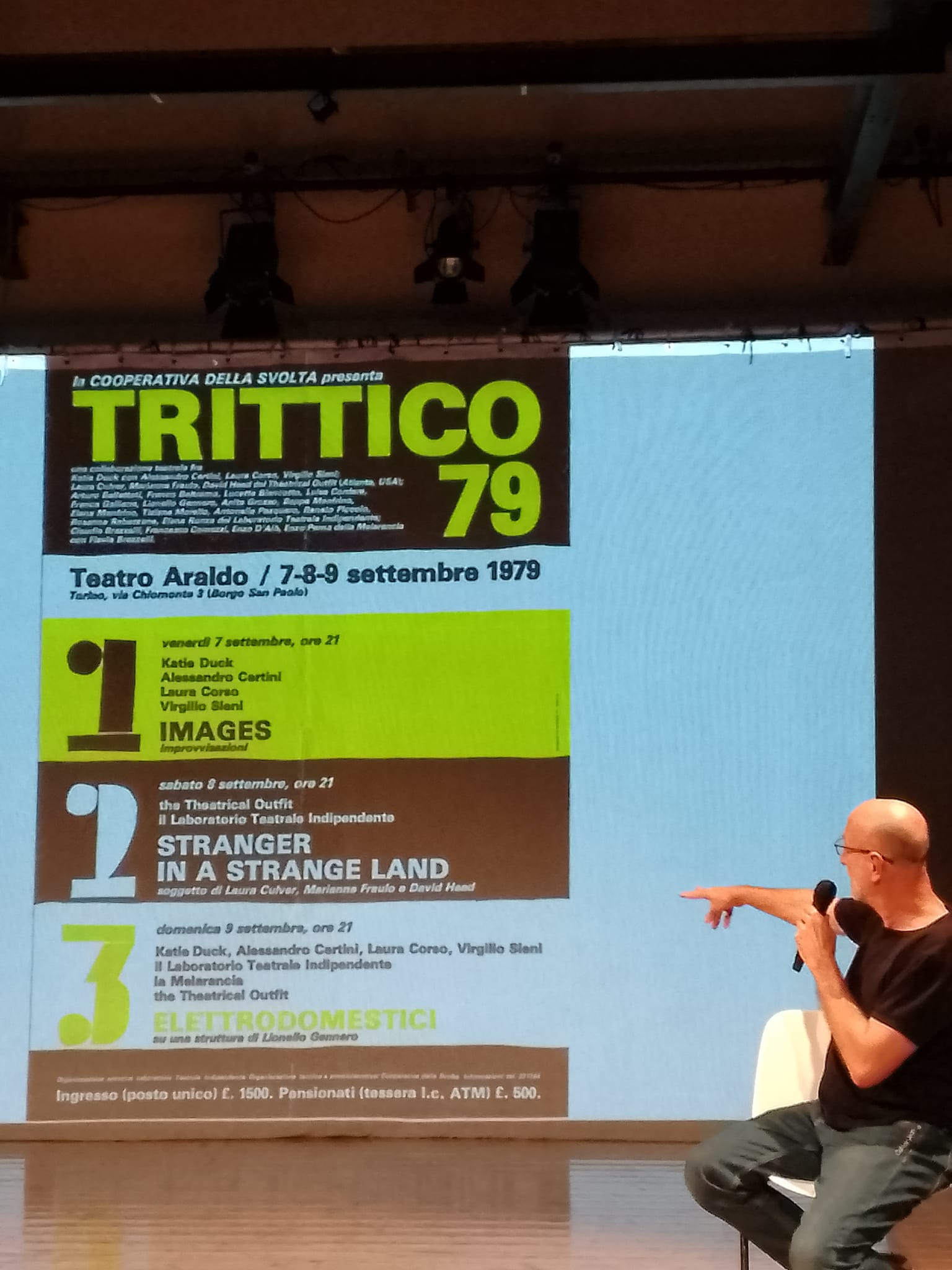RENZO FRANCABANDERA | “No better, no worse, no change. No Pain.”
In questa immutabilità di deprivazione sensoria, il dolore fisico e psichico è neutralizzato in un eterno grigio, ben rappresentato dalla scenografia di Roberto Abbiati (interprete anche del personaggio maschile Willie) e ispirata ai cretti di Burri, ma qui in monocromo grigio.
Al centro della scena, quasi a fare da tappo a un vulcanello, a una mezza solfatara, posta più che tirannicamente in cima a qualche montagna come Wilson immaginò un decennio e passa fa, si trova infitta in una montagna fino al busto Winnie (Monica Demuru), la protagonista di Giorni felici di Samuel Beckett, testo capitale della seconda metà del secolo scorso che torna in scena in questa stagione per la regia di Massimiliano Civica in una produzione del Metastasio di Prato.
La drammaturgia di Samuel Beckett in Happy Days offre nella sua monotona ripetitività un’analisi complessa della condizione umana attraverso i suoi protagonisti, Winnie e Willie, insieme ad altri personaggi simbolici e solo evocati come Shower/Cooker e Mildred. L’opera teatrale esplora i temi universali dell’identità contemporanea nella società occidentale: la solitudine, la routine, la speranza e la disperazione, presentando un quadro cupo ma al contempo commovente della vita, lettura che questo allestimento prova sotto molti aspetti a enfatizzare. La luce in cui la coppia si trova (di temperatura piena e finta, ben misurata da Gianni Staropoli), unita alla monotonia e ripetitività delle azioni, sono certo simboliche della lotta quotidiana per trovare senso, significato e scopo nella loro esistenza limitata, ma la scelta che Civica fa e che Demuru nella sua notevolissima interpretazione raccoglie e rilancia è proprio quella di rendere questo personaggio non algido e astratto ma fragilmente quotidiano.

La donna, sulla cinquantina, secondo le precise indicazioni del drammaturgo che aveva nei suoi testi l’abitudine di descrivere minuziosamente spazi e ambienti in cui la vicenda doveva aver luogo, è simbolicamente sepolta fino alla vita in una montagna di terra, immagine della sua condizione di prigioniera di una routine oppressiva e senza speranza.
Tuttavia, nonostante la situazione disperata, Winnie cerca costantemente di mantenere un’apparenza di normalità e ottimismo, affermando ripetutamente che ogni giorno sarà una “giornata felice”.
La sua costante lotta per trovare un senso di normalità e felicità nonostante le avversità è uno dei temi centrali di Giorni Felici, che al suo debutto conobbe un’accoglienza invero assai tiepida, ma che nel tempo tornò progressivamente in auge, fino a divenire uno dei grandi classici del teatro del Novecento.

Ma quella che in questa lettura viene accentata è la postura un po’ nostalgica, il rimanere legati a quella “vecchia maniera” salvifica e tranquillizzante con cui le cose venivano fatte in un tempo solo evocato ma non contestualizzabile.
La Winnie di Demuru risulta straordinaria al nostro sguardo perchè è un personaggio letterario assoluto, ma allo stesso tempo umanissimo, con sentori di signora in coda alla cassa al supermercato, bouquet di quella che nel mondo cinico e ateo dei social si sventola con il calendarietto plastificato nella antisala dell’ufficio dell’Inps, perlage di quell’altra ancora che evoca tisane e antichi rimedi ma con un moderno piglio new age che, ci mancherebbe, si stava meglio quando si stava peggio – dice – mentre commenta acida la nuova foto postata dall’amica, che mamma come le si vedono le rughe!
Che manco esistevano i social quando Beckett scrisse, ma è come se fossero già inglobati ugualmente nell’umanità che raccontava, per dire quanto fosse capace di raccontare non la superficie ma la profondità della psiche umana!
Demuru riesce a essere, in un cambio di smorfie, ora letteratura, ora caricatura di satira sociale à-la-Mannelli.
Pur in questo suo viversi mediano, senza slanci, non manca di darsi una posa vagamente ero-ammiccante, con cui provare a contrastare il tempo che passa, con un bustino ricamato e un vedo/nonvedo per portare i seni in vista, quel trucco e quella vanità che però contrastano con una borsa che sembra più quella di Mary Poppins che una luìvuitton (si nota la malizia appuntita e anche feroce nei costumi di Daniela Salernitano, che con pochissimi attributi scolpisce i personaggi).
Willie, marito di Winnie, di converso funge da contrasto all’ottimistica determinazione muliebre. Ignorando in gran parte la donna (Civica lo fa apparire di spalle, spesso assente allo sguardo dello spettatore) e impegnato in un sonno atavico e senza tempo o nella lettura del giornale (unici momenti in cui il sembiante fisico di Abbiati appare alla vista), l’uomo incarna l’apatia e la distanza emotiva che spesso affliggono le relazioni umane.
La mancanza di comunicazione e connessione tra Winnie e Willie evidenzia la solitudine e l’isolamento che affrontano entrambi, nonostante la loro presenza fisica vicina l’uno all’altro. Ma qui, pur essendo Demuru impegnata in quello che a conti fatti è un monologo con episodiche interruzioni da white noise maritale, il Wilie di Abbiati resta un personaggio che in qualche vago modo prova persino a imbastire una risposta; non di certo un vero e proprio dialogo, per carità, ma quella rassicurante attestazione l’uno all’altro di essere in vita. Come fanno i senescenti, che per mitigare l’ansia della morte si chiamano spesso al telefono per esser certi che dall’altra parte si campi ancora, affogandosi per il resto in quelle discussioni vuote sul “cosa mangi?”, “ma hai visto cosa è successo…!”.

Lo spettacolo inizia con il suono della sveglia, si alza un sipario di telo bianco (un velo pietoso, a conti fatti) svelando un mondo arido in cui i due personaggi sono immersi. Il velo ricalerà (e la sveglia risuonerà) fra il primo e il secondo atto, per poi sollevarsi ancora dopo una ipotetica nottata. Al riprendere del giorno, Winnie è ormai sepolta dalla montagna fino al collo, impossibilitata ormai a muoversi.
La lettura che dà Civica si fonda sull’idea che il “quasi monologo” della donna sia un tentativo di comunicare, semplice, nel suo farsi disperatamente continuo. Si affida per l’operazione a due interpreti particolarissimi della scena contemporanea italiana, dal portato artistico complesso, capaci di cifre e sfumature ampie e poco comuni. Demuru è attrice che ha l’abilità di dare alla voce un’espressività peculiare, frutto del suo specifico talento canoro.
Abbiati è artista immaginifico, che opera sui segni scenici sia come attore che come creatore degli spazi scenografici (sua, come si diceva, è l’ambientazione e l’installazione materica realizzata per questo allestimento), ma è anche altissimo disegnatore (la scenografia continua infatti su un telo dipinto, a fondale, una sorta di “eccetera eccetera” che prolunga all’infinito la geografia disumanizzata dello spazio scenico materico in primo piano).
Mentre nel caso di Abbiati si può parlare di una voluta assenza scenica, che dà ancora più enfasi alle sue puntiformi e sporadiche apparizioni, Demuru ha una presenza umanissima e quasi familiare. L’uno è un Buster Keaton a torso nudo, un personaggio che viene fuori dai libri di Jerome K. Jerome, un povero cristo in mutande ma che non manca il vezzo della paglietta deluxe e del giornale inglese. Lei uguale ma al femminile, con un cappello che non si capisce bene se finisce per farla assomigliare più a un Napoleone sconfitto o a un Cristoforo Colombo che non vede terra. Insomma sono come tutti noi, capitani navigatori da acqua bassa, ansiosi velleitari che pretendiamo il marchio deluxe sulle cose che andiamo a comprare al discount.
L’uso magistrale del linguaggio e della postura da parte dei due attori, ben governati da Civica che lascia i loro due talenti navigare liberi nel mare di Beckett, contribuisce alla creazione di un’atmosfera surreale e, più che opprimente, sardonicamente rassegnata: ogni azione e ogni parola assumono un significato più spesso, e arrivano allo spettatore costringendolo a un doloroso tedio in cui specchiarsi.
E quando Willie a fine spettacolo, a quattro zampe, prova a scalare la montagna, protendendo una mano verso il suo amore che lo reclama, il gesto si fa volutamente equivoco, e non si capisce se si protenda verso di lei o verso la pistola. Un gesto perfetto, che qui vale lo spettacolo e la presenza cameo di Abbiati a cui servono pochi secondi per pennellare il suo genio. E infatti l’ambiguità dell’intenzione è così sottilmente leggibile, che la visione di questo Beckett finisce persino con una tragicomica risata.
Cosa può sopravvivere a questa umanità suicida e rassegnata? Qualche sparuta piantina, che nel grigio cementizio pare mantenere un sembiante verdognolo e trovare la sua strada verso la vita nonostante tutto: è la natura che in potenza si afferma, a dispetto dell’essere umano.
Da vedere assolutamente. Da tempo non girava un Beckett così “giusto”.
Dopo le date in Emilia al nuovo Teatro delle Passioni di Modena, ospite di ERT, lo spettacolo è in questi giorni al Piccolo di Milano.
GIORNI FELICI
di Samuel Beckett
traduzione Carlo Fruttero
uno spettacolo di Massimiliano Civica
con Roberto Abbiati e Monica Demuru
scene Roberto Abbiati
costumi Daniela Salernitano
luci Gianni Staropoli
assistente alla regia Ilaria Marchianò
suggeritore Filippo Baglioni
direttore di scena Loris Giancola
elettricista e fonico Daniele Santi
sarta Annamaria Clemente
coordinamento tecnico dell’allestimento Marco Serafino Cecchi
assistente all’allestimento Giulia Giardi
cura della produzione Francesca Bettalli e Camilla Borraccino
ufficio stampa Cristina Roncucci
foto e video documentazione Duccio Burberi
grafica ed editing Francesco Marini
produzione Teatro Metastasio di Prato
foto Duccio Burberi
In accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di The Estate of Samuel Beckett c/o Curtis Brown Group Limited