
LAURA NOVELLI | Culla dell’Etruria settentrionale ed importante centro della Toscana medievale, Chiusi sorprende per le numerose bellezze architettoniche ed artistiche custodite in ogni angolo del suo territorio. Forse però non tutti sanno che ai piedi del ridente borgo toscano si apre un lago circondato da colline e vigneti e un tempo unito alle acque del Trasimeno, con cui formava un unico grande bacino lacustre. Nei giorni scorsi questo lago, con tanto di piccolo porticciolo ombroso pullulante di ninfee, è stato uno dei set più originali e affascinanti della rassegna Orizzonti. Festival delle nuove creazioni nelle arti performative svoltasi dal 31 luglio al 9 agosto in diversi spazi della bella cittadina del senese.
Giunta alla tredicesima edizione e diretta per il secondo anno da Andrea Cigni, la vetrina ha avuto un leitmotiv quanto mai emblematico: il Mediterraneo. Mediterraneo come crocevia di culture e civiltà. Come incontro di stili, tendenze, forme e linguaggi espressivi. Come superamento di barriere non solo geografiche ma soprattutto – e tanto più – etiche, ideologiche, sociali. Su questo silenzioso lago Pippo Delbono, ospite del festival con lo spettacolo/concerto La notte, ha girato alcune scene del film che presenterà a Locarno, complice il prezioso aiuto dei remaioli chiusini. Sulla sua riva più prossima al porticciolo, Andrea Adriatico ha riproposto la felice regia de L’omosessuale o la difficoltà di esprimersi e sempre su queste acque verdi di vegetazione e riflessi arborei l’attrice/narratrice Silvia Frasson – tra i suoi ultimi lavori Quando non avevamo niente e poi arrivò il signore della porcellana e Amore e ginnastica (un Edmondo De Amicis riscritto in forma di monologo da Stefano Massini) – ha raccontato la storia di Santa Mustiola, martire cristiana del III secolo che, in fuga dai persecutori romani, si dice abbia attraversato il lago usando il suo mantello come barca e, grazie al miracoloso evento, sia approdata proprio a Chiusi diventandone la patrona.
Silvia/Mustiola aspetta il pubblico su una zattera coperta da un velluto rosso e stagliata in mezzo a quelle acque tranquille, solo lievemente increspate da qualche alito di vento. Noi spettatori arriviamo in piccoli gruppi, seduti su agili imbarcazioni che si trasformano nel luogo privilegiato della nostra inconsueta visione. Ombrelli bianchi per ripararci dal sole; qualche onda più forte scuote ogni tanto la calma del momento e un panorama mozzafiato ci restituisce l’idea di un contatto profondo e incontaminato con la natura. Con la semplicità di uno stile fabulatorio che tanto ricorda Gabriele Vacis e Laura Curino, ma anche Marco Baliani, gli accenti mimici di Marceau e un certo levità “barbiana”, la Frasson (originaria di Chiusi e formatasi alla Paolo Grassi di Milano, all’interno della cui Summer School insegna proprio “tecniche di narrazione e creazione del racconto”) ci parla della Roma paleocristiana, dei primi martiri della Chiesa, di una giovane ragazza di sangue nobile che ha il coraggio di sfidare i suoi aguzzini con la sola forza della fede. Abito nero lungo, capelli lasciati liberi di assecondare il vento, occhi grandi e vivi, braccia e mani sempre in movimento, l’attrice costruisce una partitura mimico/vocale molto espressiva e al contempo lineare, snella, fruibile. D’altronde, in quello scenario così fuori da ogni tempo e ogni spazio, non le serve davvero altro per regalarci le immagini di una storia di morte e rinascita, sacrificio e redenzione che non vuole essere una semplice storia locale bensì una parabola universale contro le discriminazioni e le persecuzioni religiose di sempre.
Il monologo, intitolato La Santa. Ovvero quando Mustiola volò sul lago e prodotto proprio da Orizzonti Festival, fa parte del trittico Visitazioni che l’artista ha realizzato per Chiusi, ereditando un format già felicemente sperimentato l’anno scorso da Paolo Panaro e mettendo insieme tre assoli pensati site specific. Alla ben nota città sotterranea chiusina, la Frasson ha destinato la narrazione de Le mille e una notte, mentre presso gli antichi resti di un lavatoio ha raccontato due novelle del Decameron di Boccaccio (Masetto, la prima della terza giornata, e Guglielmo Rossiglione, la nona della quarta giornata), passando con fluida ma compita disinvoltura dai toni farseschi e ironici della prima, storia di gioie sessuali elargite alle monache di un convento da un prestante contadino, alla tragedia passionale della seconda, dove si narra – e parrebbe un voluto contrasto – la terribile fine di un amore fedifrago. Anche qui c’è lei da sola, vestita di nero, su un palcoscenico naturale che mette le ali all’immaginazione chiedendoci di credere in ciò che ascoltiamo e di vedere ciò che non vediamo. E noi spettatori – adolescenti e bambini compresi – stiamo al gioco volentieri perché lo sappiamo che in questa semplicità si annida il senso ultimo del teatro.
Nei dieci giorni della rassegna (www.orizzzontifestival.it) di spettacoli teatrali a Chiusi se ne sono visti molti, e anche di ottimo livello: insieme a Delbono (che qui ha fatto debuttare la versione definitiva del già citato La notte, monologo autobiografico intriso di riferimenti a Koltès), il programma ha proposto, ad esempio, Le Metamorfosi (di forme mutate in corpi nuovi) di Roberto Latini e Thérèse et Isabelle di Valter Malosti, oltre ad alcune produzioni affidate alla giovane Compagnia Festival Orizzonti e a una nutrita rosa di attività laboratoriali. Non da meno tuttavia il cartellone della danza (basti sottolineare la presenza di Adriana Borriello), quello della musica (ricordo almeno Paolo Fresu e il pianista/collega/amico Roberto Cipelli in stato di grazia e il raffinato concerto barocco intitolato Furie, dolcezze, pianti e tormenti) e quello molto corposo dell’opera lirica, snodatosi in due allestimenti di calibro quali Cavalleria rusticana di Mascagni e La voix humaine di Poulenc (per il quale rimando al pezzo di Matteo Brighenti La mia storia d’amore con la voce: intervista a Tiziana Fabbricini pubblicato su PAC il 9 agosto) . A chiudere la manifestazione, una serata/intervista a Franca Valeri condotta live da Pino Strabioli e straripante di aneddoti, ricordi, arguzia, intelligenza e sincera commozione.
E se non è mio compito stare qui a cantare le lodi di un festival che senza dubbio ha mostrato una compattezza di visione (e di “intenzione”) molto forte, mi sembra tuttavia importante anticipare qualcosa sul prossimo anno, convinta che la continuità di un progetto artistico come questo sia comunque segno di lungimiranza e impegno culturale appassionato. “Orizzonti 20016 si intitolerà #follia – chiarisce Cigni – e su questo tema lasceremo ampia libertà agli artisti coinvolti. Proseguirà il percorso già intrapreso dalla Compagnia del Festival e apriremo la vetrina con un’opera lirica molto ambiziosa, un allestimento della Traviata di Verdi con un’orchestra di quaranta elementi, buona parte dei quali giovani musicisti provenienti da diversi conservatori italiani. Mi sento di dire che vogliamo essere un piccolo spicchio di luce nel panorama dei festival nazionali e che il coraggio di fare certe scelte non ci mancherà”. Sul fronte prettamente teatrale ancora tutto top secret: “per ora – mi confida il direttore artistico – posso solo svelare la presenza di Babilonia Teatri con una nuova produzione e il ritorno di Roberto Latini”.









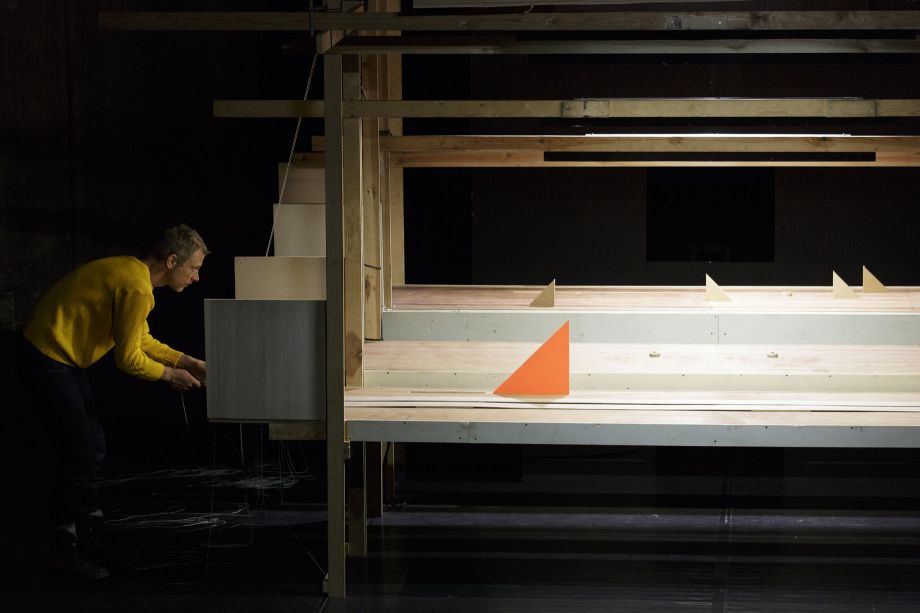



 RENZO FRANCABANDERA | Continuiamo a ripercorrere l’estate teatrale in Italia e non solo, con la narrazione video da Avignone a cura di Valentina Sorte, i reportage sulle compagnie ospiti a Venezia di Ciommiento e Giuliani, e il racconto di alcuni festival italiani che abbiamo frequentato.
RENZO FRANCABANDERA | Continuiamo a ripercorrere l’estate teatrale in Italia e non solo, con la narrazione video da Avignone a cura di Valentina Sorte, i reportage sulle compagnie ospiti a Venezia di Ciommiento e Giuliani, e il racconto di alcuni festival italiani che abbiamo frequentato.
 VALENTINA SORTE | La 69° edizione del Festival d’Avignone ha messo al centro delle sue riflessioni l’Altro: “Je suis l’autre”. E Thomas Ostermeier con il suo Riccardo III moderno e sopra le righe ha interpretato perfettamente questa istanza di alterità.
VALENTINA SORTE | La 69° edizione del Festival d’Avignone ha messo al centro delle sue riflessioni l’Altro: “Je suis l’autre”. E Thomas Ostermeier con il suo Riccardo III moderno e sopra le righe ha interpretato perfettamente questa istanza di alterità.