 ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo incontrato Àlex Serrano, fondatore di Agrupación Serrano (Barcellona) ospite con lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” a Mirabilia Festival, una rassegna internazionale attiva da anni incentrata sull’interazione delle arti performative, circensi, figurative e di strada. Una festa progettuale, a meno di un’ora da Torino, con una programmazione consistente che genera e rafforza relazioni tra realtà italiane ed estere, proponendo spettacoli e incontri con rappresentanti istituzionali, operatori culturali e artisti indipendenti. Come gli artisti anche il festival si rivela agile e capace di “ascoltare il corpo e il movimento”. In questo pieno ascolto della “strada” non mancano spettatori tenaci pronti a seguire gli spettacoli più interessanti del programma. Così il pubblico si fa coinvolgere in atmosfere variabili dove la crisi del settore non sembra prendere il colore predominante. Il risultato è l’entusiasmo e la perseveranza dello staff e degli artisti, con la conseguente reazione attiva di spettatori e operatori.
ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo incontrato Àlex Serrano, fondatore di Agrupación Serrano (Barcellona) ospite con lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” a Mirabilia Festival, una rassegna internazionale attiva da anni incentrata sull’interazione delle arti performative, circensi, figurative e di strada. Una festa progettuale, a meno di un’ora da Torino, con una programmazione consistente che genera e rafforza relazioni tra realtà italiane ed estere, proponendo spettacoli e incontri con rappresentanti istituzionali, operatori culturali e artisti indipendenti. Come gli artisti anche il festival si rivela agile e capace di “ascoltare il corpo e il movimento”. In questo pieno ascolto della “strada” non mancano spettatori tenaci pronti a seguire gli spettacoli più interessanti del programma. Così il pubblico si fa coinvolgere in atmosfere variabili dove la crisi del settore non sembra prendere il colore predominante. Il risultato è l’entusiasmo e la perseveranza dello staff e degli artisti, con la conseguente reazione attiva di spettatori e operatori.
Tra gli spettacoli più interessanti di questa edizione il gruppo di Aléx Serrano, pronto a ricevere a Venezia il Leone d’Argento alla Biennale Teatro come una delle realtà artistiche più innovative del momento. Proprio nei giorni del festival la rivista di costume Vanity Fair pubblica un articolo-omaggio riassumendo la loro storia in un titolo esemplare (“Ci capiscono anche le zie”), rivelando una poetica fatta di linguaggi figurativi, scenici e video senza rinunciare a una narrazione comprensibile.
 Lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” racconta la realtà come bolla che si muove e incontra altre bolle generando esplosioni. Questa visione contraddistingue tutto il vostro lavoro o risulta specifico di questo spettacolo?
Lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” racconta la realtà come bolla che si muove e incontra altre bolle generando esplosioni. Questa visione contraddistingue tutto il vostro lavoro o risulta specifico di questo spettacolo?
A livello drammaturgico quello che abbiamo fatto nei nostri ultimi tre spettacoli – e anche in quest’ultimo (“The House in Asia”) che porteremo alla Biennale Teatro di Venezia – è parlare di un tema centrale attraverso temi marginali. Nel caso di “Brickman Brando Bubble Boom” abbiamo provato a parlare di casa e della differenza tra “casa” (house) e “hogar” (home). Per farlo non volevamo raccontare la crisi direttamente, allora abbiamo cercato una scusa concreta. Crediamo che la migliore maniera per parlare di un tema doloroso non sia attaccare quel tema difficile ma le sue forme marginali. Attraverso Marlon Brando, personaggio reale, e John Brickman, personaggio inventato, raccontiamo la bolla economica e ipotecaria spagnola di questi anni.
Fin dall’inizio lo spettatore è convinto di “conoscere” ciò che si racconterà, prendiamo a esempio la vita di Marlon Brando, ma quello che scoprirà sarà gradualmente l’altra faccia della star cinematografica…
La prima cosa che facciamo vivere agli spettatori è la dimensione del “voyeur”, quello che ci interessa di Marlon Brando è l’altro Marlon Brando. Quello che ci interessa sapere di John Brickman (personaggio inventato da noi) è che era un ragazzo povero che diventa ricco. Ci interessa questa parte perfida e morbosa. Non solo a noi, ma anche agli spettatori.
È un corto circuito, un impatto e uno scontro che il pubblico scopre attraverso la vita di questi due protagonisti. Un altro corto circuito è la vostra presenza scenica ibrida. Non sappiamo se siete in scena come performer, attori o personaggi e questo attira l’attenzione di chi guarda…
Pensiamo molto agli “inizi” dei nostri spettacoli. È una maniera di stare in scena quella di non far comprendere se siamo attori, personaggi o performer. Allo stesso modo è una maniera di intendere la scena quella di non far comprendere quando inizia lo spettacolo. In questo modo trasformiamo lo spettatore in complice, come qualcuno che forma parte dello spettacolo. Lo spettatore attiva così automaticamente alcune percezioni: “Che cosa sta succedendo qui? Chi sono loro? Mi stanno sorridendo, si muovono, fanno parte della normalità”. Tutto questo è un ghigno che farà pensare che lo spettacolo inizierà in una forma differente.
 Chi fa teatro oggi ha paura di esplorare liberamente forme differenti…
Chi fa teatro oggi ha paura di esplorare liberamente forme differenti…
Esattamente. Buona parte del nostro teatro è documento, solo che lo spettatore sa già quello che gli piace. In fondo la drammaturgia non è altro che la scusa che usiamo in teatro per nascondere i drammi reali attraverso una storia. Il problema nasce quando noto che c’è qualcosa di reale in forma di idea e qualcuno mi sta buttando questa idea in faccia. Questo è disturbante quando leggo un libro, guardo un film o seguo un’opera teatrale. È disturbante vedere che c’è un’idea che ci avvicina a me e si trasforma in qualcosa di dogmatico. Quando invece stai lì appartato e qualcuno a poco a poco ti inganna, nel senso buono della parola, facendoti avvicinare a un’idea e a un dramma reale senza dogmi, questo diventa molto apprezzabile.
Questo inganno si avvalora grazie agli strumenti utilizzati e all’interazione dei linguaggi. Non solamente il video, la scena e la musica ma anche tutto ciò che potremmo definire gioco di “schermi su schermi”; proiezioni video che avvengono davanti ai nostri occhi e proiettano a loro volta video da smartphone. In più riceviamo dalla scena continui stimoli visivi che attingono al nostro quotidiano – facebook, whatsup, reality shows – contribuendo a un’esplosione visiva complessa ma comprensibile…
Tutto questo riguarda lo strumento che usiamo ogni giorno. Per comunicare utilizziamo un telefono cellulare e non un attore. Ogni giorno utilizziamo siti, skype, facebook, videocamere: sono questi gli strumenti reali che uso con il mio gruppo ogni giorno. In fondo un attore è molto lontano da noi, è qualcosa che non forma parte della nostra vita quotidiana. Lavoro con persone, certo, ma un attore è qualcosa di molto lontano e diverso dalla persona, per questo preferisco usare nei nostri spettacoli un performer o qualcuno che ha le nozioni dell’attore ma che non sia precisamente un attore. Per esempio Diego – nello spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” – è un attore perché fa il Padrino ma non lo è perché sta montando contemporaneamente una casa o sta usando una camera e suonando uno strumento musicale.
È chiaro quindi che la creazione di uno spettacolo non porta solamente al centro l’attore o il tema sviluppato. C’è altro da esplorare…
Serve qualcosa che apprendiamo dai francesi ovvero l’idea di dispositivo. Noi creiamo opere ma l’importante non è l’opera ma il dispositivo. La forma che prende l’opera è come una frangia che ti aiuta a unire concetti, drammaturgie e forme. Questo è molto importante per noi ed è molto importante per un teatro contemporaneo. Il dispositivo è importante perché ti sta forzando a raccogliere i tuoi strumenti e capire che non sono solo i tuoi attori.
Lo spettacolo proietta nella seconda parte della storia una frase: “tutti gli essere umani cercano un luogo dove vivere ma in pochi trovano la propria casa”…
In spagnolo c’è una differenza tra casa (house) e hogar (home) “Casa/House” è come dire condominio, si riferisce all’edificio, a un’idea fisica. “Hogar/Home” si riferisce a un luogo dove rifugiarti dove crei la tua identità e la tua famiglia. In questi anni “house” ha invaso “home”, ma noi abbiamo bisogno di case come identità e famiglie, non solo come edifici. “Hogar” in spagnolo viene da fuoco, un luogo dove c’è un fuoco che ci protegge dagli animali e dalle temperature della notte; solo che oggi la casa si è trasformata solamente in una specie di contratto sociale. Il mercato a poco a poco ha trasformato questo diritto sociale in un diritto artificiale e in un oggetto finanziario, e l’oggetto finanziario in un oggetto di speculazione. Per questo oggi non siamo più possessori di “hogar/home” ma di luoghi finanziari, quindi oggi la mia casa non è il mio luogo dove proteggermi ma un oggetto in cui speculo. Questo è molto pericoloso: quando credo che la mia casa vale in questi termini ma domani varrà di più nonostante io stia vivendo al suo interno, automaticamente scompare l’idea di “hogar/home”.
Alla fine accusate ironicamente gli spettatori – attraverso altre scritte proiettate – di essere persone “deboli” che credono nei sogni e nelle favole sciocche. Perché raccontate le vostre favole con il teatro?
C’è una frase che un artista ha esposto in una mostra: “ci raccontiamo storie per vivere”. È molto importante perché è la chiave del teatro. Abbiamo bisogno di una certa finzione e di una certa menzogna, di una certa favola, di un’idea d’inganno per alimentarci e sopravvivere. Dobbiamo far sopravvivere la nostra immaginazione ogni giorno. All’inizio il nostro Agrupación Serrano era molto concettuale, astratto, visuale e senza una drammaturgia. C’erano immagini e concetti, ma alla fine ci siamo resi conto che serve “raccontare storie per vivere”. Ci serve questo piccolo veleno. In fondo questo è come omeopatia, rivela l’antidoto. Questa idea di racconto e menzogna porta il suo virus dentro.







 Passa qualche giorno. Siamo ancora a Milano. L’odore fresco e deciso della menta si sprigiona dalle foglie che io (Michela) stropiccio un po’ tra le dita mentre mi accovaccio su una coperta distesa sul prato che cresce sul tetto del Superstudiopiù in via Tortona, cuore pulsante del fuori Salone, del fuori Expo ecc. Sono già tutte occupate le sedie sistemate sotto la cupola geodetica in bambù realizzata, ad integrazione del progetto Coltivare la città, sopra il cerchio centrale del simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. La luce serale nel cielo di giugno e un vento leggero che ci induce a coprire le spalle sembrano quasi dare concretezza a tutti i paradigmi filosofici ed estetici a cui questa risaia sul roof fa da cornice e da pretesto. Lascio che il profumo della menta, uno dei dieci odori fondamentali della percezione olfattiva secondo un recente studio di tre ricercatori statunitensi, evapori portato via dal vento, poi mi annuso le dita. Gli odori sono quelli giusti.
Passa qualche giorno. Siamo ancora a Milano. L’odore fresco e deciso della menta si sprigiona dalle foglie che io (Michela) stropiccio un po’ tra le dita mentre mi accovaccio su una coperta distesa sul prato che cresce sul tetto del Superstudiopiù in via Tortona, cuore pulsante del fuori Salone, del fuori Expo ecc. Sono già tutte occupate le sedie sistemate sotto la cupola geodetica in bambù realizzata, ad integrazione del progetto Coltivare la città, sopra il cerchio centrale del simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. La luce serale nel cielo di giugno e un vento leggero che ci induce a coprire le spalle sembrano quasi dare concretezza a tutti i paradigmi filosofici ed estetici a cui questa risaia sul roof fa da cornice e da pretesto. Lascio che il profumo della menta, uno dei dieci odori fondamentali della percezione olfattiva secondo un recente studio di tre ricercatori statunitensi, evapori portato via dal vento, poi mi annuso le dita. Gli odori sono quelli giusti.
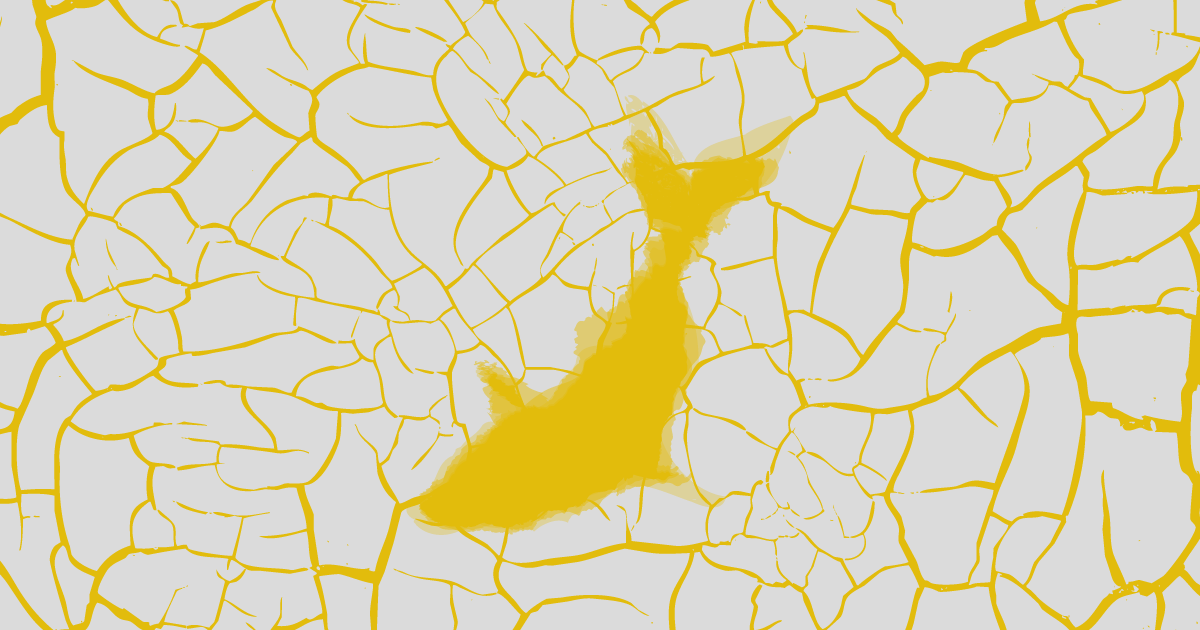
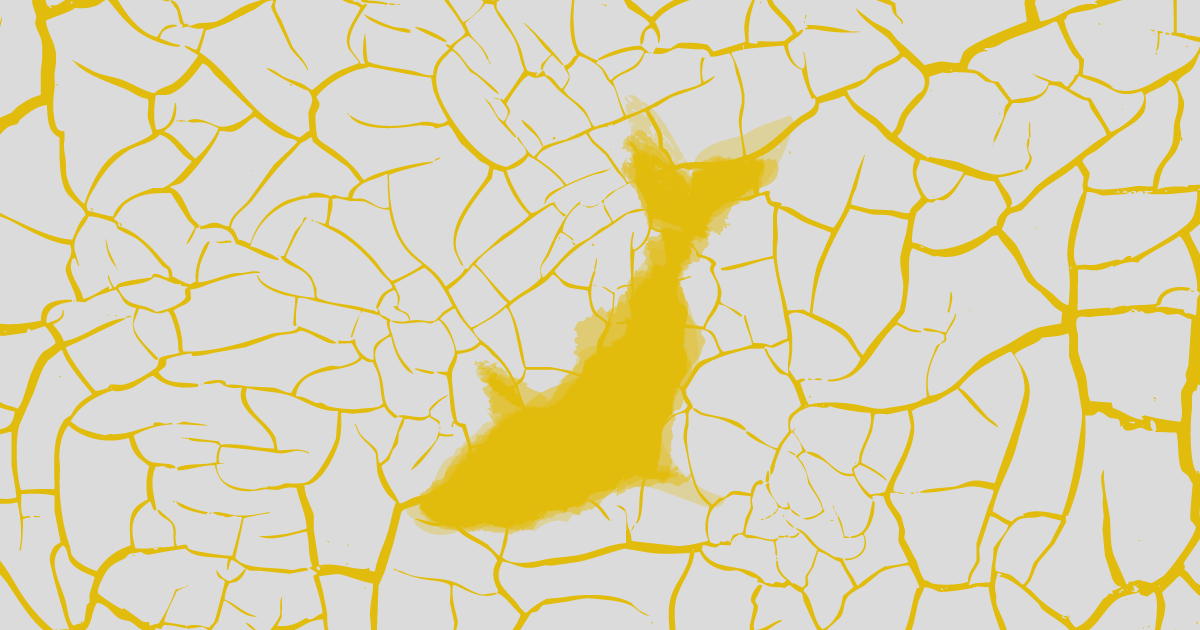




 ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo incontrato Àlex Serrano, fondatore di Agrupación Serrano (Barcellona) ospite con lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” a Mirabilia Festival, una rassegna internazionale attiva da anni incentrata sull’interazione delle arti performative, circensi, figurative e di strada. Una festa progettuale, a meno di un’ora da Torino, con una programmazione consistente che genera e rafforza relazioni tra realtà italiane ed estere, proponendo spettacoli e incontri con rappresentanti istituzionali, operatori culturali e artisti indipendenti. Come gli artisti anche il festival si rivela agile e capace di “ascoltare il corpo e il movimento”. In questo pieno ascolto della “strada” non mancano spettatori tenaci pronti a seguire gli spettacoli più interessanti del programma. Così il pubblico si fa coinvolgere in atmosfere variabili dove la crisi del settore non sembra prendere il colore predominante. Il risultato è l’entusiasmo e la perseveranza dello staff e degli artisti, con la conseguente reazione attiva di spettatori e operatori.
ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo incontrato Àlex Serrano, fondatore di Agrupación Serrano (Barcellona) ospite con lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” a Mirabilia Festival, una rassegna internazionale attiva da anni incentrata sull’interazione delle arti performative, circensi, figurative e di strada. Una festa progettuale, a meno di un’ora da Torino, con una programmazione consistente che genera e rafforza relazioni tra realtà italiane ed estere, proponendo spettacoli e incontri con rappresentanti istituzionali, operatori culturali e artisti indipendenti. Come gli artisti anche il festival si rivela agile e capace di “ascoltare il corpo e il movimento”. In questo pieno ascolto della “strada” non mancano spettatori tenaci pronti a seguire gli spettacoli più interessanti del programma. Così il pubblico si fa coinvolgere in atmosfere variabili dove la crisi del settore non sembra prendere il colore predominante. Il risultato è l’entusiasmo e la perseveranza dello staff e degli artisti, con la conseguente reazione attiva di spettatori e operatori. Lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” racconta la realtà come bolla che si muove e incontra altre bolle generando esplosioni. Questa visione contraddistingue tutto il vostro lavoro o risulta specifico di questo spettacolo?
Lo spettacolo “Brickman Brando Bubble Boom” racconta la realtà come bolla che si muove e incontra altre bolle generando esplosioni. Questa visione contraddistingue tutto il vostro lavoro o risulta specifico di questo spettacolo? Chi fa teatro oggi ha paura di esplorare liberamente forme differenti…
Chi fa teatro oggi ha paura di esplorare liberamente forme differenti…

