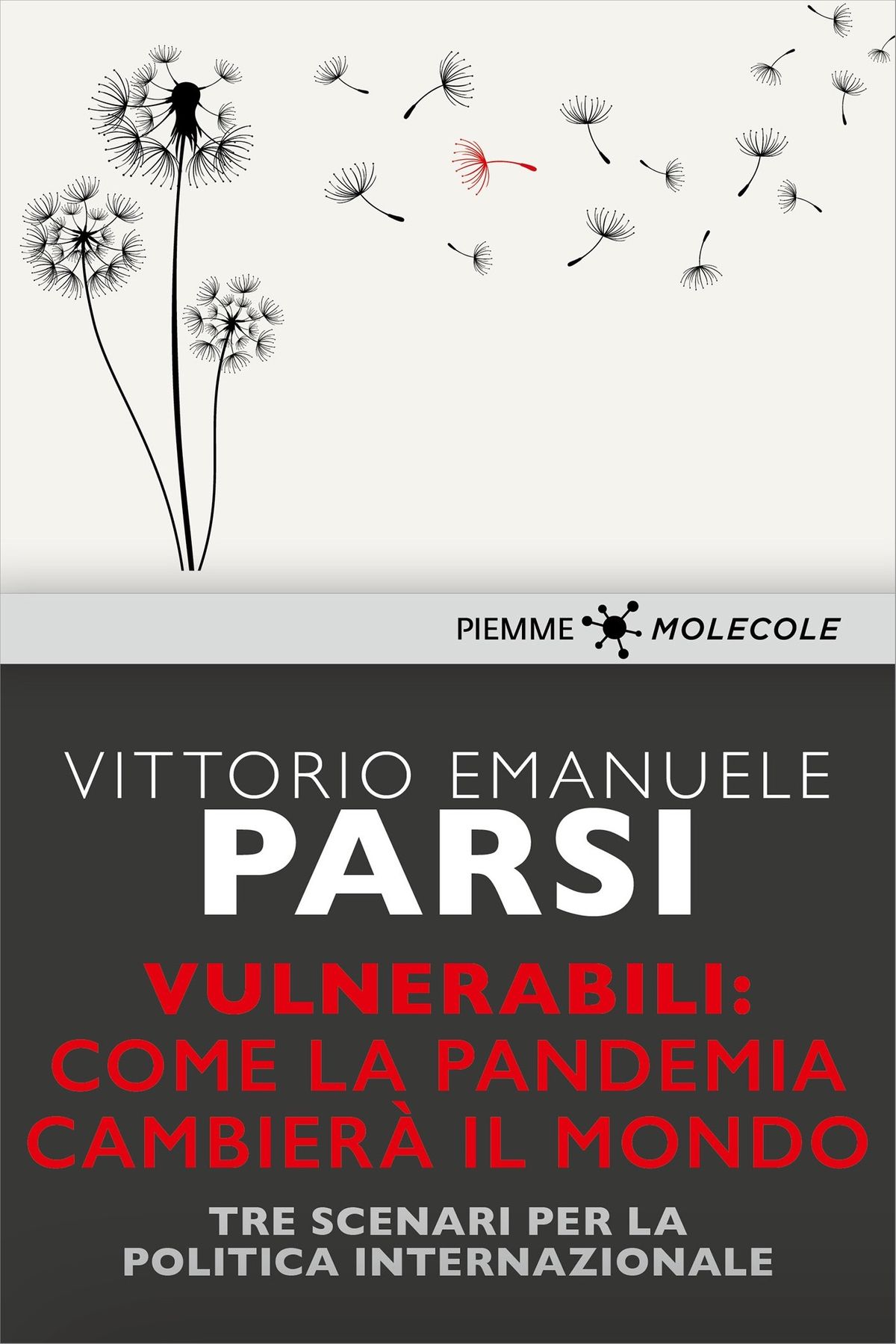ELENA SCOLARI | Vittorio Emanuele Parsi è professore ordinario di Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica, è direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali. I suoi campi di ricerca sono le relazioni transatlantiche, la sicurezza in Medio Oriente, i cambiamenti strutturali del sistema politico internazionale, il rapporto tra democrazia e mercato. Ha tenuto lezioni a Princeton e fa parte del Gruppo di Riflessione Strategica del Ministero degli Affari Esteri. Per fortuna è anche appassionato di moto, di barche e di rugby.
Come si è sentito in questi mesi?
Passato il primo momento di arrabbiatura e spaesamento, devo dire che scrivere mi ha aiutato molto. Prima mi sono sentito smarrito, ma ho un approccio tendenzialmente ottimistico verso le cose e nella settimana di Pasqua, in cinque giorni, ho scritto l’e-book Vulnerabili – come la pandemia cambierà il mondo (edito da Piemme). Quando trovi il bandolo della matassa è come avere un chiodo che ti dà l’appiglio per arrivare in cima.
Avevo le tasche piene di hashtag e di gente che cantava sui balconi, sono sempre infastidito dalla retorica. Noi Italiani non siamo bravi nella retorica civica, quella alta, quella dei bei discorsi di Churchill, Lincoln, Cicerone. Noi siamo sempre lì con il fazzoletto in mano. Ma ero stanco anche di tanti miei colleghi troppo pessimisti, tra gli estremi dobbiamo esercitare la libertà. Io andavo tutti giorni a comprare il pane. Già c’era il lockdown, non ti doveva venire anche lo scorbuto. Fin quando si è potuto camminare io ho camminato, da solo, anche per ore.
Come ci siamo comportati, secondo lei?
Quello che è andato bene è stato frutto di scelte individuali. Il dibattito scientifico avveniva sui mass media e questo lo ha esacerbato, lo ha dirottato, come quando alzi il sasso e le formiche accelerano perché percepiscono l’occhio di chi le guarda. Anche il dibattito scientifico, se avviene in diretta sui media, cambia.
Nella comunicazione, per esempio, la pubblicità sull’Italia che resiste era apprezzabile all’inizio, che i grandi marchi utilizzassero una parte del loro budget per spot in cui il brand stava sullo sfondo faceva sentire il senso di solidarietà che rimbalzava tra noi tutti. Doveva però durare poco, invece da noi si fatica a cambiare registro.
Gli hashtag e gli arcobaleni sono stati un approccio magico. Prendersi carico di una responsabilità è invece un atteggiamento raziocinante, non trova?
La responsabilità è stata una chiave di volta. In certi luoghi i controlli quasi non esistevano e si potevano violare le regole, eppure in pochi lo hanno fatto. Abbiamo capito quanto il singolo possa fare la differenza. In un’ottica poco retorica. Noi abbiamo fermato il virus, dopodiché troppa retorica non va bene ma nemmeno troppo cinismo, che spesso nasconde una sconfitta. La responsabilità individuale ha aperto una logica che ha capovolto l’ordinario: io non esco perché non sapendo se sono malato potrei contagiare un altro, faccio un gesto non di altruismo ma di investimento sulla collettività e in cambio ricevo 60 milioni di azioni.
Non crede che ci sia un certo compiacimento nel sentirsi dentro a una grande fiction alla quale è eccitante partecipare? Con comportamenti codificati, un copione da seguire, un costume da indossare…
Un grande intellettuale come Pasolini diceva che l’Italia è un paese di conformisti. Quando la gente sente di essere nell’onda allora la segue e magari denuncia il prossimo che dissente. Tendiamo a stare con il vincitore. Io spero che ci sia un’estensione del comportamento virtuoso che abbiamo tenuto, sennò ricadremo nel come prima.
In tanti si sono scagliati in maniera furibonda contro i vincoli, a nessuno facevano piacere, ma contrastarli era sbagliato quanto la retorica bolsa. Mi è piaciuto come Mattarella ha gestito l’emergenza: la gravitas della retorica istituzionale è giusta quando sottolinea quello che di buono si sta facendo senza sbrodolare troppo.
Come ha scelto l’aggettivo “vulnerabile” per il titolo del suo e-book?
La scelta di questa parola chiave è stata risolutiva: vulnerabili non nel senso del piagnisteo. In questo sistema di interdipendenza complesso che è la globalizzazione abbiamo sperimentato che l’elemento umano ha dovuto adattarsi in termini di mobilità: quello che si muove rapidamente vale più di quello che fatica a muoversi. Soldi, merci, persone. La globalizzazione non si era mai fermata prima di questi due mesi a causa di un virus, il sistema era debole in sé e si è mostrato debole per lo stress cui è stato sottoposto.
Ho pensato alla metafora della nave, un sistema di interdipendenze e di ridondanze create per la sicurezza: nessuno progetterebbe una nave pensando che la protezione dell’equipaggio sia un lusso. Sapere di essere vulnerabili, quindi, è il punto di partenza per costruire un sistema che ci protegga. Dobbiamo pretendere più protezione altrimenti saremo sempre vulnerabili, davanti agli choc finanziari, all’immigrazione.
La coscienza della nostra modestia deve spingere non a nasconderci sotto un sasso, ma a essere prometeici in quello che chiediamo alla vita e alla politica.
La pandemia ci ha fatto diventare grandi? Abbiamo passato la linea d’ombra?
Sì, se saremo abbastanza forti da battere i pugni sul tavolo perché potere e ricchezza non siano più concentrati nelle mani di pochi. L’egemonia culturale ci ha convinto che non ci fosse altra visione di mondo possibile, che potessimo solo appiattirci su un modello dato, ma l’evento è stato talmente scioccante per la collettività da offrirci qualche chance di sfruttarlo a nostro favore, anche se il tentativo già in corso sembra essere quello di tornare al mondo di ieri. La pandemia però ci ha insegnato che tutti possiamo morire ma non tutti nella stessa maniera e con la stessa probabilità: tra Manhattan e il Bronx, separati da nulla, il tasso di mortalità è stato doppio tra un quartiere e l’altro. Questo ci indica su cosa dobbiamo lavorare.
I pesi specifici di America e Cina cambieranno nella bilancia internazionale?
Sì, è possibile. Però bisogna che mutino altre cose nel sistema finanziario ed economico globale. Se il mondo resta “un universale” con questi due contendenti le differenze si assottigliano. Il vero cambiamento avviene solo se si modifica la relazione tra cose e persone, ci vorrebbe una rivoluzione come quella dell’Umanesimo nel Rinascimento.
E questo è un punto politico: indicare che la convergenza non avviene sulle singole posizioni ma si trova su una posizione che prende forma perché viene costruita dai singoli, insieme. La politica deve indicare questa via.
Vuole spiegarci meglio i cardini di questa rivoluzione?
Bisogna riconquistare l’egemonia culturale, cambiare il pensabile. Negli anni ’70 l’inflazione e la crisi petrolifera cambiarono il modo di guardare alle cose. Si è radicato un sistema che partiva dall’offerta e non dalla domanda. L’offerta la fa un soggetto solo e la domanda la fanno in molti, questo ribaltamento ha fatto sì che la spinta libertaria del ‘68 sia stata trasformata in spinta individualista: realizzi il tuo spirito libero nella dimensione economica.
Era più facile riflettere nella sospensione del mondo intorno a noi, ora che riprende la routine la tentazione di ri-cominciare e non di cominciare qualcosa di nuovo è fortissima.
Chi vuole evitare che gli assetti vengano toccati sa di poter contare sulla naturale tendenza degli esseri umani a protrarre nel tempo una situazione di vantaggio, economico e politico.
Noi siamo i protagonisti necessari della nostra vita e abbiamo un’inestirpabile voglia di sopravvivere, dobbiamo però costruire un ragionamento basato sul beneficio del maggior numero, su princìpi di equità e giustizia.
Al momento sembra però di vedere una tensione alla restaurazione, non a una rivoluzione. Secondo lei cambieranno le relazioni tra Paesi, tra l’Italia e l’Europa?
Le contraddizioni si sono esasperate negli ultimi quarant’anni. Certo, l’Europa poteva fare meglio, fare prima… Lo strumento del recovery fund però è rivoluzionario. Può essere poco, forse arriverà tardi, ma l’idea di dare denaro a fondo perduto e che il destinatario di questa misura non debba rispondere della restituzione è un principio del tutto nuovo che sarebbe stato impossibile solo tre mesi fa. Ci si chiede di fare riforme non di natura finanziaria ma investimenti trasformativi del tessuto economico. E quanto ha bisogno l’Italia di trasformarsi!
A questa grande novità si è arrivati anche grazie all’Italia, abbiamo avuto il merito oggettivo di indicare un punto di unione.
Il sovranismo è battuto?
L’unica certezza è che nessuno si salva sa solo. La cooperazione è difficile, ci vogliono umiltà e prometeicità: io voglio vincere anche se ho davanti gli All Blacks.
I sovranisti l’hanno avuta facile prima perché era comodo denigrare un’Europa scadente e una Germania con scarsa capacità di leadership, ma ora che abbiamo visto l’Europa lavorare per costruire una prospettiva migliore, un progetto più grande, gli sbruffoni cadono, si incrina il loro consenso.
Se l’Europa ha fatto qualche passo avanti non sembra altrettanto per l’America di queste settimane.
La pagina del New York Times con l’elenco dei morti per Covid è stata una rievocazione del Vietnam. Allora la società era unita contro la Casa Bianca di Nixon per il disastro del Vietnam, ma era divisa su tutto il resto. Ora la società è unita contro la gestione delirante della pandemia da parte di Trump, ma non è unita su molto altro.
Chi è nella posizione dominante ha il controllo delle cose. Chi ha il potere cerca di tenerlo e chi non ce l’ha cerca di scalzarlo, ma bisogna tornare a battersi e chiedersi quanta disuguaglianza è accettabile in una società? Ci vuole uno sforzo di ripensamento delle categorie interpretative.
Non ci sarebbe stato un New Deal senza la crisi del ’29. Se anche avessero eletto comunque Roosevelt lo avrebbero eletto con un’agenda diversa. Il New Deal si occupava di problemi che esistevano da cinquant’anni, anche le riforme da fare adesso dovrebbero risolvere squilibri presenti da decenni, non l’emergenza di oggi.
Il lavoro culturale, chi fa pensare o induce dubbi anche in maniera spigolosa avrà più spazio?
Lo spero, perché la cultura non agisce solo in maniera diretta nel proprio settore, la politica stessa cambia se segue i cambiamenti culturali esterni. Dobbiamo tornare a pensare che tentare di cambiare qualcosa è importante. Il disincanto non è il cinismo, non è rassegnazione. Un minimo di idealismo!