FRANCESCA GIULIANI | In occasione della prova aperta a L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino abbiamo incontrato Licia Lanera / Fibre Parallele. Dai 10 anni della compagnia all’adattamento drammaturgico di Orgia che debutta domani al Festival delle Colline Torinesi, l’artista barese ci ha accompagnato nel percorso che l’ha portata alla messa in scena del testo che Pier Paolo Pasolini scrisse nel 1966.
Da Mangiami l’anima e poi sputala a La Beatitudine quali sono i momenti di svolta in questi 10 anni di Fibre Parallele?
Mangiami l’anima e poi sputala è il primo spettacolo. Daniele Timpano lo vide alle semifinali del premio “Scenario” e ci propose di partecipare all’ultima edizione di “Ubusettete” a Roma. 2.(DUE) fu uno spettacolo gettonatissimo, che ancora gira ma di cui vorrei liberarmi. La svolta venne con Furie de Sanghe, il primo con una produzione, in un teatro con altri attori. È in questo momento che si sono definiti meglio anche i nostri ruoli – drammaturgo Riccardo e regista io. Poi Duramadre che ha avuto una serie di brutte vicissitudini produttive e non solo. È uno dei lavori meno riusciti ma da qui si generò una crisi che portò al nostro lavoro più solido e compiuto, Lo splendore dei supplizi. La beatitudine ha segnato altri momenti difficili che riguardavano la nostra vita privata, la nostra separazione come coppia. È uno spettacolo fatto in un tempo lampo ma molto compiuto, raffinato, che denota come dopo tanti anni abbiamo sviluppato un metodo di lavoro molto solido.
E ora Pasolini.
Orgia nasce su commissione. Rodolfo di Giammarco mi invita alla rassegna “Garofano Verde” consigliandomi la lettura di Orgia e proponendomi di fare l’uomo. Con lui avevamo già collaborato per “Trend”, la rassegna sulla nuova drammaturgia inglese, dove avevamo messo in scena il testo di Edward Bond Have I non.  Quando lessi il testo di Pasolini rimasi folgorata perché alcune cose del testo erano in forte connessione a come mi sentivo in quel momento della mia vita. Lo trovai molto appartenente e decisi di farne l’adattamento drammaturgico. A Roma feci una “lettura agita” La donna nell’uomo che andò molto bene e Antonio Calvi mi chiese di metterlo in scena nella stagione successiva. Questi furono gli input che mi spinsero a terminarlo. Per una questione di diritti ho utilizzato il testo integrale e si è presentata la sfida per come metterlo in scena, come sviluppare entrambi i ruoli, come trovare una forma unica, se avere o no un’altra attrice per il ruolo della ragazza. Io vivo da un lato la gioia di aver dominato un testo e di averne fatto una regia assolutamente mia dall’altro il terrore di essermi confrontata con un autore così mastodontico e di averlo in qualche modo destrutturato nella sua forma teatro anche se la lingua è quella, io non ho aggiunto una parola e non ho cambiato nulla. La mia autorialità, nonostante sia molto forte, in Orgia è puramente registica. Praticare quella parola e tenerla sempre viva è stato un lavoro attoriale molto faticoso.
Quando lessi il testo di Pasolini rimasi folgorata perché alcune cose del testo erano in forte connessione a come mi sentivo in quel momento della mia vita. Lo trovai molto appartenente e decisi di farne l’adattamento drammaturgico. A Roma feci una “lettura agita” La donna nell’uomo che andò molto bene e Antonio Calvi mi chiese di metterlo in scena nella stagione successiva. Questi furono gli input che mi spinsero a terminarlo. Per una questione di diritti ho utilizzato il testo integrale e si è presentata la sfida per come metterlo in scena, come sviluppare entrambi i ruoli, come trovare una forma unica, se avere o no un’altra attrice per il ruolo della ragazza. Io vivo da un lato la gioia di aver dominato un testo e di averne fatto una regia assolutamente mia dall’altro il terrore di essermi confrontata con un autore così mastodontico e di averlo in qualche modo destrutturato nella sua forma teatro anche se la lingua è quella, io non ho aggiunto una parola e non ho cambiato nulla. La mia autorialità, nonostante sia molto forte, in Orgia è puramente registica. Praticare quella parola e tenerla sempre viva è stato un lavoro attoriale molto faticoso.
È cambiato l’immaginario di riferimento in questi 10 anni?
Non è tanto cambiato. Prima eravamo molto carichi di quell’immaginario pop che già da Furie de Sanghe si è più rarefatto. C’è sempre l’immaginario della violenza. È cambiato il nostro modo di lavorare, è come se avessimo raffinato il palato con gli anni, gli incontri, le letture, gli spettacoli visti – noi che non abbiamo seguito nessuna scuola di teatro siamo stati degli spettatori accaniti. Per me l’incontro con Ronconi ha segnato un passaggio come attrice e come regista. Se non lo avessi incontrato non so se sarei riuscita a fare La beatitudine, ma sicuramente non sarei riuscita a mettere in scena Orgia come l’ho fatto oggi sia registicamente sia attorialmente.
La figura retorica dell’ossimoro sembra caratterizzare la vostra poetica: in Orgia è forte la commistione tra immaginario pop e pittura seicentesca. È il contrasto necessario a creare il cortocircuito in teatro?
Mi piace che il teatro, che dovrebbe raccontare la vita, crei questo cortocircuito che nel quotidiano c’è sempre. In più si sta sviluppando anche un esercizio di stile rispetto a questo elemento. Esteticamente cerco la commistione tra basso e alto. In Furie de Sanghe c’è la scena più cruda della violenza sessuale fatta su una canzone popolare barese; in Orgia c’è la replica del Caravaggio che crea questo contrasto con Eminem e il mondo del rap.
Quando e come sposti la tua attenzione durante la creazione allo sguardo dello spettatore?
Sempre. Per me il teatro è un mezzo innanzitutto politico in quanto fa parte della polis. È un’arte comunicativa e se non comunica perché è difficile, ermetico, non si sa spiegare non è riuscito. Io sono per un teatro popolare nel senso di Leo de Berardinis, un teatro che possa parlare a tutti. Se non riesce ad arrivare si perde il suo essere atto rivoluzionario. Sono molto per l’empatia, ci si deve emozionare, si deve entrare in una storia, non amo gli spettacoli che svelano continuamente il meccanismo scenico. In Orgia manca la contrapposizione tra l’elemento alto e basso, quell’aspetto popolare che aggancia, non in senso ruffiano ma nel prendere per mano lo spettatore per portarlo nel mondo più alto. È il testo a essere così: l’ironia non c’è quindi io spingo attorialmente l’acceleratore sul sarcasmo per rendere la parola più concreta perché ho il terrore di essere troppo elitaria.
Orgia
di Pier Paolo Pasolini.
con Licia Lanera
e Nina Martorana
regista assistente Danilo Giuva
consulenza artistica Alessandra Di Lernia
luci Vincent Longuemare
costumi Antonio Piccirilli
dipinti Giorgio Calabrese
tecnico di produzione Amedeo Russi
assistente tecnico Cristian Allegrini
organizzazione Antonella Dipierro
regia e spazio Licia Lanera
produzione Fibre Parallele
coproduzione Festival delle Colline Torinesi, CO&MA Soc. Coop. Costing & Management
e con il sostegno di L’Arboreto – Teatro Dimora di Mondaino
si ringrazia Garofano Verde


 i, che questa volta cede il suo ruolo di Lopachin (a un ottimo Federico Vanni) e si concentra sulla regia, ce lo propone così: con un testo fedele, di cui ha curato anche la traduzione, con costumi eleganti e con una scenografia che sembra pensata per creare spazi (anche non visibili) e accogliere un cast di 12 attori senza mai appesantire lo spazio scenico. Le azioni, che si svolgono principalmente nella stanza dei bambini, continuano anche fuori dalla villa e in altre stanze, anche se ne vediamo solo le porte e le luci (di Nando Frigerio) che penetrano dalle finestre. Un’atmosfera calda, come dev’essere quella di una casa che è luogo di riunione per una famiglia non sempre unita, luogo di ricordi nostalgici e ultimo appiglio prima della rovina e del cambiamento. I mobili e i quadri dei primi due atti si diradano negli ultimi due, cedendo il posto a sedie e bauli; pochi oggetti che simboleggiano una decadenza economica e uno spostamento, fisico e psicologico. Il suono di un pendolo è un frequente sottofondo, e risalta ancor più nei diversi momenti di pausa, come dei fermo-immagine, che il regista inserisce soprattutto nella prima metà dello spettacolo, per mettere a fuoco i momenti più rilevanti. Ed è di nuovo un effetto sonoro (se ne cura Jean-Christophe Potvin) che ci annuncia, nell’ultimo atto, l’abbattimento dei ciliegi del giardino, per mano di Lopachin, il nuovo proprietario della villa.
i, che questa volta cede il suo ruolo di Lopachin (a un ottimo Federico Vanni) e si concentra sulla regia, ce lo propone così: con un testo fedele, di cui ha curato anche la traduzione, con costumi eleganti e con una scenografia che sembra pensata per creare spazi (anche non visibili) e accogliere un cast di 12 attori senza mai appesantire lo spazio scenico. Le azioni, che si svolgono principalmente nella stanza dei bambini, continuano anche fuori dalla villa e in altre stanze, anche se ne vediamo solo le porte e le luci (di Nando Frigerio) che penetrano dalle finestre. Un’atmosfera calda, come dev’essere quella di una casa che è luogo di riunione per una famiglia non sempre unita, luogo di ricordi nostalgici e ultimo appiglio prima della rovina e del cambiamento. I mobili e i quadri dei primi due atti si diradano negli ultimi due, cedendo il posto a sedie e bauli; pochi oggetti che simboleggiano una decadenza economica e uno spostamento, fisico e psicologico. Il suono di un pendolo è un frequente sottofondo, e risalta ancor più nei diversi momenti di pausa, come dei fermo-immagine, che il regista inserisce soprattutto nella prima metà dello spettacolo, per mettere a fuoco i momenti più rilevanti. Ed è di nuovo un effetto sonoro (se ne cura Jean-Christophe Potvin) che ci annuncia, nell’ultimo atto, l’abbattimento dei ciliegi del giardino, per mano di Lopachin, il nuovo proprietario della villa. Perfino la natura la cospirato contro, con le raffiche di vento che l’inverno scorso hanno danneggiato in modo irreparabile la tensostruttura. A quel punto pare quasi di vederli gli amministratori, da tempo interessati a mettere a reddito la struttura distogliendola dagli attuali scopi di residenza culturale multidisciplinare, stringere le spalle e dire: “Che peccato, ma così proprio non si può”, aprendo così il Castello ad un esercito di spadellanti festosi a caccia di show cooking. Mentre il buon Claudio Morganti, interrotto nelle sue prove al castello dai fumi del soffritto, come Girolamo Savonarola, lanciava dal suo sito moniti alla morale, la pubblica amministrazione della nota località turistica Toscana ha deciso che il dado era ormai tratto, che nel parco del castello sorgerà una grande arena per eventi da migliaia di persone, di quelli che portano i soldi veri, non quella roba da straccioni del teatro italiano. Roba grossa, Panarielli, spettacolazioni.
Perfino la natura la cospirato contro, con le raffiche di vento che l’inverno scorso hanno danneggiato in modo irreparabile la tensostruttura. A quel punto pare quasi di vederli gli amministratori, da tempo interessati a mettere a reddito la struttura distogliendola dagli attuali scopi di residenza culturale multidisciplinare, stringere le spalle e dire: “Che peccato, ma così proprio non si può”, aprendo così il Castello ad un esercito di spadellanti festosi a caccia di show cooking. Mentre il buon Claudio Morganti, interrotto nelle sue prove al castello dai fumi del soffritto, come Girolamo Savonarola, lanciava dal suo sito moniti alla morale, la pubblica amministrazione della nota località turistica Toscana ha deciso che il dado era ormai tratto, che nel parco del castello sorgerà una grande arena per eventi da migliaia di persone, di quelli che portano i soldi veri, non quella roba da straccioni del teatro italiano. Roba grossa, Panarielli, spettacolazioni. Nella città della “fighissima” Biennale, dove ogni spettacolo viene proposto per una sola replica con costi esorbitanti, un ridicolo contributo di pochi spiccioli ha stretto il nodo al collo di Fondamenta Nuove, che ha provato a mantenere il suo progetto attivo per tutto il 2015, riducendo gli appuntamenti per non far venir meno la qualità: ma la resistenza non può andare avanti ad oltranza; Enrico Bettinello, succeduto nel 2008 a Massimo Ongaro dichiara: «Concludiamo addolorati questa avventura con la rinnovata convinzione che Venezia abbia bisogno di politiche culturali innovative e coraggiose, che la sua doverosa centralità sulla scena artistica e culturale europea non possa essere lasciata solamente alle grandi istituzioni ma che, come in ogni altro centro di eccellenza culturale che si rispetti, debba passare anche attraverso progettualità e strategie di sistema che al momento ci sembra di non scorgere sul territorio». Sono stati ospitati fra queste mura Uri Caine e Virgilio Sieni (beffardamente diventati poi anche direttori di Biennale), Matmos e Carolyn Carlson, e tanti altri da Teho Teardo ai Santasangre, Romeo Castellucci, i Konono n.1, Fennesz, Accademia degli Artefatti, Barcelò, Thurston Moore, Roy Paci… E ancora produzioni e residenze. Insomma mentre il premier sfreccia in motoscafo sul Canal Grande, la Venezia dei progetti che dovrebbero rendere l’Italia quel magnifico incubatore di eccellenza del fare, ecco, quella Venezia lì imbarca acqua.
Nella città della “fighissima” Biennale, dove ogni spettacolo viene proposto per una sola replica con costi esorbitanti, un ridicolo contributo di pochi spiccioli ha stretto il nodo al collo di Fondamenta Nuove, che ha provato a mantenere il suo progetto attivo per tutto il 2015, riducendo gli appuntamenti per non far venir meno la qualità: ma la resistenza non può andare avanti ad oltranza; Enrico Bettinello, succeduto nel 2008 a Massimo Ongaro dichiara: «Concludiamo addolorati questa avventura con la rinnovata convinzione che Venezia abbia bisogno di politiche culturali innovative e coraggiose, che la sua doverosa centralità sulla scena artistica e culturale europea non possa essere lasciata solamente alle grandi istituzioni ma che, come in ogni altro centro di eccellenza culturale che si rispetti, debba passare anche attraverso progettualità e strategie di sistema che al momento ci sembra di non scorgere sul territorio». Sono stati ospitati fra queste mura Uri Caine e Virgilio Sieni (beffardamente diventati poi anche direttori di Biennale), Matmos e Carolyn Carlson, e tanti altri da Teho Teardo ai Santasangre, Romeo Castellucci, i Konono n.1, Fennesz, Accademia degli Artefatti, Barcelò, Thurston Moore, Roy Paci… E ancora produzioni e residenze. Insomma mentre il premier sfreccia in motoscafo sul Canal Grande, la Venezia dei progetti che dovrebbero rendere l’Italia quel magnifico incubatore di eccellenza del fare, ecco, quella Venezia lì imbarca acqua. Deve essere la vicinanza al mare che non fa bene al teatro se è vero che, e qui chiudiamo questa piccola rassegna delle difficoltà della scena italiana, anche esperimenti ricchi di successo e pubblico come il particolarissimo Festival di nuovi linguaggi del teatro Terreni Creativi, che si tiene ad inizio Agosto in Liguria, è in sofferenza. L’alternativa culturale che Kronoteatro in questi sei anni ha garantito al territorio di Albenga, un bellissimo festival in cui teatro, convivialità e profumi delle serre si fondono, in cui il basilico d’estate inebria le narici degli spettatori, adesso solleva bandiera bianca. Cioè, non proprio.
Deve essere la vicinanza al mare che non fa bene al teatro se è vero che, e qui chiudiamo questa piccola rassegna delle difficoltà della scena italiana, anche esperimenti ricchi di successo e pubblico come il particolarissimo Festival di nuovi linguaggi del teatro Terreni Creativi, che si tiene ad inizio Agosto in Liguria, è in sofferenza. L’alternativa culturale che Kronoteatro in questi sei anni ha garantito al territorio di Albenga, un bellissimo festival in cui teatro, convivialità e profumi delle serre si fondono, in cui il basilico d’estate inebria le narici degli spettatori, adesso solleva bandiera bianca. Cioè, non proprio.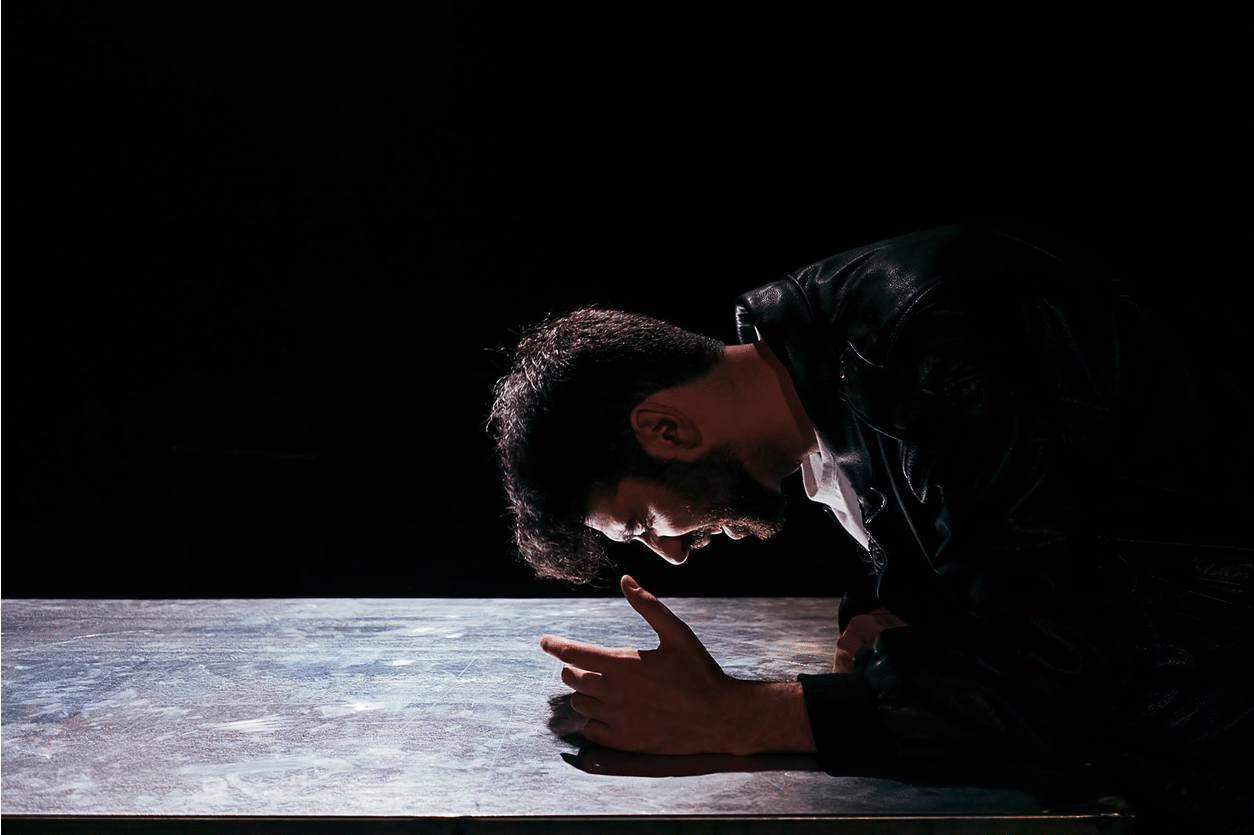

 MATTEO BRIGHENTI | “Il motto del Murialdo: Fare e tacere”. Poche e semplici parole su una targa in pietra, affissa a uno dei muri esterni di San Pio X, all’angolo tra via Bellini e largo Murialdo, 20 minuti a piedi dal Duomo di Modena. La chiesa parrocchiale fa parte della Congregazione di San Giuseppe, fondata da San Leonardo Murialdo, sacerdote nella Torino di metà e fine ’800 che si interessò dei giovani di strada, dei carcerati, e degli oratori, insieme con San Giovanni Bosco, cui è intitolato il parchetto a fianco della chiesa. Non poteva che essere qui, in questo rettangolo che cerca e custodisce il sacro nel profano, il cuore pulsante di
MATTEO BRIGHENTI | “Il motto del Murialdo: Fare e tacere”. Poche e semplici parole su una targa in pietra, affissa a uno dei muri esterni di San Pio X, all’angolo tra via Bellini e largo Murialdo, 20 minuti a piedi dal Duomo di Modena. La chiesa parrocchiale fa parte della Congregazione di San Giuseppe, fondata da San Leonardo Murialdo, sacerdote nella Torino di metà e fine ’800 che si interessò dei giovani di strada, dei carcerati, e degli oratori, insieme con San Giovanni Bosco, cui è intitolato il parchetto a fianco della chiesa. Non poteva che essere qui, in questo rettangolo che cerca e custodisce il sacro nel profano, il cuore pulsante di 



