SILVIA TORANI |  Ci domandiamo che senso abbia oggi assistere a uno spettacolo come La bella addormentata nel bosco, al Teatro dell’Opera di Roma fino al primo giugno. È solo uno status symbol? Una conferma autoreferenziale della nostra identità culturale? Un recupero nostalgico di un passato che non c’è più? Perché in questa versione del 2002, da allora riproposta ciclicamente ogni due, tre anni, il coreografo Paul Chalmer non si allontana dall’imponente e magnifica ombra di Marius Petipa?
Ci domandiamo che senso abbia oggi assistere a uno spettacolo come La bella addormentata nel bosco, al Teatro dell’Opera di Roma fino al primo giugno. È solo uno status symbol? Una conferma autoreferenziale della nostra identità culturale? Un recupero nostalgico di un passato che non c’è più? Perché in questa versione del 2002, da allora riproposta ciclicamente ogni due, tre anni, il coreografo Paul Chalmer non si allontana dall’imponente e magnifica ombra di Marius Petipa?
Non siamo ancora stanchi dei principi stranieri stereotipati, con la pelle di leopardo sulla schiena seminuda? Delle principesse adolescenti, ingenue e fiduciose? Vogliamo ancora vedere teli trasparenti che calano atmosfere oniriche sul palco?
Eppure altre strade si sono tentate. Conosciamo l’Aurora disagiata e ribelle di Mats Ek, punta dal fuso della droga per cadere preda di un sonno senza sogni; ricordiamo le tinte gotiche della Belle di Jean-Christophe Maillot. Ma il problema delle rivisitazioni contemporanee è che spesso non ci dicono molto di più, non aggiungono latenze che non fossero già presenti nell’originale. Senza allontanarci dal canone del balletto classico, perfino un lavoro poetico, scanzonato e ironico come Swan Lake, della giovanissima (e bravissima) coreografa sudafricana Dada Masilo, in scena al Teatro Argentina lo scorso novembre, rende esplicite tensioni omosessuali già insite nell’amore “diverso” che porta il principe a rifiutare le belle pretendenti cui i genitori lo vorrebbero fidanzato per inseguire la chimera di un cigno.
La moda delle attualizzazioni, interessanti se intelligenti, e pur sempre lecite, rischia di togliere tutto il piacere al pubblico, la soddisfazione di leggere tra le righe, di costruirsi la sua storia, di andare oltre quell’apparente banalità del visibile. Certo, resta il piacere della danza. Ma quello rimane anche nel più classico dei classici.
L’Aurora delle prove generali è dolce, a tratti leziosa. Incerta nel difficile Adagio della Rosa, recupera durante il grande passo a due del terzo atto, preceduto da una sfilata esemplare di tecnica e virtuosismi: alcuni personaggi mancano, ma le ottime variazioni della principessa Florine e dell’Uccello Blu, della fata Diamante e delle sue compagne riescono a compensare la debolezza di un secondo atto un po’ fiacco. Degno di nota il vivace pas de caractère dei due gatti.
Mentre l’uso uniforme delle luci non valorizza abbastanza i passaggi coreutici e narrativi, costumi e scenografia ben caratterizzano i ruoli mimici dei cortigiani e della strega Carabosse, antagonista fiera e convincente nella sua intensa gestualità, moltiplicata come in un incubo dall’espressivo corteo infernale dei corvi.
L’allestimento potrà forse essere lo stesso di dieci anni fa, la coreografia simile a quella del secolo scorso, ma di certo non stiamo assistendo allo stesso balletto di allora. Non esistono ricostruzioni filologiche neutre, perché il passato non si resuscita e nessuna rievocazione di esperienze potrà mai dirsi assoluta: possiamo imparare tanto della vita di un falsario dal modo in cui crede di riprodurre fedelmente lo stile di un capolavoro.
La différence, il senso, è nell’incontro tra le storie, tra le persone: ballerini, scenografi, costumisti, tecnici, spettatori. Perché le persone eccedono ogni schema.





 GIULIA MURONI | E’ dove le acque di Torinodanza incontrano quelle di Unione Musicale che nasce “Confluenze”, serate-evento che vedono la compresenza effettiva di entrambe le arti, in un’ottica di spettacolo/accadimento senza confini di genere. Pregevole l’obiettivo, andiamo ora ad approfondirne alcuni esiti.
GIULIA MURONI | E’ dove le acque di Torinodanza incontrano quelle di Unione Musicale che nasce “Confluenze”, serate-evento che vedono la compresenza effettiva di entrambe le arti, in un’ottica di spettacolo/accadimento senza confini di genere. Pregevole l’obiettivo, andiamo ora ad approfondirne alcuni esiti. LAURA NOVELLI | Proviamo a capovolgere la realtà e ad immaginare un filobus birichino che non rispetta orari e tragitti, un semaforo che diventa improvvisamente azzurro, delle macchine industriali che si rifiutano di costruire armi, una Cenerentola romana eletta Miss Universo, un re stagliato sul pentagramma senza corona, un funerale con epilogo tragico, un’eclissi di sole scambiata per un cerchio nero e un imperatore così sciocco da sentirsi adulato per un vestito che non indossa e da scambiare la sua nudità per sontuosità. Ne ricaveremmo un mondo rovesciato prodigo di poesia; un universo sghembo, delicato, naïf, che ce la dice lunga sulla stupidità degli uomini – tanto più degli adulti e dei potenti – ricordandoci quella massima senza tempo de Il piccolo principe secondo la quale “l’essenziale è invisibile agli occhi”. E non poche affinità con l’incantevole inquilino dell’asteroide B612 possiede la fantasia di Gianni Rodari, scrittore per l’infanzia che andrebbe letto e riletto in diverse stagioni della vita e che, in quanto a mostrare ciò che risulta invisibile agli occhi, è stato un impareggiabile genio.
LAURA NOVELLI | Proviamo a capovolgere la realtà e ad immaginare un filobus birichino che non rispetta orari e tragitti, un semaforo che diventa improvvisamente azzurro, delle macchine industriali che si rifiutano di costruire armi, una Cenerentola romana eletta Miss Universo, un re stagliato sul pentagramma senza corona, un funerale con epilogo tragico, un’eclissi di sole scambiata per un cerchio nero e un imperatore così sciocco da sentirsi adulato per un vestito che non indossa e da scambiare la sua nudità per sontuosità. Ne ricaveremmo un mondo rovesciato prodigo di poesia; un universo sghembo, delicato, naïf, che ce la dice lunga sulla stupidità degli uomini – tanto più degli adulti e dei potenti – ricordandoci quella massima senza tempo de Il piccolo principe secondo la quale “l’essenziale è invisibile agli occhi”. E non poche affinità con l’incantevole inquilino dell’asteroide B612 possiede la fantasia di Gianni Rodari, scrittore per l’infanzia che andrebbe letto e riletto in diverse stagioni della vita e che, in quanto a mostrare ciò che risulta invisibile agli occhi, è stato un impareggiabile genio. cabaret dai toni funambolici e stralunati, un montaggio della attrazioni fluido, organico e divertente dove, complici le agili scenografie di Paolo Ferrari e gli accurati costumi di Loredana Spadoni, gli interpreti (anche ottimi cantanti) azzerano le differenze, fanno piazza pulita delle gerarchie, ridicolizzano cliché e luoghi comuni, confondono i confini tra perfezione e imperfezione, entrando a gamba tesa nella filosofia di Rodari, nel suo pensiero altro. “La parola singola (gettata lì a caso con la sua forza evocativa di immagini, ricordi, fantasie, personaggi, avvenimenti del passato…) – scrive nella Grammatica della fantasia – agisce solo quando ne incontra una seconda che la provoca , la costringe ad uscire dai binari dell’abitudine, a scoprire nuove capacità di significato…Una storia può nascere solo da un binomio fantastico”.
cabaret dai toni funambolici e stralunati, un montaggio della attrazioni fluido, organico e divertente dove, complici le agili scenografie di Paolo Ferrari e gli accurati costumi di Loredana Spadoni, gli interpreti (anche ottimi cantanti) azzerano le differenze, fanno piazza pulita delle gerarchie, ridicolizzano cliché e luoghi comuni, confondono i confini tra perfezione e imperfezione, entrando a gamba tesa nella filosofia di Rodari, nel suo pensiero altro. “La parola singola (gettata lì a caso con la sua forza evocativa di immagini, ricordi, fantasie, personaggi, avvenimenti del passato…) – scrive nella Grammatica della fantasia – agisce solo quando ne incontra una seconda che la provoca , la costringe ad uscire dai binari dell’abitudine, a scoprire nuove capacità di significato…Una storia può nascere solo da un binomio fantastico”.

 RENZO FRANCABANDERA | L’Italia in campo artistico ha perso prematuramente due grandi menti nel secolo scorso. La prima è stata quella di Umberto Boccioni, la seconda quella di Piero Manzoni. Entrambi nell’intorno dei trent’anni. Entrambi in epoche di turbine artistico internazionale.
RENZO FRANCABANDERA | L’Italia in campo artistico ha perso prematuramente due grandi menti nel secolo scorso. La prima è stata quella di Umberto Boccioni, la seconda quella di Piero Manzoni. Entrambi nell’intorno dei trent’anni. Entrambi in epoche di turbine artistico internazionale.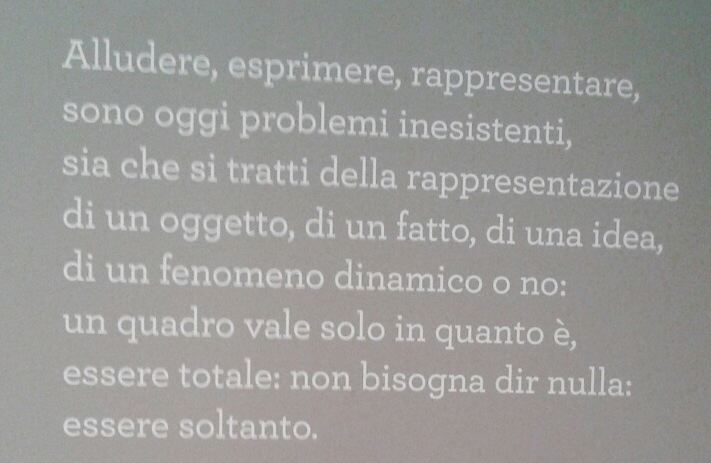
 LAURA NOVELLI | Ciò che più mi affascina nella drammaturgia britannica contemporanea è l’intelligenza di una scrittura che, in molti casi, persegue con rigorosa – ma inventiva – geometria lo schema strutturale dell’enigma. Voglio dire cioè che spesso, nei testi inglesi, scozzesi e irlandesi appannaggio degli autori viventi, il palcoscenico diventa una tribuna dialettica le cui dinamiche relazionali esistono e sussistono in virtù di un’ambiguità di fondo (chi sono realmente i personaggi? cosa li lega? chi dice il vero e chi no? quale passato si nasconde dietro le loro vite? quale futuro li attende?) che lascia al pubblico il privilegio di un’indagine agganciata ad appigli rivelatori mai esaustivi, eppure molto emblematici.
LAURA NOVELLI | Ciò che più mi affascina nella drammaturgia britannica contemporanea è l’intelligenza di una scrittura che, in molti casi, persegue con rigorosa – ma inventiva – geometria lo schema strutturale dell’enigma. Voglio dire cioè che spesso, nei testi inglesi, scozzesi e irlandesi appannaggio degli autori viventi, il palcoscenico diventa una tribuna dialettica le cui dinamiche relazionali esistono e sussistono in virtù di un’ambiguità di fondo (chi sono realmente i personaggi? cosa li lega? chi dice il vero e chi no? quale passato si nasconde dietro le loro vite? quale futuro li attende?) che lascia al pubblico il privilegio di un’indagine agganciata ad appigli rivelatori mai esaustivi, eppure molto emblematici. della provincia scozzese affacciato sul mare – i fatti si svolgono a Helensbourgh – dove Helen lavora alla reception e dove Evan arriva, con il suo carico di energia giovanile e ribelle, per trascorrere una nottata. Entrambi sono di lì: il ragazzo ci è tornato dopo molto tempo per partecipare al matrimonio della madre e del padre, divorziati pentiti; la donna sopporta da anni l’asfittico ambiente della cittadina e non ha mai trovato il coraggio di andarsene. In questo giovane dall’aria ruvida e dal fare smargiasso (cui Panici regala una prova equilibrata e matura) ella intravede subito qualcosa di familiare. Poco dopo veniamo a sapere che è stato proprio lui, mosso da una sorta di invidia sociale, l’esecutore di una feroce atto di bullismo ai danni di suo figlio, Jack Huges, all’epoca dei fatti compagno di classe di quell’intrigante cliente. Dunque, un evento tragico pesa su questo ritorno che potrebbe essere anche interpretato come una ricerca di perdono (casuale? premeditata?) o, per lo meno, di riappacificazione con le proprie radici. Fatto sta che lo scontro – non privo di qualche lentezza e ripetizione – si trasforma progressivamente in qualcos’altro: via via che il dialogo prosegue, intervallato da brevi stacchi di luce, parziali cambi di abito e note di Beethoven, le recriminazioni materne (quel “J’accuse” di storica memoria che tanto riecheggia il nome di Jack) cedono il posto ad una vibrante infatuazione, ad una curiosità più erotica che materna, tanto che la rigida Helen, contratta in un golfino vecchio stile e in uno chignon fin troppo rigoroso, diventa sempre più femminile, più accogliente, più seduttiva (sfumature emotive che l’interprete insegue con estrema bravura). Si sprigiona insomma una strana energia che, complici la birra, la notte, le confessioni intime, potrebbe far pensare all’inizio di una storia d’amore. Alla fine i due si salutano. Ma forse no. Come già in “Blackbird” (un controverso caso di abuso/passione tra una minorenne e un uomo maturo) e in “A Slow Air” (un ritrovarsi familiare sullo sfondo di Al Quaeda), anche qui non c’è moralismo. Non ci sono prediche né giudizi etici. Harrower non si schiera né da una parte né dall’altra. Troppi sarebbero d’altronde i recessi dell’animo umano da indagare per poter dire chi è nel giusto e chi ha torto. Dove sia il bene e dove il male. E i recessi umani – si sa – sono da sempre assolutamente enigmatici (
della provincia scozzese affacciato sul mare – i fatti si svolgono a Helensbourgh – dove Helen lavora alla reception e dove Evan arriva, con il suo carico di energia giovanile e ribelle, per trascorrere una nottata. Entrambi sono di lì: il ragazzo ci è tornato dopo molto tempo per partecipare al matrimonio della madre e del padre, divorziati pentiti; la donna sopporta da anni l’asfittico ambiente della cittadina e non ha mai trovato il coraggio di andarsene. In questo giovane dall’aria ruvida e dal fare smargiasso (cui Panici regala una prova equilibrata e matura) ella intravede subito qualcosa di familiare. Poco dopo veniamo a sapere che è stato proprio lui, mosso da una sorta di invidia sociale, l’esecutore di una feroce atto di bullismo ai danni di suo figlio, Jack Huges, all’epoca dei fatti compagno di classe di quell’intrigante cliente. Dunque, un evento tragico pesa su questo ritorno che potrebbe essere anche interpretato come una ricerca di perdono (casuale? premeditata?) o, per lo meno, di riappacificazione con le proprie radici. Fatto sta che lo scontro – non privo di qualche lentezza e ripetizione – si trasforma progressivamente in qualcos’altro: via via che il dialogo prosegue, intervallato da brevi stacchi di luce, parziali cambi di abito e note di Beethoven, le recriminazioni materne (quel “J’accuse” di storica memoria che tanto riecheggia il nome di Jack) cedono il posto ad una vibrante infatuazione, ad una curiosità più erotica che materna, tanto che la rigida Helen, contratta in un golfino vecchio stile e in uno chignon fin troppo rigoroso, diventa sempre più femminile, più accogliente, più seduttiva (sfumature emotive che l’interprete insegue con estrema bravura). Si sprigiona insomma una strana energia che, complici la birra, la notte, le confessioni intime, potrebbe far pensare all’inizio di una storia d’amore. Alla fine i due si salutano. Ma forse no. Come già in “Blackbird” (un controverso caso di abuso/passione tra una minorenne e un uomo maturo) e in “A Slow Air” (un ritrovarsi familiare sullo sfondo di Al Quaeda), anche qui non c’è moralismo. Non ci sono prediche né giudizi etici. Harrower non si schiera né da una parte né dall’altra. Troppi sarebbero d’altronde i recessi dell’animo umano da indagare per poter dire chi è nel giusto e chi ha torto. Dove sia il bene e dove il male. E i recessi umani – si sa – sono da sempre assolutamente enigmatici (