
RENZO FRANCABANDERA | La lettera di Paolo Nani è senza ombra di dubbio un atto creativo di talento. Una di quelle idee di utilizzo del codice teatrale che ne nobilita l’essenza e che giustifica nei tempi di tablet e digital devices, il loro spegnimento (e potremmo dire anche dolcissimo oblio per un’ora e un quarto) per dar la parola all’uomo nella sua più cristallina, miserabile, fragile, grandiosa presenza.
Lo spettacolo è una serie di variazioni su tema, tipo esercizi di stile di Queneau, o le variazioni sul canone, tipo Offerta Musicale di Bach.
Il tema del canone: un uomo entra in una stanza, dove c’è un tavolo e una sedia. Sul tavolo busta, foglio e affrancatura da lettera, e una penna. Una bottiglia di vino e un bicchiere. Una foto in un portafoto. Stop. L’uomo entra. Si reca al tavolo, si versa da bere ma sputa via quanto bevuto. Inizia a scrivere e deve togliere la foto dal suo sguardo, che forse per dolore lo turba. Chiude la lettera dopo averla imbustata e affrancata, fa per andar via, ma proprio nell’atto di uscire un dubbio lo assale, e quindi torna sui suoi passi e riapre la lettera per controllarne il contenuto. Stop.
Nulla dunque di complesso. Una serie di azioni banali una dopo l’altra.
Di qui in avanti Paolo Nani, prima con i codici della comicità e poi dell’umorismo, alternandoli, sofisticando e banalizzando, ricorrendo a clownerie, equilibrismi, mimica di altissimo livello e lavoro di rimando ad un ruolo del pubblico attivo, costruisce un one man show che a giusta ragione dal 1992 gira il mondo. Centinaia di repliche.
Si può diventare a proprio modo schiavi di una propria creazione? Mi piacerebbe chiederlo a Nani, come a tutti quei cantautori che sono inchiodati dal loro leggendario primo grande successo, a replicarlo a vita. Un Guccini senza La locomotiva? “Un manouche senza roulotte? Un casinò senza roulette?” per dirla con un’altra canzone…
Ecco solo questo mi resterebbe da chiedermi, dopo aver riso del genio di quest’uomo per un’ora e mezza, mentre rifaceva la scenetta di cui sopra al contrario, senza mani, in salsa western, in salsa horror, dormendo, ubriaco, freudiano, mentre perfino gli applausi diventavano parte del gioco, mentre comunicava con noi per mezzo di cartelli, ecco, solo questo gli avrei chiesto: se questa ripetizione, nello spettacolo e dello spettacolo in vista sua, anche solo in un momento, non gli ha procurato stanchezza.
Perché ovviamente fosse per il pubblico lui dovrebbe restare in scena 3 ore. Alla fine è lui ad esibire, mentre continuano scroscianti gli applausi del pubblico in delirio, il cartello “Andatevene!”.
Sa già che sarà un successo.
Sa quanto vale la sua creazione Paolo Nani.
E’ stato ospite in questi giorni al Filodrammatici a Milano e penso sia una di quelle cose che spero lui continui a fare a lungo, perché vorrei farlo rivedere a mia figlia fra qualche anno, appena avrà chiara dentro di sé la sottile distinzione fra comicità e umorismo, proprio per farle capire con quanta intelligenza i due concetti possono essere declinati da una persona sola in un’unica creazione scenica.


 SIMONA POLVANI | In questi ultimi anni digitali, dopo il
SIMONA POLVANI | In questi ultimi anni digitali, dopo il 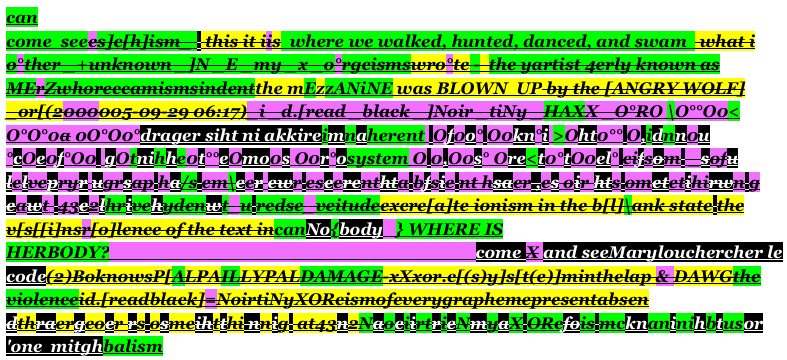 Quali sono gli atteggiamenti dei lettori performer e quali impressioni conservano dell’esperienza del Reading Club?
Quali sono gli atteggiamenti dei lettori performer e quali impressioni conservano dell’esperienza del Reading Club? EMANUELE TIRELLI | Quando l’architetto cino-americano Ieoh Ming Pei presentò e poi realizzò la piramide del Louvre fu grande polemica. Scandalo. Un grande errore. Anacronistica. E magari anche qualche colorita e accorata maleparola in francese. Tutto grazie al presidente Mitterrand che affidò l’incarico all’architetto Pei. Oggi, a distanza di anni, quella stessa piramide è considerata uno dei simboli, uno dei richiami più evidenti del grande museo parigino.
EMANUELE TIRELLI | Quando l’architetto cino-americano Ieoh Ming Pei presentò e poi realizzò la piramide del Louvre fu grande polemica. Scandalo. Un grande errore. Anacronistica. E magari anche qualche colorita e accorata maleparola in francese. Tutto grazie al presidente Mitterrand che affidò l’incarico all’architetto Pei. Oggi, a distanza di anni, quella stessa piramide è considerata uno dei simboli, uno dei richiami più evidenti del grande museo parigino. RENZO FRANCABANDERA | Lo scoglio che affoga sommerso dall’acqua? Giù il vino sui mitili, in una pentola dove sta per nascere un riso alle cozze.
RENZO FRANCABANDERA | Lo scoglio che affoga sommerso dall’acqua? Giù il vino sui mitili, in una pentola dove sta per nascere un riso alle cozze. 
 COSIMA PAGANINI |
COSIMA PAGANINI | 

