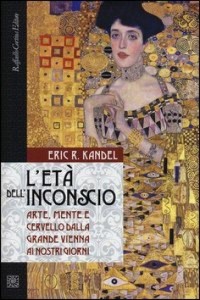RENZO FRANCABANDERA | La seconda edizione di PalCo- Palcoscenici Contemporanei, rassegna iniziata l’anno scorso al Parco di Monteclaro – Cagliari, a cura dalla Compagnia B, nonostante il grande successo dell’edizione estiva 2011, ha dovuto fare i conti con i tagli e si è ridotta a tre appuntamenti durante le festività natalizie 2012 ospitale al Mini Max il “Ridotto” del Teatro Massimo di Cagliari.
RENZO FRANCABANDERA | La seconda edizione di PalCo- Palcoscenici Contemporanei, rassegna iniziata l’anno scorso al Parco di Monteclaro – Cagliari, a cura dalla Compagnia B, nonostante il grande successo dell’edizione estiva 2011, ha dovuto fare i conti con i tagli e si è ridotta a tre appuntamenti durante le festività natalizie 2012 ospitale al Mini Max il “Ridotto” del Teatro Massimo di Cagliari.
Si è trattato comunque di una proposta particolarmente interessante nel suo complesso, con la versione della favola di “Biancaneve” firmata da Emma Dante – giovedì 27 dicembre per proseguire con “Aldo Morto” di Daniele Timpano (venerdì 28), e infine (sabato 29) “Porco Mondo” di Biancofango.
Aldo Morto di Daniele Timpano, spettacolo vincitore Premio Rete Critica 2012 e finalista al Premio Ubu 2012 come “Migliore novità italiana (o ricerca drammaturgica)”, con segnalazione speciale al Premio IN-BOX 2012, è un ulteriore lavoro dell’artista romano sulla potenza iconica dell’oblio della Storia, un tema caro e già affrontato, pur con altra lettura, a proposito di Benito Mussolini nel suo Dux in scatola, che parecchie polemiche ebbe a sollevare cinque anni fa.
Questa volta con Aldo Morto, scritto, diretto e interpretato da Timpano e prodotto da AmnesiA VivacE in collaborazione con Cité Internationale des Arts (Comune di Parigi), il focus è chiaramente sullo statista assassinato dalle Brigate Rosse (?) nel maggio del 78. Il punto interrogativo è d’obbligo visto il taglio che Timpano conferisce fin da subito al testo, che proprio facendo leva sulla forza dell’oblio a distanza di quasi 35 anni dall’evento, trasporta quella che è stata una chiave di volta della storia politica repubblicana, in un magma di persone-personaggi, vicende, piccoli frangenti umani e familiari che contribuiscono ad alimentare un non-ricordo mistificato, che travalica da subito i confini del vero ma che non abbandona mai il recinto del verosimile.
Quella dell’attore/drammaturgo è un’interpretazione nuda, che lo porta ad affrontare il pubblico in un confronto privo di scenografie di supporto e altri orpelli di scena, eccezion fatta per una mascherina da Mazinga (che riporta ad altri lavori e al confronto in termini di grammatura mnemonica, anche questa volta dichiarato, fra il passato della Storia e una qualsiasi puntata cartoon), oltre ad una riproduzione in scala della celebre R4. Così fra Renato Curcio e Mazinga Z, nella mente di un quarantenne distratto, finisce per esserci poca differenza, e questo pretesto sviluppa un narrato che si mantiene almeno per un’ora, intenso e potente, affidato ad un’interpretazione quasi anti recitativa, che beccheggia fra discussione colloquiale e momenti di mimo appassionato ma mai pulito, anzi volutamente ruvido e anti-accademico.
L’intreccio narrativo parte dall’identificazione fra Daniele e il figlio dello statista, che si chiede e chiede che germi conservi la Storia, quella dei libri, dell’epopea nazionale, della vicenda familiare, di quel vero intimo di cui mai si conserva traccia nella memoria. Da questo interrogativo ne partono poi altri sul vero della vicenda del rapimento, sul vero della storia delle Brigate rosse, sul vero della cella 3×1, sul vero nel cinema e nei racconti à-la-Mixer. Il sarcasmo sull’epopea sociale è continuo, e dialoga con il pubblico in forma non mediata, fino a portarlo quasi in scena, puntando su qualche spettatore il faro dell’interrogatorio proletario.
In tutto questo il tono rimane sempre alto, e il protagonista stesso pare accorgersi, dichiarandolo, quando il lavoro registra un punto di flesso nel dialogo che sempre è necessario con l’attenzione del pubblico. Ci si chiede perché dunque, davanti a un così chiaro atto di autoconsapevolezza, Timpano decida, approssimandosi all’ora e dieci di spettacolo, di proseguire per un altro quarto d’ora che, pur non scadendo mai nel banale, risulta più faticoso ed ermetico.
Mi era venuta in mente la sensazione piacevole di quando ci si alza da tavola nutriti ma equilibrati e quando si cede invece all’appetito ingordo per poi levarsi satolli. La fabula di Timpano potrebbe fermarsi, e bene, al primo dei due limiti, e decide invece, in uno sciabordio verbale, di approcciare il secondo. Dal punto di vista concettuale l’allungo aggiunge poco a quanto già delineato, per esaurirsi in una chiusa, peraltro, assai diversa, dal punto di vista dei segni (la musica, il neon ecc), rispetto a quello che fino ad allora era stato. Questo è un ambito che ci pare di miglioramento, che uno sguardo registico esterno meno indulgente avrebbe senz’altro posto all’attenzione del creatore-interprete, per cristallizzare il rapporto con il pubblico di fruitori all’interno di un’intensità che trova il suo culmine ben prima.
* * *
 Biancofango è una Compagnia nata nel 2005 dall’incontro tra la drammaturga e regista Francesca Macrì e l’attore-autore Andrea Trapani. Ne abbiamo seguito da subito la vicenda artistica, registrando nelle capacità della allora non ancora trentenne regista, una capacità di creare tempi scenici, atmosfere e ritmi attorali di indubbia consistenza.
Biancofango è una Compagnia nata nel 2005 dall’incontro tra la drammaturga e regista Francesca Macrì e l’attore-autore Andrea Trapani. Ne abbiamo seguito da subito la vicenda artistica, registrando nelle capacità della allora non ancora trentenne regista, una capacità di creare tempi scenici, atmosfere e ritmi attorali di indubbia consistenza.
Porco Mondo, realizzato in coproduzione con La Corte Ospitale di Rubiera e il progetto OFFicINA1011 di Triangolo Scaleno Teatro, è un’insolita storia di natale ideata da Francesca Macrì e Andrea Trapani e interpretata dallo stesso Trapani con Aida Talliente.
All’interno di un disegno luci ideato da Luigi Biondi si dipana la vicenda di un uomo e una donna, una coppia che pare aver esaurito lo spazio della condivisione per rimanere in un logorato universo di micro isterie, che oscillano in forma libera fra lui e lei, e che all’inizio paiono uscire da una stanza di nosocomio psichiatrico, ma che poi rivelano la loro essenza tutta interna ad un ambiente “sociale”, senza dubbio borghese, istruito, agiato. La drammaturgia cadenza il ritmo della parola fra lui e lei in forma apparentemente libera, ma in realtà costretta, come in un gioco delle parti, lasciando poi l’idea di una sorta di pendolo di Foucault, apparentemente libero di oscillare in ogni direzione per un tempo illimitato, ma che ben presto rivela una regola meccanica che è il motore immobile della vicenda teatrale come, nel caso dello strumento scientifico, della regola fisica che gli è sottostante.
Lei tenta in modo infantile di avvicinarsi a lui, di riconquistarlo e allontanarlo da fruizioni telematiche al limite della pedofilia, travestendosi da Marilyn, con abito svolazzante e parrucca, ma questo tentativo finisce per suscitare in lui una pena ancor più spietata e centrifuga. Fra un panettone divorato nello spasmo dei nervi e una bottiglia di spumante che finisce per stapparsi al culmine della reciproca tristezza, la drammaturgia vuole rispondere all’interrogativo “Dove si scappa mentre ci si viene incontro?”. La fruizione è obiettivamente dolorosa, soprattutto per quel pubblico che ha raggiunto l’età delle consapevolezze e delle disillusioni, che legge in maniera molto chiara il complesso di simboli, spesso anche solo fisiognomici, che descrivono il rapporto fra i due personaggi in scena. Gli sguardi di lui oltre il proscenio paiono lanciati dal quinto piano di un ricco palazzone di quelli tutti vetri di una città metropolitana, gli sguardi di lei vogliono arrivare nel profondo dell’inconscio dello spettatore, per scavargli dentro il germe che in ognuno alberga del duale vittima-carnefice.
La riuscita è dolorosamente efficace, il pubblico dopo l’applauso non riesce ad alzarsi subito dalle poltrone, ha bisogno di restare un attimo a sedimentare, a raccogliere le forze, a mollare la presa rispetto all’ora e poco più di messa in scena.
Trapani, più rodato nei linguaggi della compagnia, è nel ruolo in maniera puntuale, forte, viva. La Talliente, sfavorita anche da un pendolare drammaturgico che appoggia maggiormente sul personaggio maschile le parole, i cambi di direzione emotiva, le dichiarazioni di senso e di stato, soffre invece nel cercare una resa quasi solo fisica dell’intimità fragile, dell’autostima ormai inesistente, di una luce incapace di riverberi e forse soffre troppo questo stato di minorità verbale. Se dunque l’insieme è nel complesso di sicuro interesse ed efficace, il meccanismo scenico e la resa del personaggio di lei attivano un’invisibile inerzia che porta ad un inesorabile squilibrio, proprio come il pendolo di Foucault che venga attivato in un luogo diverso dall’equatore.
Si ricorderà che per lo strumento dello studioso francese, ad ogni latitudine della Terra tranne che all’equatore, si osserva la lenta rotazione del piano di oscillazione del pendolo, invece che rimanere su un piano unico.
Per la drammaturgia in esame la similitudine si potrebbe risolvere appunto nel paragone con lo scivolare verso superfici emotive, soprattutto femminili, più consuete e meno ricche, come se non fosse stato ancora trovato precisamente l’equatore, la registrazione precisa del meccanismo drammaturgico-scenico, che resta comunque potente e vivo, perfettibile ma già intenso.
*Disegno di Renzo Francabandera
 MARIA PIA MONTEDURO | Il monologo Novecento, a torto o a ragione, è considerato un testo cult. Diverse edizioni teatrali, una nota trasposizione cinematografica nel1998 a opera di Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’Oceano”, vincitore di ben sedici premi internazionali), molto successo di critica e pubblico. Può perciò essere interessante, a quasi vent’anni dalla prima stesura ad opera di Alessandro Baricco, assistere alla messa in scena del regista (Gabriele Vacis) e dell’attore (Eugenio Allegri) per i quali lo scrittore torinese nel 1994 lo compose appositamente. Occasione ghiotta quindi, offerta dal Teatro Eutheca di Roma, che per questo evento si sposta all’interno della cittadella Cinecittà, allestendo lo spettacolo nello Studio Fellini, la bellissima sala dove il Maestro amava seguire le proiezioni dei suoi film.
MARIA PIA MONTEDURO | Il monologo Novecento, a torto o a ragione, è considerato un testo cult. Diverse edizioni teatrali, una nota trasposizione cinematografica nel1998 a opera di Giuseppe Tornatore (“La leggenda del pianista sull’Oceano”, vincitore di ben sedici premi internazionali), molto successo di critica e pubblico. Può perciò essere interessante, a quasi vent’anni dalla prima stesura ad opera di Alessandro Baricco, assistere alla messa in scena del regista (Gabriele Vacis) e dell’attore (Eugenio Allegri) per i quali lo scrittore torinese nel 1994 lo compose appositamente. Occasione ghiotta quindi, offerta dal Teatro Eutheca di Roma, che per questo evento si sposta all’interno della cittadella Cinecittà, allestendo lo spettacolo nello Studio Fellini, la bellissima sala dove il Maestro amava seguire le proiezioni dei suoi film.