 VINCENZO SARDELLI | Starebbe bene come spazio performativo in una mostra sugli anni Settanta Figli senza volto, messo in scena dai milanesi Animanera, bel testo di Ida Farè, regia di Aldo Cassano, con una Natascia Curci di forte impatto. Una storia calata negli Anni di Piombo. Una militante della lotta armata, tra quotidianità e anonimato, affetti e ideologia. Tre quarti d’ora di monologo, in uno degli spazi angusti della Triennale-Teatro dell’Arte.
VINCENZO SARDELLI | Starebbe bene come spazio performativo in una mostra sugli anni Settanta Figli senza volto, messo in scena dai milanesi Animanera, bel testo di Ida Farè, regia di Aldo Cassano, con una Natascia Curci di forte impatto. Una storia calata negli Anni di Piombo. Una militante della lotta armata, tra quotidianità e anonimato, affetti e ideologia. Tre quarti d’ora di monologo, in uno degli spazi angusti della Triennale-Teatro dell’Arte.
Ma qui tutto è angusto, il movimento, la parola, l’anima: «Ho seguito il filo della ribellione pura, l’acqua della vita. Sono state le vostre mani a intorbidirla di morte, ma eravate più forti e ho dovuto raccogliere le armi che mi avete consegnato. Sono diventata come voi. Ho bevuto l’acqua della ribellione amara».
Casermone popolare di una città del Nord, appartamento come tanti. Una donna sola, volto smunto, sottana, maglione a trecce. Moquette, sedia. Elettrodomestici dal design postmoderno: tv, ferro da stiro, videocamera. Borsa, scarpe. Giradischi, note su vinile: la struggente Ultima neve di primavera di Franco Micalizzi, l’acid rock di White Rabbit dei Jefferson Airplane, Rain and Tears degli Aphrodite’s Child, colonna sonora del Maggio francese: a volte sono i figli a tradire i padri.
Portacenere, cicche, fumo: gli oggetti (spazio scenico Valentina Tescari, costumi Lucia Lapolla) hanno contenuti emozionali. Ritagli di giornale, Polaroid, pistola, parrucca: travestimenti, anche della sfera affettiva. Patimenti, pentimenti. Anche le luci da interior design (di Beppe Sordi) sono emozionali, la progettazione dell’epoca era così spiazzante. Le luci dilatano ombre, le ombre i gesti. Gesti di mani intorpidite. Mani che tremano, sparano, uccidono.
Un velo sottile separa una vita dalle nostre. Due mondi, due epoche. Siamo in intimità, a volte in empatia, persino. Dietro la quotidianità di un uomo e di una donna, gesti e azioni banali, si cela l’angoscia di due terroristi.
La scelta della lotta armata. L’esistenza nell’ombra. L’ansia di nascondersi, dalla polizia, dai vicini, dal letturista del gas. Anche noi ci sentiamo braccati. Dall’urgenza di trattenere il tempo. Dalla giovinezza che vola. Da passato e futuro intrecciati, sospesi, nell’emozione dei silenzi.
Figli senza volto ce li ricorda bene quegli anni: le sigle di fine programmazione della Rai, il meteo di Bernacca, Kraft-cose-buone-dal-mondo, Bontempi e la musica a portata d’infante. C’è questo nello spettacolo, e anche il resto: le armi, l’isolamento, le atmosfere livide e profonde. Gli effetti audio (di Antonio Spitaleri) s’intersecano in uno straniante climax: borbottio di caffettiera, ticchettii di macchina da scrivere, sveglia, bomba a orologeria, spari di mitragliatrice, rombo di terremoto.
Suoni meccanici. Come la voce della protagonista, fredda e metallica. Come i colpi delle P38. E sangue, a fiotti.
C’è un climax anche olfattivo: sigarette, fumo, barricate, molotov. A squarciare il grigio dilagano, proiettati sul velo, effetti caleidoscopici, a creare un acquario psichedelico che è fuga, fantasia, filtro per una danza nell’ombra della protagonista. C’è un contrappunto, cose di un altro mondo: E se domani di Mina, l’intervista a una donna siciliana che prova a emanciparsi tra una fuitina d’amore e un paio di aborti, all’epoca clandestini anch’essi.
Brandelli esistenziali, ideologie perdenti, amori (e valori) smarriti. Nostalgia, disperazione.
Che cosa resta di quegli anni, delle battaglie, di chi sacrificò la vita, propria e altrui? Scorre sul velo-schermo-sipario, come titolo di coda, un bilancio di quelle ferite, curato da Giorgio Galli. A precederlo immagini della Tv contemporanea, Porta a porta, Il grande fratello, X-Factor, La prova del cuoco, Affari tuoi. Didascalia preziosa per alcuni, pedante secondo noi. Occorreva un finale, e forse è l’unica scaglia da limare di questa messinscena di grande intensità. Che ci ha trasmesso ricordi ed emozioni. E riflessioni, ancora nuove. Quarant’anni dopo.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ejKUJu9xct4&w=420&h=315]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=YQyxCL1uMlU&w=420&h=315]



 La stessa riflessione va fatta per la maggior parte degli ospiti: Raffaella Carrà, le Kessler, Franca Valeri, Renzo Arbore. Fanno all’incirca quattrocento anni, più o meno.
La stessa riflessione va fatta per la maggior parte degli ospiti: Raffaella Carrà, le Kessler, Franca Valeri, Renzo Arbore. Fanno all’incirca quattrocento anni, più o meno.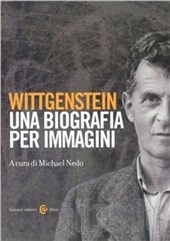


 EMILIANA IACOVELLI | “La stima è come un fiore che, pestato una volta o gravemente appassito, mai più non ritorna” lo ha scritto Leopardi e lo ha ribadito più volte Vierchowod quindi è vero.
EMILIANA IACOVELLI | “La stima è come un fiore che, pestato una volta o gravemente appassito, mai più non ritorna” lo ha scritto Leopardi e lo ha ribadito più volte Vierchowod quindi è vero.
 RENZO FRANCABANDERA – ELENA SCOLARI | ES: Hai capito che bel Peppino Impastato abbiamo visto? E fammi dire, per una volta, qualcosa di superficiale! Proprio un bell’attore Stefano Annoni. Eravamo in prima fila, l’ho visto bene. E siccome è pure piuttosto bravo sono già contenta. Ti spiace?
RENZO FRANCABANDERA – ELENA SCOLARI | ES: Hai capito che bel Peppino Impastato abbiamo visto? E fammi dire, per una volta, qualcosa di superficiale! Proprio un bell’attore Stefano Annoni. Eravamo in prima fila, l’ho visto bene. E siccome è pure piuttosto bravo sono già contenta. Ti spiace?