VINCENZO SARDELLI | Fisicità e dinamismo sono i tratti comuni di tre spettacoli di scena a Milano durante il ponte di Ognissanti. Chi non è partito ha potuto apprezzare un teatro di movimento e figura, in fuga dai cliché tradizionali.
A partire da Maratona di New York, soggetto di Edoardo Erba, con Cristian Giammarini e Giorgio Lupano, in programma al Leonardo. E qui è doveroso un cenno a Zuzzurro e Gaspare, che avrebbero dovuto inaugurare la stagione del teatro di piazza Leonardo da Vinci; al dolore per la morte di Andrea Brambilla, clown in impermeabile dalla comicità gentile.
Giammarini e Lupano, registi e interpreti, iniziano sul palco un’ora di corsa. Si allenano di notte per preparare la maratona della Grande Mela. Corrono, corrono. E intanto parlano. Lo straniante brainstorming lambisce ricordi, rimpianti, aneddoti, con una sceneggiatura leggera di disarmante realismo. Il ritmo della corsa varia. Il taglio onirico è accentuato da un mega video che proietta sullo sfondo immagini in bianco e nero di rara bellezza, poi flash di vita vissuta. C’è un che di tridimensionalità, luci lunari e anabbaglianti. Intanto scorre l’originalissimo sound post-rock dei Sigur Rós, lunghe suite mistiche, paesaggi sonori di atmosfere fredde e rarefatte. Ma dove vanno davvero i due amici? Chi taglierà per primo il traguardo: quello dalle ampie falcate che precede, o l’altro che segue con andatura sbilenca? La matassa si dipana con sviluppi surreali. Particolare questa road-story dalle venature introspettive e dai geli cosmici. Lo sforzo fisico si accompagna a una buona capacità recitativa (Giammarini è di scuola ronconiana). Tutto è calibrato e contenuto in un’ora di spettacolo, tempo adeguato anche alla complessità dei temi toccati.
Coraggioso il tentativo della compagnia Vanaclù di «dis-adattare» il Gabbiano di Anton Cechov, riproponendolo in chiave farsesca con il titolo di GabbiaNO (di scena al Tertulliano). Perché Cechov è complesso già di suo, straordinariamente contemporaneo, e non richiede aggiornamenti. In questa storia balneare di amori traditi, successi effimeri e solitudini i personaggi girano a vuoto intorno a un ombrellone e a una piscina gonfiabile che richiama un lago. Afa, noia esistenziale. Tutti dialogano con tutti. Senza comunicare davvero. È la gabbia che Treplev rifiuta. E si spara, sulle note di Tenco. La fitta è eccessiva per chi ama il cantautore genovese, stride con la messinscena leggera. Altre varianti rispetto all’originale: lo scrittore Trigorin, amante dell’attrice Irina, madre di Treplev, nelle mani non ha una lenza ma un videogioco; Sorin, fratello di Irina, è un disabile in carrozzella sin dall’inizio, e passa dalla radio canzoni stile vacanza-impegnata (Mina, Lauzi, Graziani, Martino). Costumi sgargianti, occhialoni da sole, riviste gossip e luci al neon, con l’esilarante trovata di By This River di Brian Eno cantata a cappella, sono il marchio di questo progetto di Woody Neri, regista e attore in scena. Che richiede ulteriore labor limae. La commistione di generi e la scansione delle scene vanno meglio dosate per evitare derive pulp di cui non è chiaro l’esito. Alti e bassi nella recitazione, dove svetta Marta Pizzigallo. Stefania Medri, Massimo Boncompagni, Loris Dogana, Gioia Salvatori, Liliana Laera e Mimmo Padrone completano il cast.
Cresce la compagnia Idiot-Savant, cui la regia di Benedetto Sicca reca un valore aggiunto. Il silenzio dei cassetti (al Teatro di Ringhiera) è una pièce a quadri che mette insieme teatro di figura e d’ombre, con una prova attoriale intensa e generosa di tutti i protagonisti (Pierpaolo d’Alessandro, Paola Michelini, Valentina Picello, Filippo Renda, Matthieux Pastore, Mattia Sartoni, Laura Serena, Simone Tangolo). Anche qui si copre bene il palco, meno bene il vuoto esistenziale. I personaggi hanno identità multiple. L’ipocrisia e il tornaconto sono le regole di base di quest’umanità in disarmo. Pressioni, trame, tresche, senso di precarietà. E lo spiraglio che il bisogno d’autenticità sia soddisfatto, che l’amore vinca. Tanti cassetti. A dar voce a ognuno di essi non solo gli attori, ma gli stessi spettatori, in un territorio dove tutto è possibile. Luci da piano-bar, musiche stranianti registrate alla viola in una grotta da Chiara Mallozzi. E un lenzuolo che diventa sipario, schermo, alcova, pavimento. E scandisce le scene fino a volare via sulle nostre teste, sulle ombre dell’anima. E scopre un cenno di danza tra due innamorati. Sulle foglie secche, citazione di Autumn in New York.
Maratona di New York
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hInz4dygZgc&w=420&h=315]



 Allora Fante dice a Bukowski che quando Faulkner lavora a Hollywood c’è anche lui. E che Faulkner è il peggiore di tutti ed è sempre ubriaco lercio. A volte fa addirittura fatica a entrare nel taxi da solo. Anche Fante alza spesso il gomito, un po’ per la frustrazione di non avere successo come scrittore, un po’ perché molti autori americani l’alcol se lo portano dietro dalla gioventù. E anche Bukowski non s’è mai fatto pregare per scolarsi una confezione di birre. Però Faulkner se ne va da Hollywood, lascia, mentre Fante non ha il coraggio e resta lì. Faulkner è il suo punto di riferimento. Faulkner scrive come avrebbe voluto scrivere lui, tant’è vero che lo fa dire anche al suo Arturo Bandini. Faulkner è per Fante quello che Fante è per Bukowski. Allora Bukowski gli fa un regalo, gli dice “tu scrivi bene come Faulkner” e riporta tutto quello che vi ho raccontato nella poesia “Small conversation in the afternoon with John Fante” che forse è meglio di tanti film che potrebbero girare su di lui.
Allora Fante dice a Bukowski che quando Faulkner lavora a Hollywood c’è anche lui. E che Faulkner è il peggiore di tutti ed è sempre ubriaco lercio. A volte fa addirittura fatica a entrare nel taxi da solo. Anche Fante alza spesso il gomito, un po’ per la frustrazione di non avere successo come scrittore, un po’ perché molti autori americani l’alcol se lo portano dietro dalla gioventù. E anche Bukowski non s’è mai fatto pregare per scolarsi una confezione di birre. Però Faulkner se ne va da Hollywood, lascia, mentre Fante non ha il coraggio e resta lì. Faulkner è il suo punto di riferimento. Faulkner scrive come avrebbe voluto scrivere lui, tant’è vero che lo fa dire anche al suo Arturo Bandini. Faulkner è per Fante quello che Fante è per Bukowski. Allora Bukowski gli fa un regalo, gli dice “tu scrivi bene come Faulkner” e riporta tutto quello che vi ho raccontato nella poesia “Small conversation in the afternoon with John Fante” che forse è meglio di tanti film che potrebbero girare su di lui.

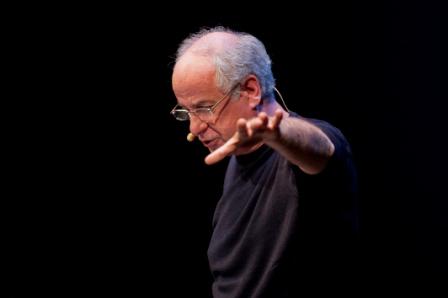

 Alla festa c’era comunque di peggio: camerieri che ti dicevano che il vino era finito e ti veniva in mente quel genere di feste di quand’eri bambino quando la fanta finiva subito a meno che non eri il figlio del notaio; e ancora, venditrici di bamby e gnometti che a Milano fanno una vita grama e ti attaccano un bottone per dirti che in provincia il bamby e lo gnometto ce l’hanno tutti perché lo regalano quando ti sposi, o ai figli universitari fuori sede, e chi ce l’ha lo fa vedere, mentre quei pochi che sono riuscite a piazzare in città giacciono nascosti nei ripostigli… E tu rispondi: bamby? È mainstream. Meglio kiiwood, il concorrente giappo-tedesco che costa anche 200 euro in meno e che bamby proprio no, meglio addirittura un qualsiasi superfrullatore da centro commerciale del sabato pomeriggio (una così ci passa tutto il pomeriggio del sabato nei centri commerciali). Costa 10 volte meno e non fa provincia, e mica siamo casalinghe disperate che dobbiamo avere elettrodomestici che funzionano. Ma se tu piazzi bamby come mai sei a questa festa? E ti risponde: ma perché a volte vendo anche kiiwood… nella scatola dei bamby. E allora ti spiega che il problema è la scatola, che queste sciattone con le scarpe dal nome tedesco usano tutte delle belle scatole. E tu allora: bello? Ma Muccia docet: «La bruttezza è attraente ed eccitante. La ricerca della bruttezza, per me, è molto più interessante dell’idea borghese della bellezza». Mentre dici questo ti guardi intorno e vedi che davvero di bellezza in giro non ce n’è troppa e le muccie sono ovunque.
Alla festa c’era comunque di peggio: camerieri che ti dicevano che il vino era finito e ti veniva in mente quel genere di feste di quand’eri bambino quando la fanta finiva subito a meno che non eri il figlio del notaio; e ancora, venditrici di bamby e gnometti che a Milano fanno una vita grama e ti attaccano un bottone per dirti che in provincia il bamby e lo gnometto ce l’hanno tutti perché lo regalano quando ti sposi, o ai figli universitari fuori sede, e chi ce l’ha lo fa vedere, mentre quei pochi che sono riuscite a piazzare in città giacciono nascosti nei ripostigli… E tu rispondi: bamby? È mainstream. Meglio kiiwood, il concorrente giappo-tedesco che costa anche 200 euro in meno e che bamby proprio no, meglio addirittura un qualsiasi superfrullatore da centro commerciale del sabato pomeriggio (una così ci passa tutto il pomeriggio del sabato nei centri commerciali). Costa 10 volte meno e non fa provincia, e mica siamo casalinghe disperate che dobbiamo avere elettrodomestici che funzionano. Ma se tu piazzi bamby come mai sei a questa festa? E ti risponde: ma perché a volte vendo anche kiiwood… nella scatola dei bamby. E allora ti spiega che il problema è la scatola, che queste sciattone con le scarpe dal nome tedesco usano tutte delle belle scatole. E tu allora: bello? Ma Muccia docet: «La bruttezza è attraente ed eccitante. La ricerca della bruttezza, per me, è molto più interessante dell’idea borghese della bellezza». Mentre dici questo ti guardi intorno e vedi che davvero di bellezza in giro non ce n’è troppa e le muccie sono ovunque.


 NICOLA ARRIGONI | «L’intero valore del teatro è che tutto quello che è stato creato scompare immediatamente. Come accade per la nebbia cresce, cresce e poi improvvisamente svanisce. Questo è il valore del teatro: la raccolta e poi l’improvviso svanire», così Eimuntas Nekrosius definisce il teatro e ovviamente il suo modo di fare teatro in cui tutto vive nell’immagine, nell’emozione impalpabile che simboli e racconto, parola e gesto, attore e pubblico vivono in quell’istante. Ma questo si può dire del teatro in genere, ma in Nekrosius assume quasi un valore esegetico, aiuta a vivere il susseguirsi delle situazioni che il regista lituano racconta, mette insieme i tasselli di una felice creatività visionaria che cresce pian piano come la nebbia svanisce, ma poi è destinata a risorgere, germogliare come racconto che persiste nell’anima e negli occhi dello spettatore. In questo senso Il libro di Giobbe da un lato e la Vita di Galileo di Brecht dall’altro – entrambi gli spettacoli andati in scena all’Olimpico di Vicenza – raccontano di un’estetica, raccontano di una persistenza del maestro lituano nell’interrogare l’uomo, nell’indagare il suo rapporto con Dio, il suo spazio nel creato, demiurgo e fragile omuncolo al tempo stesso.
NICOLA ARRIGONI | «L’intero valore del teatro è che tutto quello che è stato creato scompare immediatamente. Come accade per la nebbia cresce, cresce e poi improvvisamente svanisce. Questo è il valore del teatro: la raccolta e poi l’improvviso svanire», così Eimuntas Nekrosius definisce il teatro e ovviamente il suo modo di fare teatro in cui tutto vive nell’immagine, nell’emozione impalpabile che simboli e racconto, parola e gesto, attore e pubblico vivono in quell’istante. Ma questo si può dire del teatro in genere, ma in Nekrosius assume quasi un valore esegetico, aiuta a vivere il susseguirsi delle situazioni che il regista lituano racconta, mette insieme i tasselli di una felice creatività visionaria che cresce pian piano come la nebbia svanisce, ma poi è destinata a risorgere, germogliare come racconto che persiste nell’anima e negli occhi dello spettatore. In questo senso Il libro di Giobbe da un lato e la Vita di Galileo di Brecht dall’altro – entrambi gli spettacoli andati in scena all’Olimpico di Vicenza – raccontano di un’estetica, raccontano di una persistenza del maestro lituano nell’interrogare l’uomo, nell’indagare il suo rapporto con Dio, il suo spazio nel creato, demiurgo e fragile omuncolo al tempo stesso. Questa esigenza si ravvede in primis nella storia di Giobbe, nel suo interrogare Dio e chiedere il perché di tanto dolore. Giobbe che piega, ripone in un cassetto, poi riprende e reindossa la sua giacca e lo fa con pazienza e ostinazione, la stessa determinazione che non l’ha indotto a maledire il suo Dio anche di fronte alla perdita delle sue ricchezze, dei figli e della salute del suo corpo, la stessa determinazione con cui vorrebbe che Dio gli spiegasse perché tanto dolore. E’ l’immagine che commuove: Dio ridà a Giobbe i suoi averi, una mela divisa in due da cui poi attinge la nuova progenie del saggio timorato di Dio e coloro che sempre hanno avuto in Giobbe un punto di riferimento. Così come accadde nel Cantico dei Cantici, così come è accaduto ne Il Paradiso di Dante, ma in fondo come capita sempre con Nekrosius, il racconto in scena è pensiero, è gesto che tutto comprende, è recitazione viva, pulsante, è danza dello spirito, è parola incarnata, è l’incontenibile che c’è nel simbolo, nei grandi simboli che più che dire suggeriscono. Nel Libro di Giobbe Eimuntas Nekrosius parte alla grande con Dio che potente racconta la storia di Giobbe e subito si ha l’impressione che la parola detta, il suo ripetersi possa equivalere ad una sorta di canto accompagnato da musiche variate di poco che dicono dell’interrogarsi sul dolore e sul senso della sofferenza di fronte ad un Dio inconoscibile e iroso, come è quello dell’Antico Testamento. Pochi elementi scenici: alcuni scranni, una scrivania che rappresenta forse il banco degli imputati, il tribunale che giudicherà Giobbe, un corsetto di lampadine che scottano come le piaghe sul corpo del vecchio Giobbe, ma che sono anche sigaretta, simbolo di pensiero.
Questa esigenza si ravvede in primis nella storia di Giobbe, nel suo interrogare Dio e chiedere il perché di tanto dolore. Giobbe che piega, ripone in un cassetto, poi riprende e reindossa la sua giacca e lo fa con pazienza e ostinazione, la stessa determinazione che non l’ha indotto a maledire il suo Dio anche di fronte alla perdita delle sue ricchezze, dei figli e della salute del suo corpo, la stessa determinazione con cui vorrebbe che Dio gli spiegasse perché tanto dolore. E’ l’immagine che commuove: Dio ridà a Giobbe i suoi averi, una mela divisa in due da cui poi attinge la nuova progenie del saggio timorato di Dio e coloro che sempre hanno avuto in Giobbe un punto di riferimento. Così come accadde nel Cantico dei Cantici, così come è accaduto ne Il Paradiso di Dante, ma in fondo come capita sempre con Nekrosius, il racconto in scena è pensiero, è gesto che tutto comprende, è recitazione viva, pulsante, è danza dello spirito, è parola incarnata, è l’incontenibile che c’è nel simbolo, nei grandi simboli che più che dire suggeriscono. Nel Libro di Giobbe Eimuntas Nekrosius parte alla grande con Dio che potente racconta la storia di Giobbe e subito si ha l’impressione che la parola detta, il suo ripetersi possa equivalere ad una sorta di canto accompagnato da musiche variate di poco che dicono dell’interrogarsi sul dolore e sul senso della sofferenza di fronte ad un Dio inconoscibile e iroso, come è quello dell’Antico Testamento. Pochi elementi scenici: alcuni scranni, una scrivania che rappresenta forse il banco degli imputati, il tribunale che giudicherà Giobbe, un corsetto di lampadine che scottano come le piaghe sul corpo del vecchio Giobbe, ma che sono anche sigaretta, simbolo di pensiero.