 MATTEO BRIGHENTI | La fantasia è una maschera di legno che canta. Si fa con le mani, il disegno, riscoprendo uno stare insieme arcaico, occhi aperti e testa sgombra. Nel Maggio drammatico l’Appennino tosco-emiliano celebra in ottava rima e in quartine di ottonari la primavera, cioè la sconfitta del gelo della morte. I Sacchi di Sabbia (www.sacchidisabbia.com) recuperano quella tradizione e la rileggono come somma esilarante delle differenze che ci rendono ugualmente sconfitti, oggi, dal gelo della vita. Piccoli suicidi in Ottava Rima – Volume I, presentato in anteprima nazionale al Teatro Studio di Scandicci (Firenze), frutto di una collaborazione tra Giovanni Guerrieri e Dario Marconcini, con la consulenza di Enrico Pelosini, Andrea Bacci ed Enrico Baschieri, è un musical a cappella, un match di recitazione vernacolare, un divertimento in quattro tempi veloce, pulito, leggero.
MATTEO BRIGHENTI | La fantasia è una maschera di legno che canta. Si fa con le mani, il disegno, riscoprendo uno stare insieme arcaico, occhi aperti e testa sgombra. Nel Maggio drammatico l’Appennino tosco-emiliano celebra in ottava rima e in quartine di ottonari la primavera, cioè la sconfitta del gelo della morte. I Sacchi di Sabbia (www.sacchidisabbia.com) recuperano quella tradizione e la rileggono come somma esilarante delle differenze che ci rendono ugualmente sconfitti, oggi, dal gelo della vita. Piccoli suicidi in Ottava Rima – Volume I, presentato in anteprima nazionale al Teatro Studio di Scandicci (Firenze), frutto di una collaborazione tra Giovanni Guerrieri e Dario Marconcini, con la consulenza di Enrico Pelosini, Andrea Bacci ed Enrico Baschieri, è un musical a cappella, un match di recitazione vernacolare, un divertimento in quattro tempi veloce, pulito, leggero.
Un quadrato di luce rossa, la musica degli stornelli, cinque sedie. Lo spazio che accoglie la nuova indagine sulla parodia di Guerrieri insieme a Giulia Gallo, Gabriele Carli, Giulia Solano, Enzo Illiano è l’alba di un tramonto strascicato. Gli attrezzi di scena e i semplici costumi sono in delle scatole ai piedi degli attori. Non c’è altra scenografia che il corpo e le sue voci. Seduti, poi in azione, su e giù, i Sacchi di Sabbia sono i pistoni del racconto di quattro “rievocazioni storiche” dell’immaginario cinematografico pop/olare: western, horror, commedia, fantascienza.
In Pat Garrett e Billy the Kid, dall’omonimo film di Sam Peckinpah, le ferite da arma da fuoco sono gocce di tintura su una camicia bianca. Billy non vuole morire, preferisce cantare mentre rovina a terra. Le pistole a salve dell’immaginazione sono cariche di pianto trattenuto. Le armi della finzione ti lasciano solo di fronte ai tuoi sogni realizzati. Il teatro non può rappresentare la morte, è finzione, serve unire le volontà di tutti per riuscirci. Fare comunità.
L’accettazione del gioco dei ruoli, della necessità di fare squadra, si fa avanti a passi rumorosi nell’episodio The Wolf, che stravolge il tema di Wolfman, pellicola di Joe Johnston. L’uomo, anche se trasformato in lupo, resta un poeta. Dedito alla bellezza. Uccide quando si riempie gli occhi di tre Cappuccetti rossi, la femminilità in un giro di spalle, un cestino di cartone e il sorriso idiota.
Questi Piccoli suicidi sono lenti di ingrandimento puntate sulle ovaie dell’impegno a non lasciarsi vivere. Che cos’è l’amore, da Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere, il Woody Allen del 1972, prende tre spermatozoi e li mette a godersi lo spettacolo del concepimento. Non c’è democrazia dentro l’utero, la Natura non è uguale per tutti, i forti vanno avanti, gli indecisi restano indietro, e lo spermatozoo riluttante fa la fine del cuscino sulla sedia. Schiacciato.
Il lavoro dei Sacchi di Sabbia è trasformazione, passaggio, confine, una maschera per incontrare gli altri dentro di sé e far divertire il pubblico. Nel quarto e ultimo suicidio, il più riuscito e divertente nella sua fulminea semplicità, L’invasione degli Ultracorpi, dall’omonimo film di Don Siegel, l’alieno che s’impossessa dell’umano è un sacco nero con gambe, braccia e testa. Sembra Grillo incappucciato che scappa alle domande dei giornalisti sulla spiaggia di fronte alla sua villa di Marina di Bibbona (Livorno). Non si capisce chi sia più alieno, se l’extraterrestre o il padrone di casa che lo accoglie in calzini e canottiera, anestetizzato da La gatta sul tetto che scotta su un minuscolo televisore, costruito con niente, come tutto lo spettacolo. Entrambi, comunque, spaesati, senza posto, fuori da questa realtà sorniona e incomprensibile.
Non possono farlo davvero così, con quella furbizia trasognata da start up in garage, eppure lo fanno, finché non ridi completamente, con tua bella sorpresa. Una ridda di impasse comiche che fanno di Piccoli suicidi in Ottava Rima – Volume I una canzone orecchiabile per sorrisi in cerca di respiro.




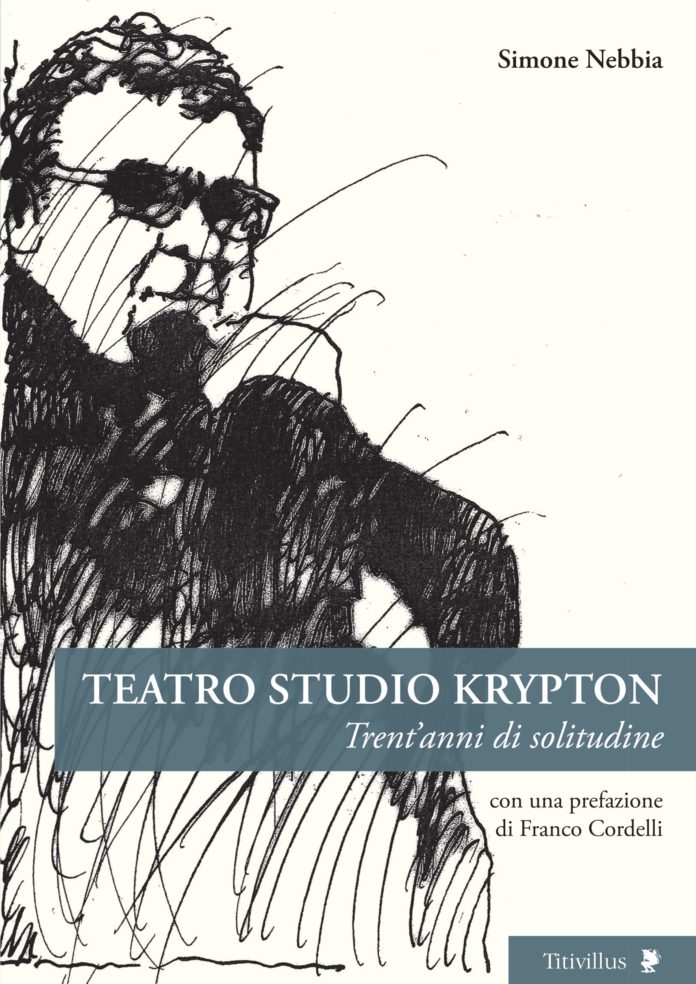
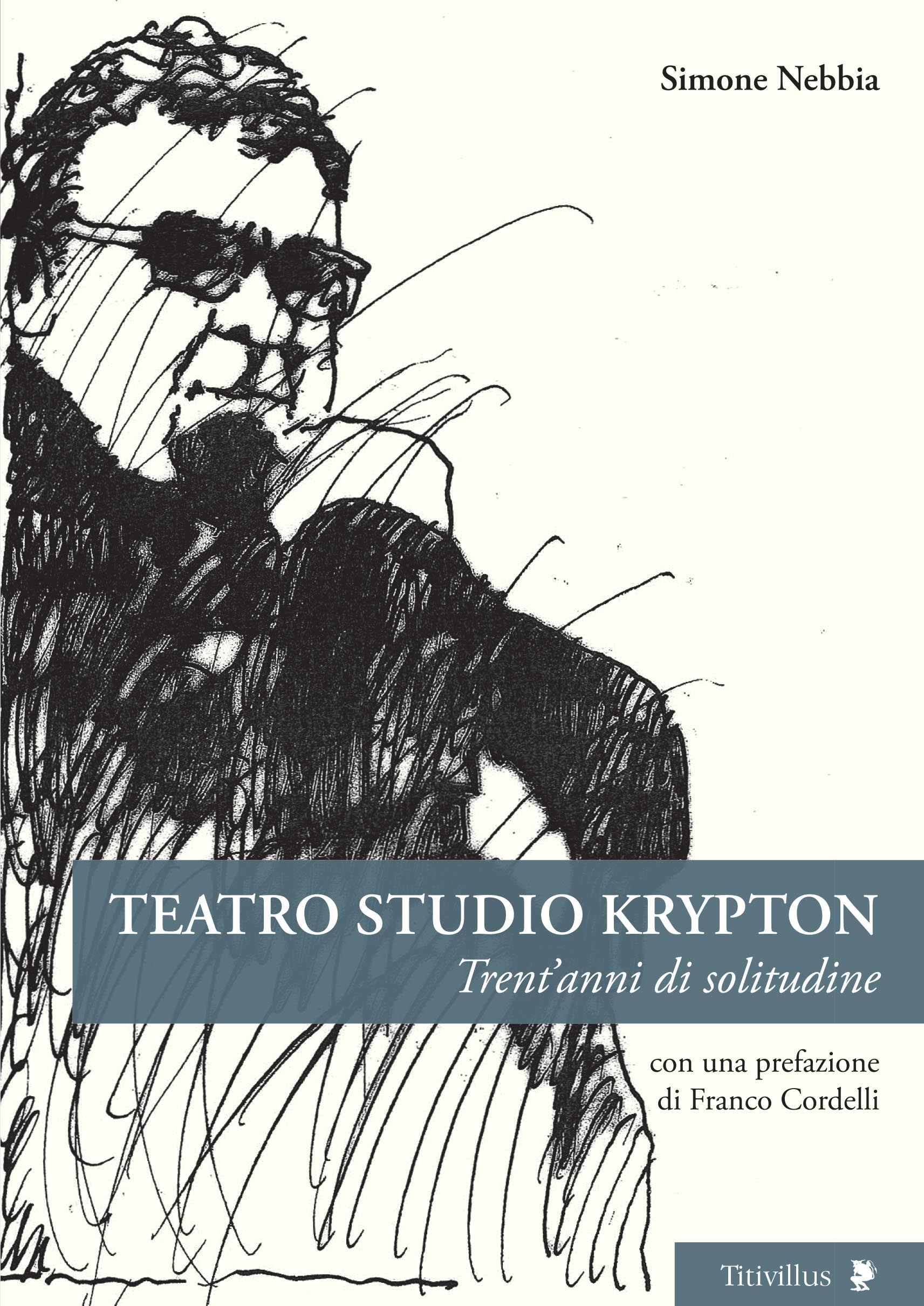




 NICOLA ARRIGONI | Uno spettro si aggira per i teatri italiani: l’Arlecchino bianco, larvale e demoniaco di
NICOLA ARRIGONI | Uno spettro si aggira per i teatri italiani: l’Arlecchino bianco, larvale e demoniaco di  VINCENZA DI VITA | Il video che segue è realizzato dagli studenti del Dipartimento di Scienze Cognitive e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina con i quali si è avviato un laboratorio di critica teatrale: Mirko D’Urso, Daniela Milici, Antonella Serra, Luisa Tabbì. L’intervista realizzata con il generoso contributo dell’artista Vincenzo Pirrotta che si è esibito con ‘N gnanzoù, opera prima dell’artista, regista, autore e attore.
VINCENZA DI VITA | Il video che segue è realizzato dagli studenti del Dipartimento di Scienze Cognitive e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Messina con i quali si è avviato un laboratorio di critica teatrale: Mirko D’Urso, Daniela Milici, Antonella Serra, Luisa Tabbì. L’intervista realizzata con il generoso contributo dell’artista Vincenzo Pirrotta che si è esibito con ‘N gnanzoù, opera prima dell’artista, regista, autore e attore.