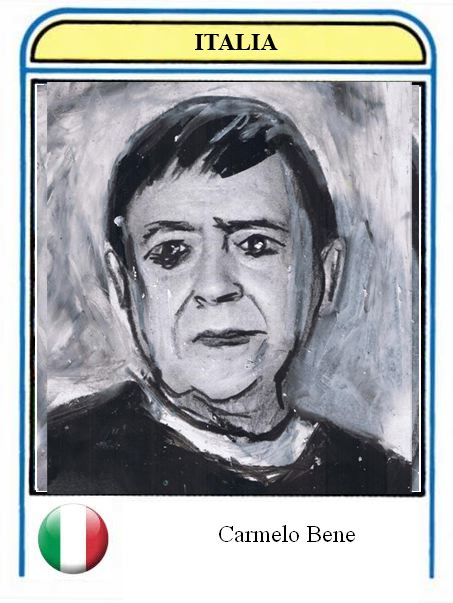
RENZO FRANCABANDERA | “Ebbene sì, in tutta onestà credo di poter dire che…” Beh, allora parliamone. Dopo undici anni, mentre si dibatte su quale sia davvero l’eredità, se c’è un’eredità da dividere, e soprattutto su chi (e se ci) sono gli eredi, per la neonata casa editrice FaLvision di Bari, è apparso a marzo un piccolo volume, “Figli di B.: ad una voce per il teatro”, antologia fra teatro, cinema e musica dedicata a Carmelo Bene. Ne è curatore Carlo Coppola, ricercatore dalla variegata formazione in ambito teatrale e cinematografico, che ha cercato di coniugare le intuizioni di chi si è formato nella pratica attoriale e drammaturgica guardando a Bene come fonte di ispirazione, con riflessioni maggiormente sistematiche. Autori della pubblicazione insieme a Coppola sono alcuni protagonisti del teatro italiano e non solo, per lo più giovani: Carlotta Vitale di Gommalaccateatro, Vincenza Di Vita, Mariano Dammacco, Roberto Latini, Giuseppe De Trizio e Pierluigi Ferrandini.
Coppola, cosa possiamo iniziare a togliere al mito di Carmelo Bene per vedere meglio vizi e virtù dell’artista?
Dipende da chi siamo e come intendiamo leggere l’opera di Carmelo Bene. Per molti aspetti, credo sia giusto continuare a mantenere vivo il mito e l’ “incomprensibilità di cui esso si nutre”, così che i perditempo si tengano alla larga. In generale credo che demitizzare sia un peccato gnoseologico quanto quello di mitizzare. Allo stesso tempo occorre puntare proprio i temi essenziali dell’esperienza beniana: la matrice salentina, il rapporto con l’Assoluto, con la Comunicazione e quello con la Morte debbano essere i punti di partenza. Il resto è pettegolezzo, lasciamolo alle servette.
In che cosa la redazione del suo libro l’ha aiutata in questo obiettivo e ci dica se ritiene di averlo raggiunto.
Figli di B.: è un tentativo di riunire una serie di “seguaci” di Bene. Artisti che in qualche modo si siano imbattuti in lui per ventura o per scelta. Amare Carmelo Bene, in vita e in morte non è cosa facile, bisogna essere disposti all’Assoluto, come rispondere ad una chiamata vocazionale. Si ci imbatte per caso in questo Monumento, magari si cerca di staccarsi da esso, ma a fatica. Questo libro in qualche modo è una sorta di antidotum, nasce dall’esperienza pratica di Artisti nel voler Proclamare e in qualche modo Stigmatizzare quanto di C.B. che c’è in loro. Anche per questo tale lavoro non può dirsi definitivo.
C’è del Bene più nel teatro contemporaneo o nell’arte e nei nuovi linguaggi? E che c’è di Male nel teatro e nell’arte contemporanea?
Come molti autori della nostra letteratura, Carmelo Bene non poteva pensare ad una eredità. In modo molto più ardito pensava alla clonazione, ma questa è un’altra storia. Ciò che persiste di lui sono schegge, temi, vocalizzi come di cantante lirico, o voli. Ognuno dei miei compagni di questa pubblicazione ha una diversa idea o un motivo proprio per appartenere all’ “Ordine dei Carmeliani”. Ma per rispondere più compiutamente rispondo con le sue parole dette d’Amleto: “Più tardi mi s’accuserà d’aver fatto scuola. Come sono solo! E quest’epoca non c’entra nemmeno un po’.”
 Si può parlare di Bene senza rischiare di annoiare o sembrare un po’ retrò? I personaggi totalizzanti ritiene possano essere misura del tempo presente o studiarli serve anche ad andare oltre? E se si cosa c’è oltre Bene?
Si può parlare di Bene senza rischiare di annoiare o sembrare un po’ retrò? I personaggi totalizzanti ritiene possano essere misura del tempo presente o studiarli serve anche ad andare oltre? E se si cosa c’è oltre Bene?
Personalmente rifuggo dall’idea totalizzante di esemplarità dell’arte, dalle balene rosse o bianche e dai pachidermi inattaccabili. Per questo studiare C.B. è un rischio anche per me. So che per alcuni è ostico, oltre che antipatico: ben pensanti, snob, per i radical chic, o semplicemente per chi si rifiuta. C.B. è la quintessenza dell’intellettualità meridionale, nella sua accezione più europea. È molto più vicino a Giordano Bruno, e G.B. Vico di quanto non lo sia Dario Fo o a B. Bertolucci, che pure stimava. Oltre Carmelo Bene c’è altra ricerca che parte o meno da lui. Egli ha né mostrata, negandone il pedagogismo, il resto tocca ai nostri contemporanei.
Quello che lei ha trovato nel suo libro è un Bene umano, troppo umano o disumano? E’ giusto che chi fa arte ambisca ad una vita del genere o la ritiene una ricetta estrema e pericolosa, e che solo rarissime eccezioni possono permettersi di indossare un abito come quello? In tal caso gli altri dovrebbero astenersi, in quanto fondamentalmente mediocri (come Bene spesso sottolineava) o esiste un giusto anelito dell’uomo a vivere una sua dimensione creativa sollevata dal giudizio?
Parlare di ritrovamento mi piace meno, e preferisco parlare di esiti di una ricerca e diciamo pure parziali. C.B. pare scherzasse sul suo cognome e sul non portare fiori alla mamma o alla zia per le feste comandate ribadendo lo slogan “Non Fiori ma opere di Bene”. Ho concepito questo volume come una testimonianza di affetto, per Lui morto e per coloro che gli sopravvivono, parenti, amanti, amici. Quanto alla mediocrità, di cui mi si chiede, di fronte al sua cultura enciclopedica e alla originalità della sua sua sintesi perfetta di arte e vita, chiunque è pressoché cieco, sordo e muto, storpio, oltre che stitico. Qualcuno lo è meno di altri, ed io, da curatore di un’antologia, ho puntato e scelto proprio questo qualcuno. Ho cercato di creare una sorta di Canone beniano, come anticamente si faceva nelle Accademie, e per vocazione tutti gli invitati anno risposto alla chiamata.
Bene era un genio? O una persona con una lancinante solitudine che ha chiamato poesia?
Ebbene sì, in tutta onestà credo di poter dire che Carmelo Bene fosse un genio, che avesse capito, come e più di altri che il teatro e l’arte, quindi la poesia, hanno a che fare con l’Assoluto, con il Sacro, non in senso religioso, ma in termini di Metafisica certamente. [Con Lorena Liberatore, l’anno scorso Coppola ha tracciato un profilo del Salento Metafisico di Carmelo Bene, sempre per l’editore FaLvision ndr] Il suo genio, a mio avviso, sta nell’aver colto in un modo lucido questa relazione trascendentale, un po’ come accade nel kathakali, forma espressiva di teatro-danza indiano. Per noi occidentali vedere il connubio tra Arte e Assoluto è difficile, ma Bene era pugliese e salentino, teso ad oriente per costituzione, forse anche per questo a lui era più chiaro. Per lo stesso motivo era famelico e bisognoso di affetto, come poche persone di cui io abbia sentito parlare.

 RENZO FRANCABANDERA | La ninfa undicenne arriva in monopattino da fondo scena, attraversando la sala illuminata da un faro, mentre l’adulta ha appena finito di elencare la “babilonica” tassonomia di punti di vista, pareri, voci di popolo sul personaggio di Lolita: dal chi non ne sa, al chi la vive nel suo immaginario; la bambina è nell’età di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dove alcuni gesti iniziano a vivere il crinale dell’equivoco, diventa oggetto (e soggetto?) di seduzione. Come le more addentate dallo spiedino, gesto innocente e capace di un potenziale di provocazione adulta di cui chi lo pone in essere (e non parliamo qui della giovane attrice ma di ogni ragazzina di quell’età) può o meno essere consapevole, tutto in quell’età diventa ambiguo. Il corpo cambia, porta i segni dell’età feconda della specie umana, che socialmente si sposta vicino ai 40 anni, ma nella dinamica sessuale inizia invece prestissimo. Sempre più, in un’iconografia di diari, lucchetti, post-it, sms, canzoni di x-factor, fra bambine-ragazze, che giocano con le bolle di sapone e indossano capi di abbigliamento che le trasformano in signorine, che vanno in palestra di karate e di colpo ti sembrano Uma Thurman in Kill Bill, pronte a combattere per la vita.
RENZO FRANCABANDERA | La ninfa undicenne arriva in monopattino da fondo scena, attraversando la sala illuminata da un faro, mentre l’adulta ha appena finito di elencare la “babilonica” tassonomia di punti di vista, pareri, voci di popolo sul personaggio di Lolita: dal chi non ne sa, al chi la vive nel suo immaginario; la bambina è nell’età di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, dove alcuni gesti iniziano a vivere il crinale dell’equivoco, diventa oggetto (e soggetto?) di seduzione. Come le more addentate dallo spiedino, gesto innocente e capace di un potenziale di provocazione adulta di cui chi lo pone in essere (e non parliamo qui della giovane attrice ma di ogni ragazzina di quell’età) può o meno essere consapevole, tutto in quell’età diventa ambiguo. Il corpo cambia, porta i segni dell’età feconda della specie umana, che socialmente si sposta vicino ai 40 anni, ma nella dinamica sessuale inizia invece prestissimo. Sempre più, in un’iconografia di diari, lucchetti, post-it, sms, canzoni di x-factor, fra bambine-ragazze, che giocano con le bolle di sapone e indossano capi di abbigliamento che le trasformano in signorine, che vanno in palestra di karate e di colpo ti sembrano Uma Thurman in Kill Bill, pronte a combattere per la vita.

 ALESSANDRO MASTANDREA | Una parabola davvero insolita, quella tracciata dalla carriera televisiva di Luca Telese. Tanto insolita da non poter essere inquadrata sotto la sola lente del giornalismo televisivo. E’ infatti grazie alle sue naturali doti istrioniche che, nel corso degli anni, ha potuto dar prova delle sue indubbie capacità di grande attore, spaziando con disinvoltura tra generi assai diversi: dalla commedia all’italiana, alla tragedia esistenziale, non disdegnando tuttavia le sponde più leggere tipiche della sit-com.
ALESSANDRO MASTANDREA | Una parabola davvero insolita, quella tracciata dalla carriera televisiva di Luca Telese. Tanto insolita da non poter essere inquadrata sotto la sola lente del giornalismo televisivo. E’ infatti grazie alle sue naturali doti istrioniche che, nel corso degli anni, ha potuto dar prova delle sue indubbie capacità di grande attore, spaziando con disinvoltura tra generi assai diversi: dalla commedia all’italiana, alla tragedia esistenziale, non disdegnando tuttavia le sponde più leggere tipiche della sit-com. GIULIA MURONI | “Che bello che animate questo posto! In questa piazza non si fa mai nulla. A parte le celebrazioni per la festa dei morti….” Ci fa venire un po’ i brividi l’affermazione della cordiale signora di Esterzili. La festa dei morti. Mi trovo a pensare che in fondo molti spettacoli non siano altro che cerimonie di morte. Coazioni a ripetere di maniera, senza vita, senza arte.
GIULIA MURONI | “Che bello che animate questo posto! In questa piazza non si fa mai nulla. A parte le celebrazioni per la festa dei morti….” Ci fa venire un po’ i brividi l’affermazione della cordiale signora di Esterzili. La festa dei morti. Mi trovo a pensare che in fondo molti spettacoli non siano altro che cerimonie di morte. Coazioni a ripetere di maniera, senza vita, senza arte. RENZO FRANCABANDERA | Fermo restando il fatto che il soggetto pubblico resta in forma determinante il baricentro decisionale e il fulcro per la promozione dell’attività culturale su un territorio, esistono sicuramente tentativi di azione e promozione che cercano di superare l’occasionalità dell’incontro estivo, sviluppando promozione ed educazione al sensibile sul territorio di più lungo termine.
RENZO FRANCABANDERA | Fermo restando il fatto che il soggetto pubblico resta in forma determinante il baricentro decisionale e il fulcro per la promozione dell’attività culturale su un territorio, esistono sicuramente tentativi di azione e promozione che cercano di superare l’occasionalità dell’incontro estivo, sviluppando promozione ed educazione al sensibile sul territorio di più lungo termine. RENZO FRANCABANDERA | Sempre maggiore è in me la convinzione che il nuovo ruolo del teatro e delle arti scenico-performative in generale, forme d’arte dal vivo per eccellenza, ormai superata la dimensione Otto e Novecentesca e i suoi portati ideologici dai contorni così definiti, si avvicini moltissimo a quello della filosofia, ovvero diventare un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull’uomo, indaga sul senso dell’essere e dell’esistenza umana e si prefigge inoltre il tentativo di studiare e definire la natura, le possibilità e i limiti della conoscenza, allorquando l’uomo, soddisfatte le immediate necessità materiali, cominci ad interrogarsi sulla sua esistenza e sul suo rapporto con il mondo.
RENZO FRANCABANDERA | Sempre maggiore è in me la convinzione che il nuovo ruolo del teatro e delle arti scenico-performative in generale, forme d’arte dal vivo per eccellenza, ormai superata la dimensione Otto e Novecentesca e i suoi portati ideologici dai contorni così definiti, si avvicini moltissimo a quello della filosofia, ovvero diventare un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull’uomo, indaga sul senso dell’essere e dell’esistenza umana e si prefigge inoltre il tentativo di studiare e definire la natura, le possibilità e i limiti della conoscenza, allorquando l’uomo, soddisfatte le immediate necessità materiali, cominci ad interrogarsi sulla sua esistenza e sul suo rapporto con il mondo. Alla seconda macro categoria, quella pratica e poietica apparterrebbero, in questo suddividere, i due spettacoli di Latella e Motus. Siamo consapevoli dell’azzardo argomentativo e vogliamo circostanziare l’argomento a questo momento e a queste proposte artistiche, visto che, come per la filosofia, anche per il teatro non può darsi una definizione ultimativa e specifica: ogni pensiero sul teatro include, infatti, al suo interno una ridefinizione del concetto di arti sceniche, e la riflessione generale stessa sulle arti muta per il contenuto sempre diverso del fare arte, che evolve con l’evolvere della società e delle abitudini del genere umano. Su questo riprendiamo per esemplificare quanto diceva Aristotele stesso: “È giusto anche chiamare la filosofia (philosophian) scienza della verità, poiché di quella teoretica è fine la verità, mentre di quella pratica è fine l’opera (ergon); se anche infatti i (filosofi) pratici indagano come stanno le cose, essi non considerano la causa per sé, ma in relazione a qualcosa ed ora”.
Alla seconda macro categoria, quella pratica e poietica apparterrebbero, in questo suddividere, i due spettacoli di Latella e Motus. Siamo consapevoli dell’azzardo argomentativo e vogliamo circostanziare l’argomento a questo momento e a queste proposte artistiche, visto che, come per la filosofia, anche per il teatro non può darsi una definizione ultimativa e specifica: ogni pensiero sul teatro include, infatti, al suo interno una ridefinizione del concetto di arti sceniche, e la riflessione generale stessa sulle arti muta per il contenuto sempre diverso del fare arte, che evolve con l’evolvere della società e delle abitudini del genere umano. Su questo riprendiamo per esemplificare quanto diceva Aristotele stesso: “È giusto anche chiamare la filosofia (philosophian) scienza della verità, poiché di quella teoretica è fine la verità, mentre di quella pratica è fine l’opera (ergon); se anche infatti i (filosofi) pratici indagano come stanno le cose, essi non considerano la causa per sé, ma in relazione a qualcosa ed ora”.
 ANTONELLA POLI | C’era una volta….Il fascino della favola di Cenerentola scritta nel 1697 da Charles Perrault e dai Fratelli Grimm perdura e rivive ancora oggi a conferma che antiche novelle possono ancora suscitare l’interesse dei più grandi coreografi e musicisti.
ANTONELLA POLI | C’era una volta….Il fascino della favola di Cenerentola scritta nel 1697 da Charles Perrault e dai Fratelli Grimm perdura e rivive ancora oggi a conferma che antiche novelle possono ancora suscitare l’interesse dei più grandi coreografi e musicisti. Ci sembra evidente che questa creazione acquisti per Malandain un significato particolare sentendosi qui infatti libero di mettere in scena ció che gli interessa di più da un punto di vista artistico : la purezza delle linee, la costruzione dei duo, la rappresentazione dei sentimenti. E ci riesce benissimo con grande padronanza e mostrando una profonda sensibilità grazie anche alle capacità degli artisti in scena e in particolare di Miyuki Kanei e Daniel Vizcajo, coppia che balla con grande leggerezza facendo sognare il pubblico. Da non dimenticare la scenografia che non cambia mai durante lo spettacolo: decine di scarpe da donna nere con tacchi alti e tutte uguali, sospese lungo fili che discendono dal soffitto del palcoscenico lungo le tre pareti del palcoscenico. Il loro effetto ottico é sorprendente dato che vedendole da lontano si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un volo di rondini.
Ci sembra evidente che questa creazione acquisti per Malandain un significato particolare sentendosi qui infatti libero di mettere in scena ció che gli interessa di più da un punto di vista artistico : la purezza delle linee, la costruzione dei duo, la rappresentazione dei sentimenti. E ci riesce benissimo con grande padronanza e mostrando una profonda sensibilità grazie anche alle capacità degli artisti in scena e in particolare di Miyuki Kanei e Daniel Vizcajo, coppia che balla con grande leggerezza facendo sognare il pubblico. Da non dimenticare la scenografia che non cambia mai durante lo spettacolo: decine di scarpe da donna nere con tacchi alti e tutte uguali, sospese lungo fili che discendono dal soffitto del palcoscenico lungo le tre pareti del palcoscenico. Il loro effetto ottico é sorprendente dato che vedendole da lontano si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un volo di rondini. ANDREA BALESTRI | OGGETTO: Pensieri su Pitecus, di Antonio Rezza
ANDREA BALESTRI | OGGETTO: Pensieri su Pitecus, di Antonio Rezza
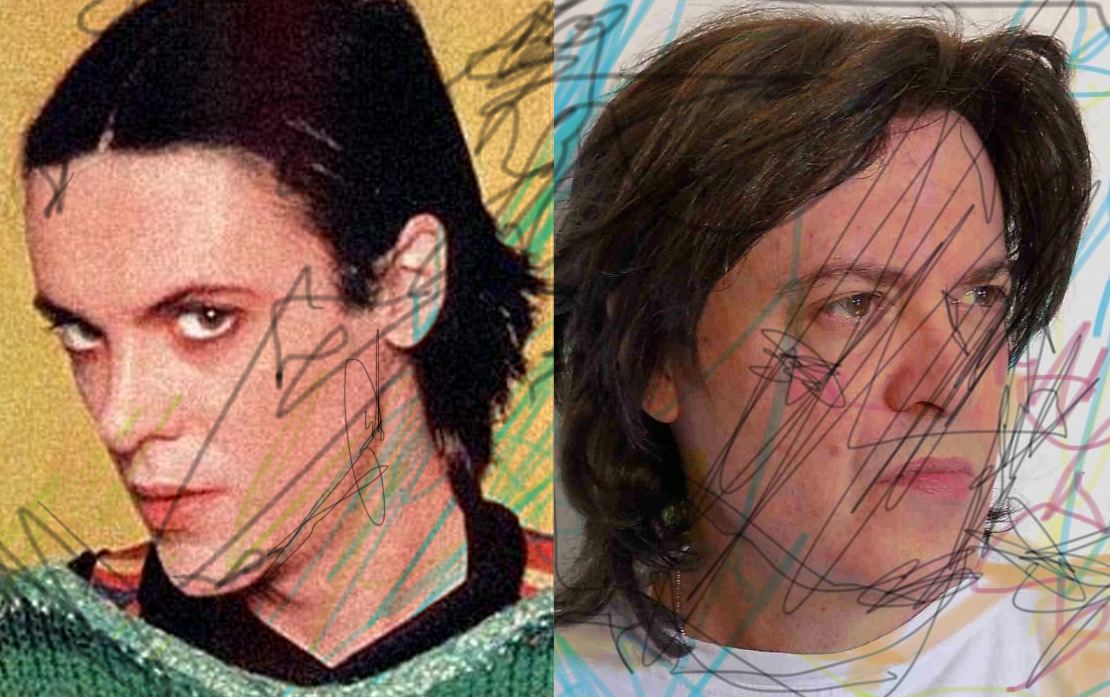 MARAT | Luglio 1982, Italia Mundial. Ci si abbraccia ai gol di Pablito Rossi. Il partigiano Pertini esulta in piedi davanti al mondo. E si balla. Grazie ad Alberto Camerini, Arlecchino dinoccolato, esploso l’anno prima con Rock’n’roll robot. È l’estate di Tanz bambolina, via di mezzo fra i Kraftwerk e i falò sulla spiaggia. Pare qualcosa di nuovo. In un paese quasi da bere, grasso di droghe, rigurgiti fascisti, Moncler. Ascesa e caduta di un genietto bruciatosi col fuoco. E con un Sanremo disperatissimo. Prima di tornare in forma. E vederlo a Ferragosto al Carroponte di Sesto. Che (non) si esce vivi dagli anni Ottanta.
MARAT | Luglio 1982, Italia Mundial. Ci si abbraccia ai gol di Pablito Rossi. Il partigiano Pertini esulta in piedi davanti al mondo. E si balla. Grazie ad Alberto Camerini, Arlecchino dinoccolato, esploso l’anno prima con Rock’n’roll robot. È l’estate di Tanz bambolina, via di mezzo fra i Kraftwerk e i falò sulla spiaggia. Pare qualcosa di nuovo. In un paese quasi da bere, grasso di droghe, rigurgiti fascisti, Moncler. Ascesa e caduta di un genietto bruciatosi col fuoco. E con un Sanremo disperatissimo. Prima di tornare in forma. E vederlo a Ferragosto al Carroponte di Sesto. Che (non) si esce vivi dagli anni Ottanta.